Le mie, le tue, erano spesso virtù ineguali,
lasciate all’estro che pescava dal profondo,
e di tanta oscurità il colore ne soffriva,
il voler essere cangiante era prigione:
parlavamo d’altro eppure eravamo incredibilmente prossimi e vicini,
chi s’intendeva di magie avrebbe conosciuto l’assonanza,
non noi, così aperti e chiusi,
non noi che donavamo senza risparmio e conto,
eppure di quella necessità d’essere riluceva l’assenza,
il grido acuto che non aveva parole,
non ancora,
o forse mai,
nell’occasione ripetevamo l’io, la necessità, il bisogno,
mentre da tutto il vero urgeva il noi,
l’allacciarsi nell’assoluto, e ancora il noi.
Archivi categoria: appunti
intercalare
Davvero
C’è sempre incredulità in un pensiero nuovo. Aria pulita, stupore, e la richiesta di una conferma che ci si rivolge. Si sospende per un attimo la corsa per raccogliere ciò è emerso improvviso e guardarsi attorno.
proviamo emozioni
La sorpresa si è sciolta, il passo è leggero. Quella sintesi che si è fatta strada ha mostrato un accesso al profondo, ma è stato un momento e ha lasciato solo un’ impressione. Come un tuffo nell’acqua che risveglia il corpo e gli dice: esisti.
più per paura
Ragionare per confronto, per differenza propria, perché senza presunzione, siamo differenti. Da noi, anzitutto. Da ciò che siamo stati e saremo. E il pensiero è la fotografia, sorprendentemente a fuoco, di un momento. Ricca di dettagli, fa uscire dalla velocità che appiattisce le cose, le sensazioni, i desideri. Esce dalla tirannia del presente e ci mostra un modo d’ essere che a volte perdura, ma quasi sempre si perde, dopo aver illuminato e affascinato. Questo è anche motivo dello scrivere: per contrastare un senso di perdita d’occasione alla quale è difficile abituarsi.
che per passione?
Nel mio giardino c’è un noce, da san Giovanni si raccoglievano i frutti per il nocino, altri frutti continuavano la loro crescita e poi cadevano senza essere raccolti. Tagliando l’erba, a primavera, vedevo piccole piante che a volte si facevano strada dalla corazza del frutto. Quella forza del crescere mi spiaceva fosse confusa tra gli steli, perché non erano erba ma alberi che volevano fruttificare. Era una foresta che voleva nascere da un solo albero. Si è chiuso il dubbio iniziale in un nocciolo duro che non ha soluzione; può però germogliare. Lo farà. A volte capita che generi una roccia, altre una ninfea, per questo bisogna camminare leggeri.
Davvero
proviamo emozioni
più per paura
che per passione?
![IMG_2915[1]](https://willyco.blog/wp-content/uploads/2015/01/img_29151.jpg?w=584)
numeri: l’11
Prende la tensione dell’uno verso il cielo, l’accostamento di coppia che è già intesa erotica, riscatta la banalità del 10, dopo la capriola del 9, ed è l’apertura di una modalità nuova, un impegno sinora sconosciuto nelle sequenze dell’unicità, il confronto con l’altro.
C’entra il palindromo? Non penso, anche perché la convenzione umana di numeri e date è una pallida prefigurazione del mistero delle coincidenze. Ma l’11 non coincide, s’affianca, si confronta e sovrappone, non si ripete, è individuo doppio: mancasse il respiro tra l’uno e l’altro perderebbe la qualità e si disperderebbe nell’unicità. Il palindromo però è un evocatore demoniaco.
Uno dice: in agguato c’è il palindromo, la lettura doppia. Non fidarti dell’evidenza, il palindromo si nasconde nei dettagli, si insinua nei pensieri e perde chi li pensa. Fuggi dal palindromo perché il palindromo è un gran fascinatore, e via dicendo. E’ il fascino della specularità senza specchio, il luogo dei gemelli, altro grande evocatore d’inquietudine e fascino che implica la ricerca della differenza presi dallo stupore dell’eguale che non si eguaglia. Insomma l’ 11 apre una serie che usa due volte il segno e pure essendo il più semplice tra i doppi apre una porta fantastica, ricca di fantasia che non risponde a regole, ma da destra o da sinistra inizierà la fantasia? Chi considera il calcio una rappresentazione pratica degli scacchi, non avrebbe dubbi: da sinistra. Là dove c’è il piede e il luogo del diavolo, la maglia di Mariolino Corso e di Gigi Riva, il genius loci imprevedibile che sovverte e vince.
non dare caramelle agli sconosciuti

Fuori il cielo è diventato color piombo. Ha anche la stessa consistenza. Solo le nubi verso occidente sfrangiano al giallo. A chi conosce un po’ di chimica qualitativa viene da sorridere perché i sali di piombo sono rivelati dal giallo e l’aranciato. Intanto cumuli nembi, incuranti delle spiegazioni sui colori, si sono caricati di lampi, e adesso tutto si sussegue con quel timore atavico che lega l’uomo alla folgore. Finita la festa di saette, alcune vicine, sarà la pioggia ad avvolgere strade e case.
Tutto consequenziale, prevedibile, si può essere persino grati del rumore sul tetto e del brontolio che s’allontana. Evidentemente, non c’è nulla da capire, basta sentire e vedere.
Nell’uso delle parole, ben più pericolose delle saette, c’è un senso che appartiene a chi le dice. Chi ascolta, non di rado, manifesta una prevedibilità che coincide col desiderio. Si vorrebbe finisse in un certo modo la frase, il racconto, oppure capire così tanto da coincidere con la testa di chi ha scritto. Ma questo è il caso migliore, perché la maggior parte ascolta o legge distrattamente: non vuole fare fatica. Per questo non si deve spiegare, evitare le glosse che peggiorano l’incomprensibilità. Pensate ai vostri anni scolastici o ai libri complicati, chi leggeva davvero le noiose note a piè di pagina, o peggio a fine volume, spesso più oscure del testo e soprattutto quando si leggeva, quell’andare avanti e indietro non peggiorava forse l’attenzione, rivelando i buchi e l’ignoranza pregressa?
C’era però un fatto piacevole in tutto ciò, l’attenzione sviava verso angoli inattesi, poco spieganti, ma interessanti e fecondi. Spesso emergeva l’idea che superata la fatica quei pensieri così freschi e nuovi sarebbero stati ripresi, che qualcosa di originale sarebbe nato da quello che si comprendeva più o meno. Non andava così, ma l’impressione che qualcosa di utile fosse nato dall’incomprensione restava.
Per questo bisogna accettare l’oscurità. Anche propria. Perché è feconda e perché le parole nel migliore dei casi sono imprecise. E poi non si vuole davvero dire tutto, ma ciò che conta è selezionare chi è curioso, e può diventare complice. Cioè talmente vicino da interagire con le nostre presunte oscurità.
E per questo penso sia meglio non dare caramelle agli sconosciuti, le masticherebbero, impazienti, chiedendone altre. Una caramella come una nube, non si spiega, ma che fine farebbe la dolcezza di ciò che davvero si vuole condividere?
a proposito di enigmi, meglio il primo o il secondo brano? 🙂
pozzanghera
selfie ϑεολογία
A volte guardando la stessa fotografia di sé, si riconosce un altro. E poi, in altra occasione, guardando la stessa fotografia, emerge ancora un’altra persona. Sono differenze di particolari. Chi ci ha visto e fotografato, chissà a cosa puntava. Voleva un sorriso oppure il pensiero che attraversava mente ed occhi? Voleva essere rassicurato, tenuto da conto, amato e ce lo chiedeva attraverso l’espessione, oppure si ingegnava di trovare la differenza, indagare su ciò che sino a quel momento non aveva notato chiaramente eppure sapeva esserci. Il lato oscuro, insomma.
Molto più facilmente, avrà fermato un attimo purchessia, e il contesto aveva lo stesso senso della nostra presenza: c’eravamo entrambi, c’era il sole o una pioggia battente, condividevamo, eravamo felici, il luogo era singolare, ecc. ecc.. L’immagine era già nata come un rafforzamento del ricordo, utile per i momenti meno luminosi, un lasciare e tenere traccia d’essere stati. Cosa e come, contava molto meno, questo in fondo, serve poi e lo si lascia alla più fallace e creativa delle facoltà, ovvero la memoria, ma è importante che essa agisca anche per prove. Perché le continuità di questo hanno bisogno, di prove, mentre le passioni, gli innamoramenti o le assenze esigono altro, della poesia, ad esempio, del non stato, del presumere, dell’assenza della verifica.
Comunque sia guardando la fotografia di me vedo un’aria ironica, lievemente sbarazzina, quasi incurante di ciò che sta attorno, come pregustassi una evoluzione. C’è un lampo negli occhi che può essere di ingenuità (il bimbo che emerge?) oppure di contentezza senza un motivo particolare che non sia la comprensione di star bene.
Rivedo la stessa fotografia, dopo parecchio tempo, è uscita da sola nell’immenso salva schermo che toglie dall’oblio il rumore del mondo che abbiamo fotografato. Vedo altri particolari. Mi riconosco vedendo altro di me. Mi studio, cosa chiaramente inutile perché nel vedersi davvero, funziona solo l’intuito e l’impressione. Dall’osservazione analitica emergono le difficoltà, i difetti d’immagine, la conformità alla maschera che è l’opinione di sé e si colgono le cose che non vanno, ma è superficie, cos’è che va invece ? Tolto il narcisismo, resta il comprendere ed è questo che si dovrebbe fare anche davanti allo specchio, nel selfie, che è sempre un messaggio a qualcuno: chi sono, cosa guardo, a cosa sto pensando e soprattutto chi vorrei essere che m’assomiglia?
attesa
- La vita germina nel segreto,
e nel mistero
si nutre di luce,
e generosamente la ridona.
un albero
Ti sei lasciato scavare, piano, con gli anni, da uccelli che inseguivano insetti,
insetti che volevano cibo e poi talpe, topi,
animali che correvano e lenti innamorati.
Questi ultimi toglievano un po’ di pelle, scrivevano date, promesse, tracciavano cuori.
Era corteccia, ma era pelle, respirava,
ricca d’amore, sensibile al vento e alla pioggia, si godeva il sole e l’ombra che arrivava nel giorno,
fino al fresco della notte.
Rabbrividiva, nel sentire una schiena che si posava,
e una parola incisa la faceva trasalire.
E in questo imparare, il corpo s’è curvato ad accogliere,
a tenere, aria, vita, acqua, amore.
Di questo essere, vorrei dar testimonianza,
del tuo accogliere,
ed essere storia d’abbracci, senz’altro dire.
Perché l’abbraccio è da solo una lingua,
una pazienza,
una forma dell’ amore.
ripensamenti
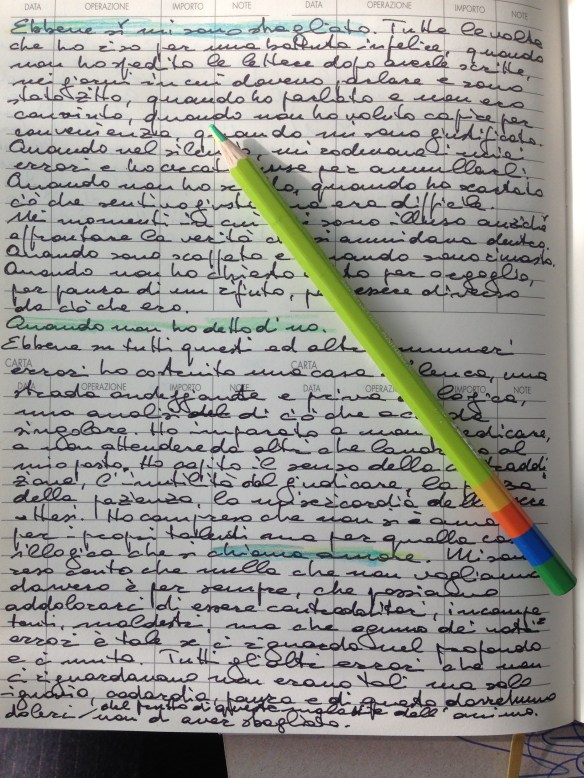
Avevo scritto un testo di getto. Parole che erano uscite a fiotti, dove era solo la meccanicità dello scrivere a far da argine, poi mi sono fermato e ho messo da parte. L’ho riletto stanotte, e l’ho trovato troppo proteso verso qualcosa. L’immagine era quella di uno sporgersi da un balcone cercando di toccare una mano. Nessuna pretesa di afferrare, di usare il verbo avere, ma la voglia di far sentire calore, come si usa nel silenzio e nel linguaggio delle mani che si cercano.
Però mi è sembrato eccessivo, troppo scoperto e nudo e allora ho tolto aggettivi, retrocesso pronomi, impastato i verbi di realtà, sfumati gli assoluti. ( Che poi così assoluti non erano, sembravano, al più, bricole di laguna a cui attaccare una barca, e mentre si riposa mangiando in compagnia, si guarda l’acqua che traccia linee nette, si ascolta il rumore che sciacqua e parla e muove per suo conto conchiglie e piccoli sassi e noi )
A furia di limare ne è venuta una forma tondeggiante. Poteva essere un sasso di fiume che si era rotolato così a lungo da bearsi della sua condizione, ma era pur sempre sasso. E se arriva in testa fa male, e se ci si cammina sopra fa un po’ barcollare, ma almeno non lacera la pelle pur facendo ben sentire la sua presenza. Non mi piaceva la compattezza del sasso e se guardavo il tutto da altra angolazione, il risultato poteva essere una bolla di sapone. Una grossa bolla come quelle che fanno gli artisti di strada, facendola uscire da un telaio e mandandola nell’aria. Piena di fascino e translucida di arcobaleni, precaria di futuro, però felice di un fallibile presente. Mi piaceva questa analogia e avrei voluto che le parole fossero così eteree da sollevarsi dal peso del dire, avere la libertà di scoppiare di significato, lasciando un ricordo fugace, qualche goccia controluce e una sensazione di inafferrabile bellezza.
Allora ho capito che non era rimasto nulla e mi sono sentito più leggero.
uggia
Oggi la giornata è particolarmente uggiosa, cielo grigio su, foglie gialle giù. E non sogno California.
Ma cos’è l’uggia che è uscita dalle parole usate e dalle possibilità reali delle vite di corsa? È una condizione umorale del flâneur, del rentier, del fannullone che oggi si chiama neet, oppure essa è scomparsa con l’età ed è stata riservata ai bambini, che corrucciano il labbro, diventano insofferenti e gridano : mi annoio!
Di cosa, di che?
Oblomov frequentava l’accidia, che è anch’essa scomparsa dai vizi, ma era comunque più attiva dell’uggia. Perché l’uggia è l’ombra degli alberi che ammalora le piante sottostanti. Cioè toglie loro la luce e la possibilità di crescere appieno, di godere della propria natura. Se poi l’uggia la portiamo nel sentire, essa diventa la noia che si accompagna ad una leggera inquietudine. Un non saper che fare accompagnato da un senso di incompiutezza. E quindi, forse, colpa. Ma è tutto leggero, può mutare se qualche sole si accende e ciò che non è concesso alle piante, il muoversi, a noi è dato, quindi per uscire dall’uggia è necessaria una luce. Quale essa sia ciascuno può scegliere. Un piacere momentaneo, un’attenzione improvvisa, un cercare nel sensibile oltre l’apparenza.
Non avendo ricette, mi tengo la parola e la scavo per coglierne l’essenza, vedo che essa mi riguarda quando il tempo dell’impegno si sospende, quando esso s’associa al mettere da parte e al tempo stesso attendere una soluzione che mi illumini. Devo mettere argine prima che questo sentire diventi molesto, cerchi colpe dove non ci sono. Abbandono le cose che non attraggono, non devo stare qui, esco e qui l’uggia aumenta. Sono le luci di natale che ormai invadono ovunque. Non è la luce che cerco, sento odore d’affari, di festa fasulla. Il kitsch è così sparso da suscitare repulsione. Capisco che l’uggia si dissolve e sta mutando in rivolta, non sopporto, ma neppure mi rintano. Sono costretto a cercare più a fondo. M’innamoro di un libro, lo apro tra l’odore di carta delle piccole librerie, e trovo :
se un giorno, all’improvviso,
un’anima ordinaria- per ragioni
imperscrutabili- si inceppa,
il canto di lode verso
il mondo più non sale.
Un malessere molle
e penetrante la invade –
corpo e sensi, una nausea
indefinibile l’assale.
…
(VIII- Franco Marcoaldi, Il mondo sia lodato )
Allora non sentendomi più solo, leggero, cerco il senso, non dell’andare, dell’essere, del fine, ma quello semplice dell’essere insieme purché anche in silenzio ci si parli. E per miracolo, l’uggia scompare e resta solo la parola.
https://www.youtube.com/watch?v=0peXnOnDgQ8

