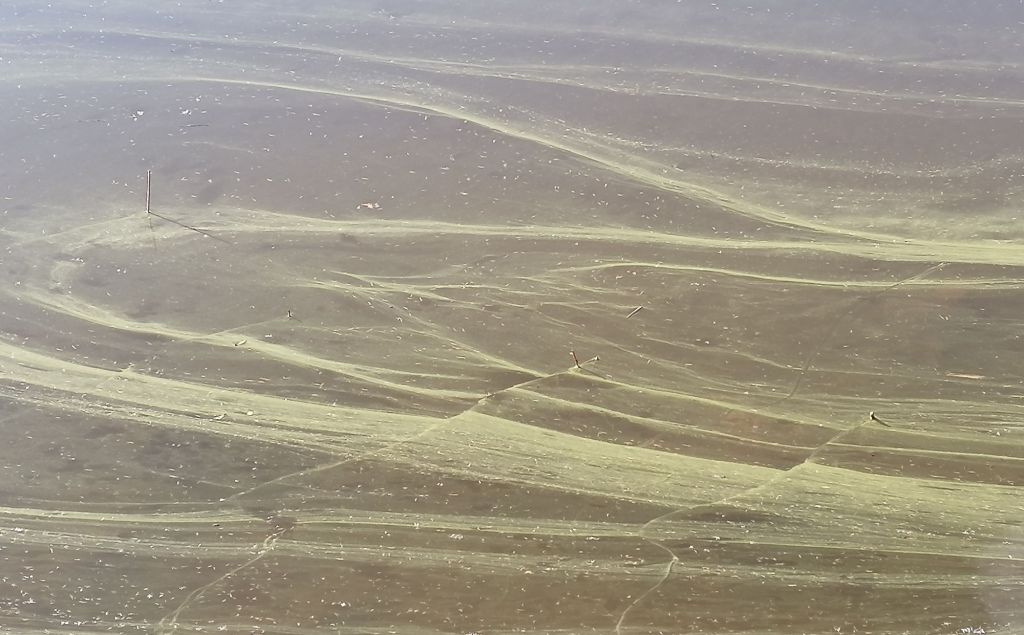Difficile e predittivo l’inizio, diceva la mia insegnante di lettere, poi il resto è opera d’artigiani del pensiero logico. Ed io facevo inizi folgoranti, salvo poi seguire le mie fantasie per pagine tortuose. E’ questione di pazienza, le dicevo, se si legge abbastanza magari non si coglie il senso dello svolgimento rispetto al tema, ma quello della testa, sì. ( Non mi pareva vi fosse eccessivo interesse per la mia testa). Mi consolavo, pensando che le migliori cose sono quelle fuori tema e visti gli insuccessi del folgorante, ero passato all’inizio ansante, quello che sembrava un cagnone accucciato un poco enfisematico, un inizio senza corsa, fatto di pennellate rapide, convulse, come se il passato fosse davvero già avvenuto, mentre chi scrive sa bene che il passato è davvero avvenuto solo quando lo si è scritto, prima è una sequenza di fatti, di fotogrammi con precario filo logico (il filo è sempre nel futuro, perché lì si capisce cos’ è accaduto davvero) e solo la logica delle parole può dargli un senso. Insomma io scrivevo storie che promettevano molto e poi menavano il can ansante per l’aia. Non mi capiva nessuno, neppure l’insegnante di lettere, che pure mi elargiva bei voti d’incoraggiamento e mi diceva, ma cosa volevi davvero dire? Io facevo il misterioso, alludevo, le parlavo della festa della sera prima e di quella della sera dopo, così lei capiva che ero festaiolo e un pochino m’invidiava, perché diceva, bella età, ma poi i nodi vengono al pettine.
Ecco questa dei nodi che vengono al pettine mi è sempre parsa una partenza fulminante, per niente scontata, perché per me era il pettine che veniva ai capelli. Faccenda questa dei nodi anche un tantino pericolosa, io avevo i capelli ricci e i nodi si scioglievano passandoci le dita aperte, ma forse si trattava di nodi più difficili e dolorosi rispetto ai miei. Cadevo nel dubbio, si avvicinava la fine della fatica scolastica e i nodi restavano. E se per caso fossi caduto nella configurazione topologica gordiana, la cosa sarebbe diventata critica, un qualsiasi Alessandro il grande(ne avevo più d’uno tra gli insegnanti) con un colpo di spada avrebbe sciolto il nodo, ma si sarebbe fermato a tempo? Ecco, queste cose mica le potevo spiegare alla mia insegnante di lettere, al massimo potevo dirle che i nodi non mi piaceva scioglierli e subire il rischio che ancora una volta lei non capisse nulla di quell’allievo che molto prometteva e nulla manteneva,
Fu allora che determinai che in ogni storia che si rispetti, anziché mettere in premessa ciò che poi sarebbe venuto, l’inizio sarebbe stato un parlar d’altro, e che il senso l’avrei criptato e nascosto tra le frasi del testo successivo. Pezzetti d’una storia che non finiva in un comporre chiuso, ma diveniva una sciarada che continuava a svolgere il suo senso.
Devo dire, sommessamente, per chi avesse capito l’andazzo linear circolare dello scrivere mio, che mica ne posseggo la soluzione, al massimo ne intuisco il divenire. Turing, genio assoluto e co-inventore con Newman di Colossus, la macchina per decrittare i codici che i tedeschi creavano con Enigma, mi avrebbe sputtanato in un attimo e m’avrebbe raccontato per filo e per segno la storia, quella che ancora non so come vada a finire. Ma la mia insegnante non era Turing, era bella e discuteva volentieri e forse per questo perdeva il filo del mio discorso.
Lei spiegava benissimo, molto e d’altro, ma chi m’affascinava era Gadda, chi volevo essere era Boccaccio, per via degli ormoni giovanili applicati alla letteratura, entrambi mi sembravano perfetti. Glielo dissi, lei mi rispose che c’erano altre sorprese nella letteratura. Non le credetti che al 78%, finché non scoprii Calvino. Lui non lo sapeva, ma alla stregua di Borges e della riscrittura del Don Chisciotte, la lezione di “una notte d’inverno un viaggiatore” io l’avevo già svolta, solo che non l’avevano capita.
Il segreto si nasconde nei dettagli, parimenti al buon diavolo, oppure nella pancia dove sembrano dormire le parole, e il rasoio di Occam serve a far la barba più che a scegliere, l’inizio è solo un inizio a cui se ne sovrappone un altro, così in sequenza perché se è vero che se si vuol sapere “dove vuole arrivare questo scemo” (Totò), ci sarà sempre uno che capisce e dice: “ma mi faccia il piacere” (idem).