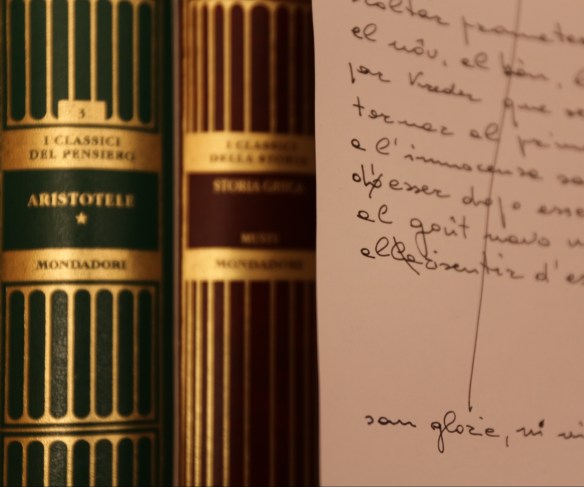Questa lettera, che qualcuno leggerà, fa parte del progetto di libro che sto scrivendo. e questa premessa comparirà solo questa volta. Da tempo sento che i miei interessi nello scrivere hanno bisogno di mutare e tra la carta e il blog c’è certamente un’altra via da capire e percorrere.
Si crede, e fa comodo crederlo ma non è vero, che il tradimento sia il perseguire un altro da sé, una sorta di perversione dell’io che violenta la propria natura per perseguire qualcosa che lo muta in peggio, mentre spesso, esso è il comporre il desiderio con una diversa concezione della vita che ci riguarda così tanto da essere alternativa a quella posseduta. Non sto per tessere un elogio del tradimento e neppure voglio negarne la valenza distruttiva, la tesi che vorrei discutere con te è che ci sia comunque una fuga nel tradimento e che chi tradisce stia cercando qualcosa che non trova nel suo vivere. In subordine, ma ne parleremo un’altra volta sostengo che la fuga sia una delle tre sostanziali condizioni in cui le vite si esprimono.
Ricerca e fuga spesso si sovrappongono, poi nell’essere interpretate risentono dalla natura e dall’educazione di chi le compie. Chi sfarfalla è differente dall’introspettivo, chi si pone domande e dubbi, è differente da chi si aggrappa a certezze immanenti e da queste trae giustificazione. Anche l’età pesa nelle scelte e quante volte il tradire è una fuga dalla responsabilità acquisita, l’illusorio ritorno a una condizione in cui il possibile non è così determinato e solido, e comunque molto viene perdonato. Con l’accumularsi degli anni le scelte si ossificano in percorsi che hanno canoni più sociali che personali: da una persona ci si aspetta che si comporti in un certo modo e solo quello comporta un giudizio positivo, un’approvazione sociale.
È il lemma tradire che fuorvia e che si dovrebbe applicare dopo aver conosciuto fatti e circostanze, invece è semplice usarlo e già contiene un giudizio inappellabile. Ma la considerazione sembra ormai restringersi ad ambiti più ristretti di un tempo, quello sentimentale e quello intellettuale, ad esempio. È scomparso il nemico della patria, così caro fino a quando ci sono state guerre e patrie definite, non c’è più il tradimento commerciale e sta impallidendo la proprietà intellettuale perché con i nuovi mezzi, copiare e rielaborare sembra diventato più facile che esprimere la propria originalità. Che ne dici, ad esempio, del continuo espungere citazioni da contesti, vantare associazioni di testi o altri pezzi di media che diventano un collage indistinguibile e che oltre a essere apparentemente nuovi tradiscono l’originale eclissandolo ad altro? Non parliamo della politica dove il cambio di casacca testimonia l’assenza di ideali e di progetti che non siano quello personale e ogni qualvolta sento dire che solo gli stupidi non cambiano mai idea penso che ancora una volta la citazione è tradita e usata per giustificare altro. Mi convinceva molto di più Berlinguer quando affermava che non aveva tradito gli ideali della giovinezza, e lo diceva pur leggendo un mondo che mutava, aveva cioè enucleato il sé che coincideva con l’identità e da questo non derogava perché non sarebbe stato più se stesso. Però se pensi alla scarsa consistenza e coerenza tra programmi e azione che oggi circola in ambito partitico allora capisci che non Lui, ma un’intera generazione ha derubricato gli ideali a parti negoziabili o semplici ubbie giovanili.
Insomma il tradimento sembra si sia ridotto a una questione sentimentale e a qualche giuramento con relativo impegno, o poco più, che ha rilevanza penale, ma il resto fa parte di altri ambiti che si sanano con facilità e non comportano particolari cambiamenti di vita. Il mutare azienda ad esempio, viene considerato un commercio lecito di competenza anche quando si portano appresso segreti industriali che è ben difficile arginare in un nuovo contesto. Pensa che quando dicevo di essere aziendalista, ovvero fedele all’azienda pubblica prima che a un mandato politico di un socio, venivo prima guardato con sospetto e poi messo da parte come inaffidabile. Eppure a me sembrava che questo fosse l’ambito del lecito e che l’illecito, ovvero il tradire, fosse nel fare qualcosa che potesse impedire la crescita o addirittura nuocere all’azienda in cui ero amministratore per acconsentire a una pressione politica.
Ma questo era solo un inciso personale, ti dicevo invece, che a mio avviso, il cosiddetto tradimento è in realtà assimilabile a una fuga verso un sé e che in questo contesto andrebbe analizzato. Quello che penso è che la condizione abituale in cui ci muoviamo sia quella tra l’immagine che l’individuo offre e quella che viene proposta come paradigma di felicità individuale. Il sentire sociale (e commerciale) vorrebbe che ci fosse coincidenza tra un ordine che garantisca la prevedibilità delle persone e la loro completa realizzazione con quanto dall’esterno viene loro offerto. Molte cose si fanno per comodità e non per convinzione, altrettante sono soggette a valutazioni di tipo economico/sociale e diventano difficili da mantenere, in quanto generano precarietà individuale o familiare. Anche dal punto di vista delle idee, la cosiddetta libertà è spesso ossequio a circuiti di convenienza in grado di determinare se una novità sia o meno “produttiva” e quindi accettabile. Non si spiegherebbe altrimenti il perché lo star system si applichi dall’arte sino ai modi di vita e si accetti supinamente il teorema della crescita infinita che non si cura di quanto lascia in termini di macerie e di vite piegate al profitto. In val di Susa chi protesta contro l’alta velocità ferroviaria viene considerato dal resto del Paese, fatta salva una minoranza militante, un ottuso che si oppone al progresso, che “tradisce” la crescita, mentre la stessa persona pensa di tradire il luogo in cui abita se permette che passi senza protesta una infrastruttura che violenta luoghi e modalità del vivere.
Ricordi quando andammo in Irpinia dopo il terremoto, ci raccontavano che dopo l’arrivo della Fiat a Grottaminarda, oltre a cambiare gli equilibri politici per le assunzioni, non c’era più un sarto che facesse un abito su misura o mettesse in ordine un vestito, mancava il fornaio, persino il barbiere era andato in fabbrica e per farsi i capelli bisognava prenotarlo, se ne aveva voglia, nei giorni di festa. Il tradimento del tessuto sociale lì c’era stato ed era stato mascherato da progresso, tanto che ora che la fabbrica è stata chiusa, mi chiedo cosa ne sia di quei luoghi rimasti senza capacità individuali e lavoro. L’ho visto ripetersi questo teorema, in molti luoghi in Italia, nelle cosiddette aree di sviluppo e lì il tradimento è stato collettivo, tanto che ora la spersonalizzazione è più forte e disperata. Il tradimento verso il sé implica un esercizio della libertà e un riconoscimento di ciò che si è. Non è cosa da poco, per questo mi spiace che la parola venga usata indifferentemente per chi si riconosce come non realizzato e cerca altro, e quindi fugge da una condizione di sofferenza cercandone una migliore, e con la stessa parola si definisca con molta meno frequenza chi viola, tradisce, principi individuali e collettivi. Insomma quello che volevo suggerirti è di non ridurre tutti a questioni facilmente risolvibili. L’apparenza inganna perché gli esempi che abbiamo sottomano portano all’individuo e ai suoi obblighi sociali, come se esso non esistesse come persona. Pensa a chi “tradisce” in un rapporto amoroso e fa la scelta di disfare un rapporto, un matrimonio. Se guardiamo i film o leggiamo i romanzi, l’amore sembra giustificare tutto. Quante eroine ed eroi vengono capiti, giustificati, suscitano approvazione e partecipazione, mentre nella vita comune verrebbero esecrati. Lo stesso vale in altri ambiti in cui la ricerca del sé è così evidente che la valutazione moralistica si ferma e guarda altrove. Non però nella vita comune dove il giudizio è più semplice della comprensione.
Credo si sia scelto di non investigare troppo su chi tradisce veramente e chi invece cerca la realizzazione di sé, mettendo tutto in una categoria sociale facilmente usabile, che consente di discriminare partendo dall’apparenza. Tu sai che non amo troppo chi si giustifica, mi pare più adeguato chi dice la verità, e questa può essere spiacevole, ma è la verità e allora si può capire. Non è necessario condividere, ma almeno capire che chi fugge non sempre è un vigliacco, che cercare di essere se stessi può risultare ben più complicato e doloroso che fingere. Quindi il tema che vorrei discutere con te è il tradimento come fuga verso sé, e quanto questo sia compatibile con le regole che la società ci fornisce, perché, e qui c’è una contraddizione, è la stessa società che predica la felicità individuale, a emanare regole che di fatto la rendono possibile solo se essa è conforme. Qui si apre un tema più largo e riguarda la libertà e la coercizione, ma questa era un’altra di quelle tre caratteristiche di cui ti parlavo. Ci sarà tempo per discuterne.