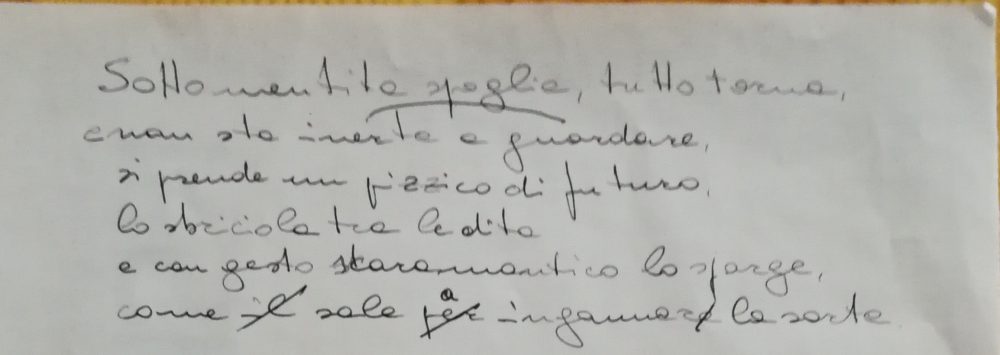Pubblicato su willyco.blog 3 novembre 2015
L’ auto s’inerpica nella sera, le curve si susseguono, i fari illuminano case spente o alberi fitti come palizzate. Gli alberi sono alti e giovani, due guerre hanno eliminato la storia dei boschi antichi e l’immensa distesa che riforniva la Serenissima di pennoni e fasciame per le galee. Per curve ripide, si sale, e il bosco circonda il sasso e l’asfalto, fino alla spianata dei cimiteri, dopo la strada prosegue senza più case. Fino in cima. Qui combatterono a lungo fanti che venivano da regioni lontane rispetto all’altopiano di Asiago. La brigata Liguria perse 2000 uomini in tre giorni, una carneficina, ma tenne l’urto della Strafexpedition. Qui erano loro a resistere e a Castelgomberto, la brigata Sassari. C’è una piccola cappella, che adesso i fari illuminano, poco oltre il cimitero inglese e quello italiano, con i caduti di entrambe le parti.
La strada adesso è più accidentata e ripida, c’è un silenzio che sospende la luce nell’aria, fino alla cima. Dove c’è oggi una malga e un allevamento di maiali, c’era il comando della brigata. La vista sull’altopiano è magnifica. È immerso nelle nubi, con i monti del Trentino a far da sfondo, e il chiarore del tramonto che scema rapidamente. Penso a ciò che vedevano quegli uomini nei pochi momenti di calma: attorno gli alberi spianati dalle artiglierie pesanti, ridotti a moncherini fumanti, le petraie e i prati che scendono a precipizio verso Cesuna.
Non c’è nessuno stasera, anche il finto rifugio illuminato, è vuoto. Torno fuori e guardo la distesa di nubi che scurisce, le prime piccole luci, i segni di vita delle strade. Il silenzio continua. Cosa sentivano i fanti, oltre gli scoppi, gli ordini concitati, i fischi dei projettili in arrivo ? E chi assaliva, gli Alpenkrieg tirolesi, cosa sentivano? L’epoca dei fatti è il maggio 1916, l’Italia non è ancora entrata in guerra con la Germania, il generale Cadorna, pur ripetutamente avvisato di una spedizione in preparazione da parte degli Austriaci, non dà peso alle informazioni dei disertori. Persino agli ufficiali nemici non crede. Poi dal 15 maggio si scatena l’inferno, al solito mancano gli ordini e una chiara visione della battaglia. Viene spesso ordinato di morire per carenza di seconde linee. Così nascono le leggende sul monte Cengio, il salto del granatiere, i suicidi dei volontari trentini o giuliani. Chi viene catturato farà la fine di Battisti e di Filzi. Se la spedizione austriaca riuscisse, sarebbe il disastro, presa Vicenza, poi Padova, Verona, Venezia. Gli austriaci avrebbero la pianura e la guerra vinta. In quei giorni l’altopiano viene evacuato, con la triste sorte degli esuli, portati distante, confinati e guardati con sospetto. Cimbri, todeschi, solo gente di confine, ma visti come possibili nemici: erano donne, adolescenti e bambini, più di 20.000. Agli altri, evacuati dagli austriaci, andò peggio, morirono in tantissimi, per fame, malattie, freddo. Si può morire di freddo dentro una baracca? Sì, soprattutto i bambini.
Nell’aria c’è il profumo dell’autunno: un po’ di fumo lontano, le foglie dei faggi che iniziano a marcire, la terra che esala vapori. È tutto così calmo. Gli animali tornano dal pascolo, lenti, i campanacci agitati nelle ultime brucate d’erba grassa, ma sono pochi, la transumanza c’è già stata, queste mucche e vitelli sverneranno qui. A fine giugno del ‘916, il 27, finì l’offensiva, le parti si trincerarono e cominciarono gli attacchi alla baionetta per pochi metri. Ci sono molti nomi che troviamo nelle nostre strade e che fino allora erano luoghi da pascolo e bosco, Ortigara, monte Cengio, Melette, ad esempio, luoghi di macelli insensati per pochi metri, guadagnati e persi per puntiglio. C’era chi non capiva, ed era la maggioranza, il perché di tanto uccidersi. Lussu ne ha parlato con una prosa sommessa e forte, senza epicità, e in molta letteratura di guerra vissuta questo non capire, emerge, poi ci sarà il mito della guerra santa propagandato da chi non l’aveva fatta.
Con una terra di nessuno breve, le trincee a tiro di voce e tanti morti, c’erano diserzioni dall’una e dall’altra parte. A questo penso e guardo la luce, che ora è un biancore rosato e segna alberi e cime con la precisione del nero, come volesse ritagliarli e poi ricostruirli su un tavolo: un gioco da bimbi prima di cena. Ma è solo bellezza e qui nessuno giocava.
Mi torna a mente un episodio di quei giorni. Qualcuno di una compagnia dell’89° fanteria, durante l’ennesimo, inutile assalto, pensa di consegnarsi durante un attacco. Di arrendersi, insomma. Il comandante del corpo d’armata, viene informato e fa bombardare la compagnia, che ancora combatte, uccidendo innocenti e disertori. Poi non sazio dell’esempio, da tutta la brigata Salerno fa estrarre due uomini per compagnia e li fa fucilare. Anche dai reparti che avevano combattuto con eroismo, anche da quelli che erano a riposo. Il comandante della brigata, che protesta, viene minacciato di essere fucilato entro 10 minuti se non procede con le esecuzioni. Alle 18, quest’ora, 48 innocenti vengono fucilati. Orrore nell’orrore.
Cosa avranno pensato, e capito, i fucilati e i loro compagni? Ci sarà stato trambusto, protesta, paura, pianti, un divincolarsi inutile, poi la catatonia di chi non capisce e il silenzio che precede le esecuzioni. Non ci si chiede mai cosa passi per la testa di chi è oggetto di un’ ingiustizia assoluta. Se esso pensi che tutta la sua vita sia stata inutile di fronte a ciò che subisce, se ciò che ha costruito, l’amore provato sia sbagliato per un mondo che non lo vuole. Avranno pensato che la nazione, lo Stato per cui tante volte hanno rischiato, per il quale hanno patito fame e paura, adesso disponeva di loro per capriccio, per dimostrare una forza cieca uguale a quella del nemico che uccideva in battaglia. Ma almeno il nemico non li chiamava per nome, gli lasciava una possibilità di difendersi, poteva anche solo ferirli, lo Stato, no, li uccideva e basta. Per dare esempio di una forza così bruta e ingiusta da non avere possibilità d’essere capita. Impossibile racchiuderla in una logica di vita, era solo morte.
Valeva allora e vale anche adesso questo pensiero che si oppone alla sofferenza delle vite che si sentono sconcluse, uccise due volte. Anche quelle che la sorte ha risparmiato, vengono uccise nel vedere la morte gratuita, l’ingiustizia perpetrata. Penso che se ci fosse una giustizia, questa dovrebbe emergere dall’analisi del suo contrario, dall’esame dell’arbitrio. Il disertore, il ribelle dovrebbe dire qualcosa e invece li si circonda di ignominia per non parlarne. Questi uomini furono esclusi dai monumenti ai caduti. Eroismo, paura, coraggio, scelta, in una ragione alta ci sta tutto perché l’uomo contiene tutto e qualcosa sempre tradisce.
Mio nonno morì l’anno dopo, in una dolina vicino al San Michele. Era agosto, erano i giorni del suo compleanno, era giovane e aveva moglie e due figli. Chissà cosa pensava dei tedeschi che di lì a poco avrebbero sfondato a Caporetto. Erano quelli che gli avevano dato agiatezza e lavoro, quando era emigrato. Parlava la loro lingua, ma era italiano. Era bastato questo per farlo rimpatriare e poi arruolare.
In questa sera, che ormai è notte, chi ha ragione è il silenzio. È un vuoto che non si può riempire. Non ragiona, afferma.
Credo che il sacrario siano queste nubi, questa luce, queste montagne, questi boschi che non appartengono a nessuno, eppure sono stati vissuti, riempiti di speranze, di desideri, di grida e dolore. Loro e il silenzio ci chiedono qualcosa: perché?
Queste righe volevo titolarle: decimazione. Poi ho pensato che la decimazione viene praticata non solo sui campi di battaglia, ma che è il non distinguere, è la cecità dell’esempio che non esemplifica. È solo forza con una ragione presunta e debole che non motiva chi resta, fa solo paura. Ho anche pensato che i generali non li decimano mai qualunque errore facciano e per quanti morti inutili ci siano. La decimazione sta intorno a noi, basta riconoscerla.http://https://www.youtube.com/watch?v=D9qUE0Baj8I