Vicolo cigolo è un procedere di case vive e morte. Allineate e ordinate nella fatiscenza o nel rifarsi dei fortunati che le hanno avute, stanno, immerse nell’aria annoiata dall’attesa. Mostrano finestre antiche e recenti, muri senza intonaco e spatolati. Finezze d’architetti, anticamere, ingressi tirati a lucido e porte murate. Una casa, apparentemente senza uscio, ha finestre con tendine in pizzo bianco. Segni d’una vita che accede altrove e guarda il vicolo. Come gli alberi che piegano i rami a guardare, superando le alte mura che occludono lo sguardo. Sembra di percorrere un pezzo di tempo che non ha ancora scelto dov’essere, eppure la grande piazza è l’accesso vicino. Là ci sono i mercati, il simbolo della città, le statue, gli spazi enormi e la corona dei palazzi, ma qui il secolo s’è appisolato in un meditare su ciò che verrà.Un ristorante ch’era famoso ha chiuso ormai molti anni fa, nessuno ha riaperto e la palestra che s’ è insediata in un altro edificio è discreta, ostenta il bianco d’un intonaco che le altre case non hanno, ma anch’essa si adatta. Ogni tanto gli abitanti protestano perché nelle molte feste del Prato questo pezzo di strada viene usato come vespasiano, hanno ragione ma la città ormai ignora che i bisogni umani hanno lati urgenti e poco redditizi da regolare pubblicamente. In compenso il suo essere vicolo, e stretto, l’ha sottratto alla sosta delle auto. E chi ha voglia di bighellonare lo deve percorrere apposta e sapere che c’è una fine che poi riporterà indietro. Sembra non ci sia nulla da vedere e invece è l’insieme che ha un suo borbottare, come un resistere a ciò che corre e che il nome evoca: un lento girare di ruota dove l’asse resiste e il mozzo non collabora. Un cigolare, per l’appunto.
Archivi categoria: mosaico
una tesi sulla decadenza
C’è uno stupore morboso con cui l’intelligenza contempla la decadenza e l’associa a categorie morali, così Berg è affascinato dal cammino di Lulu in quello che, per essere accettato dalla morale prevalente, deve aggettivare con il termine degrado. Il degrado morale come conformità all’ordine comune, all’appartenenza e soprattutto alla sessualità che rispetta canoni. Tra la felicità, il piacere e l’ordine la scelta è il terzo, se la prima è priva di regole, il piacere dev’essere anch’esso regolato. In questo consiste la superficie della morale, la crosta che sotto aspira ad altro. Alda Merini con l’aiuto di una follia temperata e quieta, nella poesie e nel comportamento, salda la felicità al contemplare se stessa, ne trova ragioni che non contraddicono, in questo c’è non poca parte dell’amore che la circonda oggi, non prima , quando era viva. Perché la follia, nelle sue accezioni di rottura dell’ordine non consente tutto. Ad esempio non consente la felicità come esibizione di tranquilla pienezza, dev’essere sguaiata, esibita, oscena per il suo imporsi come libera e assoluta, folle e priva cioè della regola che ne consente il controllo sociale. Nel fascino della decadenza si trova non solo il vecchio che non ha percorso pienamente la vita, non ha avuto, ma ogni persona regimentata e insoddisfatta, segretamente colpita dal fatto che ciò che sembrava assicurare felicità in realtà non abbia mantenuto la promessa. Così l’ordine esteriore ed interiore più che un modo di vivere che sia compimento di sé diviene abito che occulta e dissimula, viene favoleggiata un’innocenza innata che è prima della morale e quindi libera di essere, la si colloca in un tempo di cui non c’è ricordo ma dev’essere esistito. Finzioni dell’intelligenza e contraddizioni non ricomposte. Anche oggi che il decadere è fuori moda: non si decade più e nell’ esaltazione del giovanilismo come condizione permanente in cui tutto è permesso, non viene colto il nesso tra una condizione di ricerca della felicità e il suo materiale farsi. C’è sempre un giudizio morale che deve riportare l’ordine. La libertà sessuale così indagata in tanta morbosità pseudoscientifica da rotocalchi, dovrebbe rivelare un passaggio innanzi nella felicità e nell’appagamento, essere una felicità 4.0 e invece emerge una confusione, un disorientamento che fa oscillare tra giudizio morale e desiderio d’essere differenti. Non si evidenzia ciò che già nell’età precedente era il bivio in cui aspettava il demone: le vite scelgono tra la tranquillità e il rifiuto dell’eccesso di piacere oppure la libertà di essere, pena il decadere. Il resto è materia di follia e di corrosione e l’unico elemento nuovo, oltre al giovanilismo, è lo spostamento del limite della percezione, ossia possiamo includere più comportamenti evidenti nel catalogo della non decadenza. Il tema può sembrare astratto, ma le civiltà decadono a partire dai comportamenti collettivi e dalla loro relazione con la giustizia distributiva, ovvero se è l’individuo a prevalere e il suo essere felice non è tensione collettiva il tessuto si rompe, le persone perseguono secondo i loro mezzi il loro destino e non lo rendono partecipato. Subentra il privato, quello che Berg spia e Merini esibisce, ma così ognuno ha una felicità, un piacere e un evolvere, ciò che non viene accettato come comune diviene degrado o follia.
presbiopia
Le cose si sono ricomposte seguendo percorsi che stanno sotto la ragione. Fanno sempre così le cose, hanno una loro intelligenza che non insegna. E invece dovrebbero insegnare, diventare coscienza e prevedibilità possibile, non lasciarci spettatori di quello che pare il mare del caso e poi ficcandoci dentro ad esso.
Non sai nuotare, impara…Come servisse saper nuotare se non hai una direzione. Si resta a galla, ci si salva, ma il posto dove costruire non è il mare del caso, è la terra dove poggi i piedi, dove senti, vedi e prevedi.
Le cose si ricompongono, diventano leggibili, ma passa un sacco di tempo e si accumula dell’altro, che a volte c’entra e a volte è solo conseguenza, finché subentra un po’ di calma.
Si penserà, poi, con malinconica meraviglia, a come eravamo, ma avremmo preferito saperlo allora. Insomma nell’adesso, non ci si vede bene. Forse perché ciò che pare realtà non lo è mai davvero, salvo in momenti particolari e c’è bisogno di quiete che non hai, di distanza per vedere bene e non c’è.
Presbiopia. Era comunque diversa la realtà percepita da quella degli altri. Ciascuno ci aggiungeva di suo, ti mostrava qualcosa che sembrava attraente e si mescolava con te, e così le cose avevano punti di vista. Hai mai provato a farti raccontare una cosa che ricordi bene, che hai vissuto, da un altro che c’era? Ne viene fuori qualcosa di così differente che alla fine non cerchi i fatti ma le cose comuni. Ti sforzi per avere uno straccio di ricordo uguale e non è detto che tu ci riesca. Eppure le cose erano quelle e se le abbiamo vissute diversamente, certamente non si poteva dire allora. Ti avrebbero preso in giro: ma non vedi, ti avrebbero detto, è evidente… Dimostra tu che l’evidenza non è proprio così evidente e comune.
Forse era l’eccessiva fedeltà a sé che travisava. Le convinzioni costruite con fatica, i desideri spasmodici dell’età che mascheravano i bisogni, le notti insonni, i giorni attoniti, le parole eccessive come i silenzi e le offese. Le rabbie, l’incapacità di capire, la presunzione di sapere, la negazione o l’esasperazione dell’intuito, tutto gonfiato in una lente che avvicinava, selezionava, scartava, teneva da conto fatti, cose e sciocchezze marginali. E ora come si è ricombinato tutto questo nei ricordi?
Mah, se si vuole uscire da quella sensazione d’aver sbagliato troppo spesso un particolare che ha rovinato l’evolvere, bisogna leggere o sentirsi raccontare storie di passioni sconcluse da altri. Ascoltare. Lì c’è un confronto con qualcosa che pare d’aver vissuto anche se non è la stessa cosa. E non è la passione per i fallimenti che ridisegna i terreno dei fatti, delle cose accadute, ma la consapevolezza che altrove è accaduto qualcosa di analogo, un ricordo quasi comune che fa compagnia, che toglie l’onnipotenza, la preveggenza, la forza invincibile della volontà e ci consegna a un limite.
Noi siamo un limite, e quando lo capisci, è una cosa che improvvisamente sembra bella, perché non ti sei adagiato, hai continuato a sbagliare, di poco, di un nonnulla e le cose che già erano incastrate nel reale, non le hai perse. Estrai da un sacco il buono che si è composto per capire quello che si ricompone ora. Nel limite, hai fatto, hai portato avanti senza la vista a fuoco e se resta un dirsi nostalgico per l’età perduta, non è per i momenti mancati, perché capisci che ne verranno altri. E sbaglierai, di poco, ancora, perché è la possibilità che interessa non il percorso che non si è fatto e tantomeno quello che non si farà.
antico amico caro
Abbiamo passato notti a fantasticare su cosa ci sarebbe piaciuto essere e diventare. Essere, in quel momento, che pareva sempre incompleto, essere per riuscire a dar sfogo all’ immensa energia che serpeggiava e ribolliva. Essere, per trovarsi oltre l’ apparenza abbandonata in quelle lunghe chiacchierate. Parlando, comunicavamo davvero perché qualcosa diventava urgente, chiaro e possibile. E prima non lo era. Eravamo dentro la nostra determinazione di essere ossimori felici, grandi e ricchi di indecisioni e sfumature. Perduti in un presente e ansiosi di costruire il futuro, nostro e altrui. Quello era il diventare, il sogno ad occhi aperti che diventava urgente e plausibile. A volte mi tornano a mente quei ragionamenti, quella necessità di essere, ora e domani assieme. Si arrossava il viso, parlando, e la testa ribolliva, e ogni difficoltà sembrava sciogliersi, come cera che spandendosi, ravvivava la fiamma. Dicevo che avrei voluto fare il giornalista e lo scrittore e tu mi parlavi del tuo voler essere un chimico che costruiva nuovi materiali. Facevamo le stesse cose, studiavamo sugli stessi libri e le vite si realizzavano nel giorno ma anche nella prospettiva. Quanto rispetto e consapevolezza avevo per le tue doti, per la rapidità nel capire cose che mi costavano fatica e, credo, lo stesso facessi tu con la mia capacità di mettere assieme cose parallele e apparentemente scombinate. Mi chiedevi il nesso di un accostare ardito e discutevi, come io facevo per quanto riguardava un processo oppure una relazione acido/base al limite della comprensione. E quanto in una definizione di valenza, dalla materia e dai legami trasbordava in quel quotidiano che poco si capiva e in cui eravamo immersi. Chissà se i pesci si chiedono del mare e dei suoi flussi oppure se ne lasciano permeare e si formano in essi secondo natura e attitudine.
Attorno accadeva di tutto, ne eravamo partecipi e discutevamo: si sentiva, la necessità di capire cosa stava nascendo perché in esso saremmo diventati altro, ma non da soli, in tanti.
Eravamo una somma di desideri e di possibilità che, ci pareva, sarebbero stati la nostra generazione e il mondo. Sapersi generazione comportava una gran quantità di novità comuni, di desideri condivisi, cose da fare, idee da pensare, tanto che quei materiali a cui tu pensavi per me diventavano lo zucchero colorato delle sagre, estruso in lunghi bastoncini colorati. Dolce, fragile e continuo, questo era il futuro che nasceva da un presente fatto di parole, di entusiasmanti fatiche senza orari, di scoperte e necessità di raccontare ciò che accadeva per capirlo. Non è forse questa la comunicazione, il dire profondo che interagisce? Eravamo consci di non sapere, felici di scoprire, di avere sogni e un’ energia che correva l’un l’altro, dappertutto. E c’erano gli amori timidi e forti, le tristezze infinite e le gioie immotivate, c’erano le parole difficili da dire e quelle che uscivano incaute ed erano così enormi che poi ci si doveva abituare alla loro realtà. C’erano i sogni di una generazione colma di rivolta e di voglia di fare, c’era un noi che sperimentavano ovunque e ci pareva che solo così potesse essere.
Che ne abbiamo fatto del nostro diventare? Il tuo più determinato si è realizzato a suo modo, il mio ha trovato strade così tortuose che spesso mi ha fatto pensare d’ essermi smarrito. Certo, non ho realizzato il diventare di allora, ma il noi e l’ essere sono rimasti e con essi la voglia di cambiare. Mi chiedo quanto siamo stati utili alle nostre vite, alle nostre felicità, e quanto a quelle degli altri. Insomma quanto siamo cresciuti tutti assieme e quanto stiamo meglio. Allora sembrava naturale che i figli potessero avere più desideri dei padri, che ciò che a loro non era stato possibile, si potesse diversamente realizzare. E ognuno aggiungeva a sé, ma anche ad altri, il nuovo. Certo esistevano le stesse invidie , favoritismi, incapacità glorificate in immeritate posizioni. Ma ci faceva ribrezzo e non volevamo assomigliare a quel familismo che pensava al singolo, che toglieva e diventava ingiustizia da combattere. Eppure assieme al rivoltarsi c’erano attese semplici e conformismi, eravamo la coda staccata della lucertola del romanticismo. Forse era questa vitalità indomabile che spingeva a un diverso comune, al cambiare radicale che i padri non capivano, ma che non li eliminava del tutto e non lo sapevano. Nessuno uccideva i padri e però mettevamo assieme la mediocrità e il sublime che sempre accompagna gli uomini con quel noi che c’è ogni crescita comune, gloriosa di piccole cose e cambiamento. Oggi ho l’ impressione di un noi frantumato, di una Magna carta fatta coriandoli e gettata al vento. Cos’ è rimasto di tutto questo? E senza voler invadere chi è venuto dopo, c’è ancora la smania di capire dove siamo, in quale mare nuotiamo ed esiste ancora, la più grande cosa, che oltre all’ amicizia, ci siamo scambiati allora: vogliamo ancora capire il mondo per quanto possibile e diventare in esso, magari, a volte, felici?
piccoli segni
Piccoli segni. Il crepitare delle foglie troppo secche, un fruscio nel lavandino che preannuncia lo scivolare del piatto tra l’acqua saponata, L’orologio funziona come crede facendo le stesse cose. Dilatazioni e restringimenti d’anime di cose. Potrebbe essere la stagione che sciorina ottobrate senza pudore oppure il rumore di un bacio dietro l’angolo. Pulviscolo danzante nell’aria. Sole basso e rosso, che illumina foglie denudate dalla folla sui rami. Poche e meravigliose di connessioni sottili, di nervature che irradiano da una spina dorsale, poi il picciolo, già quasi legno e il ramo che s’aggrinza di strati verso un cuore tenero. Pensano al volo.
Nel bussare sui vetri la luce ha un fare sommesso e deciso, come avesse da fare altro se rifiutata. Lontano, lo so, dispongono e spingono persone dai pensieri antichi e bambini, ad accoglierla. Ma non è troppo lontano, è appena fuori le mura, nei giardini e sotto i portici. Ieri una signora ha levato il capo e sul ponte dove cadde la città e s’innalzò una tirannia, ha visto la luce danzare sull’acqua. Ti è tirata ritta sul carrettino della spesa e ha additato le scie delle anatre tra le case immerse nell’acqua: c’era un brillio di creste arrotondate, un segnare che si ricomponeva, ma intanto frangeva i riflessi e l’oro diventava verde e poi ancora oro. Bello, e immane come la natura, ha detto. Ed è rimasta a guardare verso la torre granda. Verso ovest, dove il sole racconta il meriggio e la realtà pensa d’ adagiarsi nel sogno. Attorno, s’è formata una piccola coda di attenzioni che cercavano di rubare l’attimo con un telefonino. Le scie si erano ricomposte ed ora, dietro a loro, ciottoli antichi rilucevano per attimi prima di ritornare color del ferro. Ma non le vedevano.
Il sangue ha il sapore del ferro, lo sapevi? ha detto uno dei due bambini che hanno proseguito parlando verso qualcosa che non s’intuiva. Liberi, come il pulviscolo, che parla felice e racconta, mentre attorno s’affollano piccoli segni.
con fusione
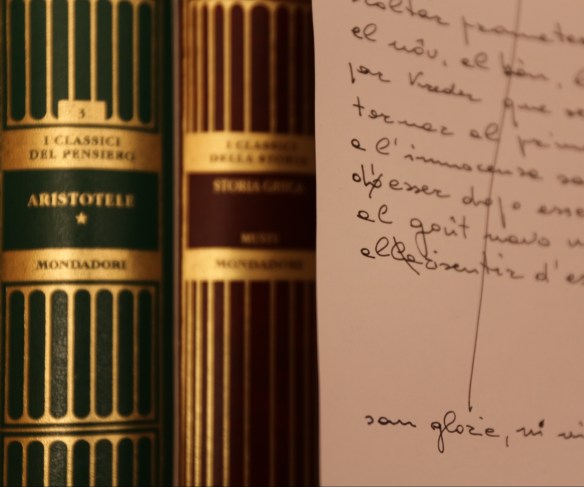
Le parole sono liquidi insufficienti, si plasmano all’interno di contenitori oppure si spandono. Dilagano inghiottite da tutti i ricettacoli che le portano altrove. E si sporcano. Possono essere gettate in avanti, in faccia, trattenute, le parole. Possono essere comprese in silenzi, espresse dalle mani, dagli occhi, dal muoversi del corpo. Quando esse diventano segno, attribuiamo loro un compito immane, ovvero quello di suscitare emozioni, trasmettere concetti, essere verità. In quel momento diventano parziali, insufficienti e reticenti, quasi sempre falsificanti. Non sempre accade, però le parole e i segni prendono la mano. Si deve finire un discorso, la sintassi ha una sua condizione costrittiva, i lemmi a disposizione hanno più significati che verranno corretti e precisati da ciò che precede e segue. E l’intuizione fa i conti con la verità della forma, sottrae energia alla sostanza per descrivere, suscitare, convincere. Un bacio è molto più esplicito e coinvolgente del dirlo, ma se devo descrivere un bacio, se voglio virtualmente darlo, o c’è un patto del silenzio tra chi lo riceve con me, un sentire così comune che non ha bisogno di parole, oppure devo circostanziare. Per questo i baci bisognerebbe darli più spesso di quanto si raccontino. E così la tenerezza, l’amore, il bene. E lo stesso vale per le parti oscure delle emozioni, per la collera, il disprezzo, l’indignazione, l’ira. Ma mentre il sentire e l’intuito sono emendabili e transitori, le parole restano, scavano, diventano atemporali. Riferiscono di un momento o di un tempo in cui avevano quella forza che si è tentato di descrivere, ed è il loro ossificarsi, diventare sasso. La parola scritta non fa eccezione e solo il vorticare, la marea del dire, diluisce il liquido, ne toglie il profumo. Come a dire che a parlare e scrivere poco, non molti riescono e se dicono una verità nel suo farsi ed evolvere, allora bisognerebbe ascoltarli con attenzione, perché sotto ogni parola, ogni gesto, ce ne saranno altri mille contenuti e pronti ad essere dati. E il con fondere diviene un fondersi assieme.
inventario

oznor
Di trame di foglie radiografate dal sole, di vuoti e pieni di terra, di reti misteriose e sotterranee, di Karl Kraus e dei suoi detti e contradetti, di mescolanza tra blut und boden che infetta e fa morire, di rigurgiti di razze inesistenti, di sovranismi e identità coagulate in squadre di calcio, di molto io e poco noi, di buddisti inventati e di cristiani ateizzati, di atei convinti e di spiritualisti increduli, di evidenze tragiche, di democrazie tronfie, di prassi prigioniere, di libertà inenarrabili, di desideri sconclusi, di sublimazioni per mancato coraggio, di adattamenti per impotenza, di porcherie evidenti e di sottaciute convenienze, di cinismi di comodo, di spiriti stanchi, di pillole per non vedere e non sentire, di foto di mici, di cani, di cose, di umani consenzienti, di privacy presunte e di nudità esibite, di dolori apparenti, di sofferenze nascoste, di indifferenze protratte, di redenzioni egoiste, di erotismi inventati, di amori accennati, di silenzi pieni di parole, di parole piene di silenzi, di ricerche del sé dove non c’è nessuno, di solitudini volute e di speranze infangate, di bandiere che hanno significato e ora non più, di principi che appartenevano a molti cuori, di stagioni della politica, di stagioni che non ci sono più, di un mondo che si sfalda, di braccia ribelli che lo tengono assieme, di estati e di sole sulla pelle, di età, di nudità vere e pudori presunti, di notti agitate, tranquille, rigirate, sognanti, sognate, di giorni senza capo, di code senza notti, di voglie imprecise, di insofferenze vicine, di sentimenti ragionati, di scelte dovute, di attese tranquille, ansiose, disperate, di viltà proiettate, di tensioni sbagliate, di verità cercate, di verità possedute, di verità esibite, di colpe subite, di innocenze presunte, di omissioni ripetute, di riconoscimenti sbagliati, di felicità trattenute, dilaganti e traboccate, di parole senza senso apparente, di tempi coincisi, di sorrisi immotivati, di anticipazioni posticipate, di intuiti inascoltati, di voglia di non fare, di cerchi che non si chiudono, di rapporti geometrici, di politiche del meno peggio, di soluzioni che non risolvono, di politica necessaria, di politica respingente, di noi annegati nello stagno dell’io, di singolarità conculcate, di calamità naturali provocate dall’uomo, di generosità senza motivo, di misericordie negate, di persone isolate, di invisibili creati, di poveri impoveriti, di ricchi sfondati, di dignità calpestate, di ridicole gioventù protratte, di responsabilità negate, di folle che non hanno un luogo, di luoghi che non sono una meta e di molto altro. Perché non finisce, no, non finisce.
incerta la fredda stagione
Intanto dissemina foglie e piccoli rami,
ma è incerta la fredda stagione.
Aggiunge lane sui corpi,
aggrega a crocchi sotto le luci,
in disparte, ma poco, una coppia si bacia,
stringe e non basta,
cerca, si ferma, indecisa,
poi s’allontana nella fretta d’un pensiero che cresce,
mentre attorno scosciano voci, accenni di canto:
colpisce il ricordo, si esalta il colore della sera,
e nel cuore si conficcano parole
che vorrebbero ascolto mentre si fanno tra labbra
sono fruscio di foglie che ondeggiano,
e cadendo poi mulinano in vortici
nell’ irrisolto ancora tiepido vento.
l’anima è un muscolo?
Chissà se l’anima è un muscolo ed ha anch’essa le sue contratture, il bisogno d’essere curata per non zoppicare.
Chissà se l’anima è un muscolo che ha palestre sconosciute e solitarie, che pratica attrezzi quali l’introspezione e il discernere, ma anche la misericordia e il raziocinio.
Chissà se l’anima è un muscolo che si distende per abbracciare tutto ciò che gli occhi possono contenere e il cuore sentire, ma anche rifiuta ciò che non le appartiene. Si divincola e respinge e quando è costretta, intristendo deperisce.
Chissà se l’anima è muscolo che a volte trova il pudore di stendersi e finire tranquillamente una lettura che ha mosso pensieri, provocato emozioni, cambiato quello che pareva.
Chissà se l’anima è un muscolo che capisce attraverso il suo sangue che scorre e dove prima c’era il sonno della certezza, lascia che ora viva il piacere d’una nuova percezione.
Chissà se l’anima è un muscolo e quello che a volte mostra è la dolenzia che chiede aiuto. Nasconde la sua fatica e magari confonde le acque, fa la spavalda mentre vorrebbe farsi compatire.
E quando sembrerà additare e sorridere, magari è un artificio, una scorciatoia che si trasformerà in altro che sempre vorrebbe essere compreso.
Allora se l’anima è un muscolo, chissà quante volte si chiederà se può scrivere mi piace a un’altra anima che dice la sua pena.
il diritto a una storia
Quattro mesi fa, per il mio compleanno, ho raccolto una serie di scritti che avevo pubblicato su questo blog e ne ho fatto un libretto, senza velleità letterarie, da regalare agli amici. Era un riassumere impressioni e ricordi, neppure i più rilevanti, ma quelli che avevano a che fare con alcune parti della mia storia. Bisogna insistere su questa parola: storia perché vita spesso si riempie di connotazioni esterne, quasi un subire ciò che accade anziché esserne protagonista. Per mia fortuna ho conosciuto non poche persone portatrici coscienti della propria storia e non occorreva andare a chissà quali celebrità, anzi, erano persone singolari che sceglievano e conducevano una storia che assomigliasse a loro. Per quanto possibile. Non accade così a tutti in amore, ad esempio, dove le scelte diventano futuro, dove ci si radica dentro per decidere e alla fine quello che ne esce coinvolge non poco le vite. Quindi il creare la propria storia è di tutti e la scelta è tra il lasciarsi decidere da altri oppure procedere in proprio. Questo conta poco per la felicità, per il successo, ma un merito ce l’ha, ovvero quello di avere una storia. Riflettevo su questo dopo aver legato un commento a quanto scrivo con un pensare alla mia storia. Il commento, riferito a quel libretto, parlava di una malinconia soffusa. Poi i termini si attenuano, la malinconia può diventare gentile, pensierosa, contorta, leggera. Insomma gli aggettivi rifuggono dagli ossimori che invece esprimono bene le dualità che possediamo e che il mondo esterno tende a semplificare. Mi sono chiesto, ma la mia, seppure aggettivata, è una storia malinconica? È il dis farsi delle cose che prevale? Oppure il senso dell’incompiutezza che impedisce di accogliere il momento? E in questo analizzare sono giunto a una conclusione che ha tutti i pregi del dubbio: la mia storia è fatta di momenti malinconici e di scelte dovute, di allegrie inconsulte e di gioie meritate, di errori madornali e di intuizioni felici, di permanenze fortissime e di oblii misericordiosi. E potrei continuare parlando della ricerca della leggerezza, della fortuna della memoria, dell’intuizione e dell’analisi di quanto si vede in uno sguardo largo. Potrei dire delle insoddisfazioni e dei fallimenti, ma questo offuscherebbe il molto che mi è stato dato, le esperienze scelte, le radicalità e le mediazioni costruite. Insomma ne verrebbe fuori una storia parziale, questa sì immeritata. Quindi rassicuro me stesso: la mia storia non è malinconica, ha l’allegria e l’ironia che l’accompagna, cerca la felicità anche quando si rende conto che essa è transitoria e difficile, persegue la leggerezza e l’inutile mentre si dà da fare con la concretezza e la dura lezione del reale. Nessuno di noi, penso, si merita una storia parziale, ha la propria. E in qualsiasi momento di quel lasso di tempo in cui siamo senzienti, e che chiamiamo vita, può decidere, fare, prendere una strada anziché un’altra, sapendo che può costruire qualcosa che nessun altro potrà fare e che lo riguarda così da vicino che è meglio gli assomigli. Ecco, questa è la propria storia e in fondo possiede tutti gli aggettivi e non merita giudizi, ma solo allegra consapevolezza d’aver vissuto e voler vivere.



