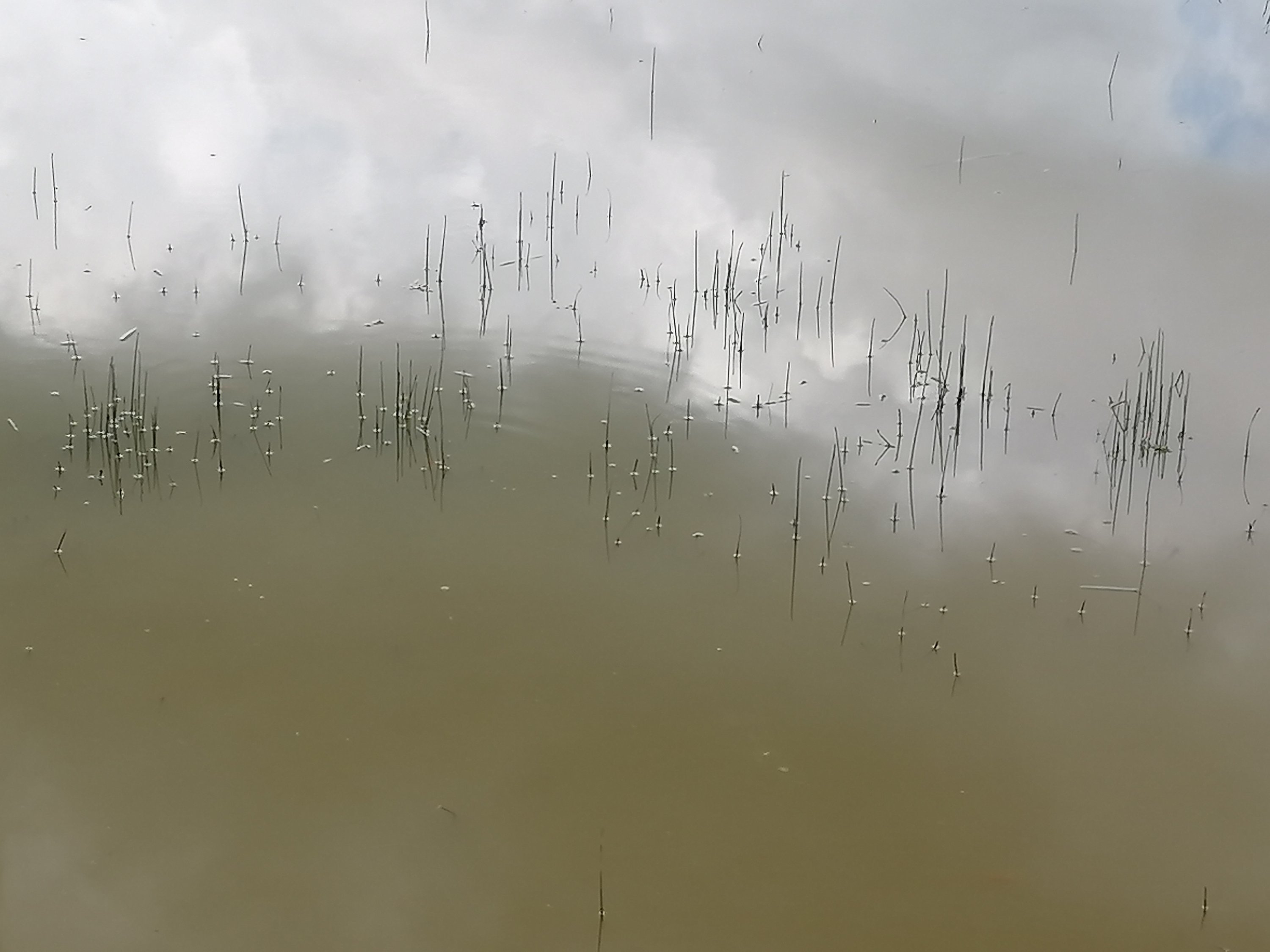Oggi è piovuto due volte. Fa fresco e si annuncia il ripensare che ha sempre con sé l’autunno. Credo che le stagioni abbiano una memoria, un lento divenire che si sfrange e poi si sminuzza piano piano partendo dalle evidenze, da quelle che si considerano le caratteristiche di una parte dell’anno, sino al loro essere profondo di mutazione, di noi, della terra, delle specie che ci attorniano. La continuità porta con sé una memoria che feconda, che rende dolci i passaggi e logiche le variazioni. Ci aspettiamo tempeste e giorni di quiete, freddo impetuoso che sfumerà nel sole, magari debole ma rassicurante di vita. Ci attendiamo passioni e un procedere sicuro come fa la prima nave del convoglio quando rompe la banchisa e traccia una via d’uscita. Una rotta, un futuro che si alimenta di presente, che tiene da conto il passato e scorge la continuità d’un cammino, d’un infinito succedersi di pensieri che s’annodano, di vite che si toccano e si tengono per mano. Per un tratto, per un tempo che continua e non finisce.
Archivi categoria: divagazioni
ci sono cose che non finisco
Ci sono cose che non finisco. Ce ne sono altre che non finiscono. Proseguono per loro conto. A volte si fermano e penso siano già avanti e non le trovo nel luogo dove dovrebbero essere, poi mi raggiungono ed è una felicità inattesa. Ci sono storie che finiscono troppo presto e sono colme di cose sbocconcellatte, ma mai gustate a fondo. Peccato, se c’era una ragione poi non è bastata.
Ci sono cose che neppure iniziano, non è colpa del caso. C’è sempre un motivo che qualcuno ritiene valido, eppure erano una possibilità, un corso della storia, ma non iniziano o si spengono subito. Oppure si mettono troppi vincoli e così si scorano e rinunciano. Peccato.
Ci deve essere un posto dove si raccolgono le storie e ciascuna parla di ciò che è stato, di com’era chi le ha vissute, oppure racconta, con malinconia ciò che poteva essere e si è smarrito.
Si, ci deve essere un luogo dove i trucioli delle vite si raccolgono assieme e riformano colori, usando vecchie matite, mine mal temperate mostrano che ci sono le storie, le cose e le umanità. E di ciò si consolano o sono felici di aver vissuto, di essere state una possibilità, di aver trovato chi le ha colte e amate.
I conti che non si chiudono
Il fornello di questa pipa in ceramica ha almeno 90 anni, tedesco per acquisto, forse di fattura Olandese per la sua essenzialità. Ha superato il novecento. E di questo vorrei dire un pensiero che da qualche giorno cova, mentre fumo guardando il tramonto: si è chiuso un secolo senza in realtà chiuderlo. Breve o lungo, pieno di cambiamenti, per chi ha la mia età molto ha contato e molte speranze ha generato. È stato il secolo che ha chiuso con alcuni assiomi, che pensavamo tali, con le ideologie ad esempio, e non ha lesinato i problemi a chi c’era e a chi è venuto dopo. Un secolo lento nel capire e nell’elaborare, è stato un secolo che ha dissolto e costruito. Questo passaggio, e chiusura che non c’è stata, era in realtà un fare i conti con il romanticismo e con gli ideali che hanno dato senso alle vite che volevano un mondo radicalmente migliore. Era questa la realtà che avremmo voluto? In particolare ora che la memoria difficilmente può essere condivisa e che ci consegna ad una solitudine che nasce dalla difficoltà di trasmettere speranza, valori, centralità del condividerli, capacità di costruire assieme. Lo penso per la polis e per la politica, ma anche, e soprattutto, per le nuove sfide nell’essere umano. Gli uomini ora sono più liberi, sembra, anche se la tecnologia è al servizio di un potere che orienta e ottunde le libertà. In realtà sono più soli e privi di bussola. Non c’è vento per il marinaio che non sa dove andare e che deve costruire nuovi portolani. Però ora, come mai, il futuro è nelle mani degli uomini di buona volontà, gli eterni sconfitti dalla furbizia, dal quotidiano. I facitori di futuro che non hanno paura di essere uomini e di dominare, non più la natura ma la paura del nuovo. Ad essi i nuovi anni e per quanto conta, a chi ha memoria, l’ obbligo di ricordare che il bello, ciò che ci salva, è opera del singolo e del gruppo, della condivisione e della generosità. Il resto è poca cosa, che lascia rovine, che non si chiude, ma transita e non lascia traccia.
l’amore al tempo del covid
Come muta il tempo e come resta uguale. Traggo auspici da pensieri che ricorrono e capisco che i ricordi sono una moneta con due facce. Una consola e racconta d’aver vissuto, l’altra è un sovrapporsi di esperienze dove ciascuna precisa e modifica le precedenti. La seconda, pur aperta indica una strada con molte soste e poca luce. Come accadeva nelle mie passeggiate notturne quando il comune abbassa le luci e le ombre diventano morbide e solide, allora sembra si sussurri nell’aria che è tempo di tornare. Abbiamo i ricordi e le cose. Ci sono quelli bravi che si liberano di tutto e ricominciano indefinitamente la vita oppure, maniaci dell’ordine, mettono a posto il poco conservato cercando di far collimare il nitore esterno con la necessità di un equilibrio interiore. Tu di che specie sei? A cosa appartieni e cosa ti appartiene che ti identifica e accompagna? Non serve una risposta se essa non è una liason d’âme, perché solo questa consola, parla oltre le parole. Ho capito che non serve, non basta scrivere, scandagliare dentro, cercare di capire. Anche comprendere la radice dell’inquietudine non basta perché ci sarà sempre una condizione che ci farà vedere chi e cosa siamo se qualcuno ha voglia di guardarci. E allora si scopre ciò che è fuori posto, quello che è sfuggito dall’apparire, perché di questo si tratta nel mostrarsi, nell’essere in ordine per gli altri mentre poco o nulla si rivela della lotta interiore. Com’è l’amore al tempo del Covid, quali artifizi usa per celare le proprie paure e come esso unisce o divide? In questa ansia di normalità accettiamo che ciò he è mutato sia tale senza una ragione che lo certifichi e neppure immaginiamo cosa occorrerebbe mutare davvero perché anche l’amore fosse adeguato al bisogno che ne abbiamo, non solo noi, ma il mondo. Vecchi vestiti frusti e dignitosi non bastano a rendere onore a un passato che non insegna e a un futuro che non apprende. Sono un anello di una catena che non lega (al più potrebbe farlo con me ma non avrebbe alcun senso, prigioniero di chi?) e che riassume storie, sensazioni, ricostruzioni difficili e che ormai sono muta narrazione oppure lampi, frames di un manoscritto sdrucito e disperso per mancanza di cura. Per questo ancora l’amore mi interessa, perché vedo in esso la linea di una umanità di singoli che evolve e sia esso virtuale, fisico, sperato, consumato, la sua storia racconta la necessità minuta e il grande bisogno collettivo. L’amore al tempo del covid sembra uguale mentre è radice che si fa strada in noi. La terra è la roccia impongono fatica e regole ma non sono impenetrabili, solo che bisognerebbe (pessima parola che si attribuisce alla necessità di far luce nelle nostre vite attraverso quelle altrui) capire sino in fondo perché non l’ordine delle cose, ma noi ci pieghiamo. Perché non inizia una nuova esaltante stagione in cui l’amore personale ha valore collettivo e così muta la società, il mondo ne viene risanato e la speranza sconfigge il buio. L’amore al tempo del covid è l’occasione offerta all’amore precedente perché esso sia un moto di cambiamento, una nuova stagione di pensiero e azione, lo scandaglio di nuove felicità in cui non arenarsi. A chi ha la propria casa interiore in disordine, l’occasione dell’innocenza e del nuovo che finalmente diradi la confusione in cui l’umanità sembra immersa. Una confusione che non produce pensiero forte, che s’accontenta di abitudini e toglie significato alle parole che dovrebbero mostrare la nostra essenza e la gioia del progredire. Per questo, penso, siamo – e sono- afoni oppure pieni di luoghi comuni. Soli e disordinati mentre mettiamo a posto l’ennesimo oggetto che si ostina a trovare una posizione diversa mentre in realtà interpella il nostro amore. L’amore al tempo del covid è analisi multivariata, che ha soluzioni diverse, è fluido con moto lamellare che ancora non ha trovato la sua strada ma sa dove andare e con chi farlo, è tempo senza orologio, possibilità felice, volo di uccelli che sente la stagione, cuore che non ha timore e se vede che la confusione è somma sotto il cielo, allunga la mano e sente quelle dita che assieme alle sue mutano il futuro.
andare o fuggire
Andare è un atto pacifico, un trascorrere dove il tempo e il moto si confondono sfuggendo alle leggi della meccanica classica. Il tempo dell’andare è un compagno che non si esaurisce se non dopo un percorso e poi si riforma per tornare a scorrere. Nel frattempo lo scorrere si è mutato in un vivere tra gli altri e osservare, aprire la mente, scardinare le abitudini.
Fuggire è lo stato che segue la misura colma per preservare l’integrità o almeno ciò che conta in essa. Non si può fuggire da se stessi, ma si può attutire, deviare l’attenzione, sollevare, e questo lo si raggiunge con il nuovo, lo stupore dell’inusitato, la rottura delle abitudini circolari. Il tempo lotta, sottrae possibilità, fuggire è ricaricarsi. Cercare un’altra possibilità dell’essere se stessi, dopo aver compreso il limite proprio e quello altrui.
Andare e fuggire, disseminare la strada di ciò che non necessita, che non aiuta a star bene. Benessere e andare, in una dimensione nuova per misura e limite. Oltre la delusione e il fallimento c’è il non provato che attende o il buio della tenebra, la scelta è nel trovare un fotone di luce, di speranza che appicchi il fuoco e cominci nuovamente il trascorrere.
Se conosco la direzione posso mutarla, 90° bastano per scoprire cosa stia sfuggendo accanto e quanto di tutto questo non abbia consapevolezza, nozione e scelta.
È la scelta l’ elemento basilare del tempo e del suo scorrere. Il senso dell’andare. Si può essere felici, sereni, in equilibrio o meno, sono possibilità che solo il restar fermi ci nega. Nel ripetere c’è la sicurezza di quel che accadrà e la scontentezza del non approssimarsi a ciò che si è o si potrebbe essere. Questa è la radice dell’inquietudine, dell’essere sfocati e fuori posto e per questo, inconscia o meno, l’intelligenza innata del crescere, spinge ad andare. Non occorre sapere dove e verso cosa, ma andare salva ciò che vuole vivere.
a che serve l’astrolabio? un mantra per il mobile procedere
Sostanzialmente abbiamo bisogno di sapere dove siamo e che giorno é. Per questo ci occorre non il nostro orologio interiore ma quello esterno, fatto di stelle fisse e di orizzonte, di latitudine e di altezza del sole.
αστήρ “astèr” (“astro”) e dal verbo greco λαμβάνω “lambàno” (“prendere, afferrare”).
Ma anche se ti pare di sapere dove sei, ti senti nell’ingranaggio, in quel tutto che comprende anche il suo contrario, l’anima, l’assenza, lo spaesamento. Sono quelle bolle del sistema che lo stesso tollera per autogiustificarsi, senza le quali l’illusione di scelta cadrebbe.
Chiediti allora, a che serve l’astrolabio, se sei tu che sei tornato a casa.
le mie estati erano spinose
Le mie piccole estati erano spinose con punte che si conficcavano ovunque, anche se prediligevano mani e piedi. La sera, mia madre arroventava uno spillo sul fornello e poi estraeva le spine. Avevo prima imparato a non piangere e tanto meno ad aver paura e poi a farlo da solo. Mi sembrava una prova di coraggio ma anche un governare me stesso in ciò che facevo. Andavamo a un mare semidisabitato, ricco di colonie, di case di suore e preti e di ospedali per cure elioterapiche. La casa era in spiaggia ma il mare aveva messo duecento e più metri di dune e sabbia caldissima prima del mare. Un terreno di giochi infinito dove il vento aveva disseminato semi di piante spinosissime, creato ginepri di rovi di more dolci e acuminate e soprattutto aveva elevato le dune ad altezze inverosimili da scalare per le nostre piccole gambe. Ed era un correre continuo, con il costume che continuamente scivolava dai finanche magri finché lo si usava come palla da lanciare iin quelle risalite e discese a pelle nuda. I piedi riuscivano a trovare dei piccoli globi duri, irti di spine, su cui zoppicare e da togliere pungsndo anche le mani. Ciò che non si riusciva a capire era la frequenza di questa spinosità diffusa, come se le piante si difendessero dagli uomini o da qualche sconosciuto predatore. E di certo tutti quegli spini a cui non badavamo se non per le parti del corpo più delicate, erano rivolti a noi perché gatti, topi, lepri e altri animali di caria stazza e velocità entravano e uscì ano dai cespugli, si muovevano nelle macchie verdi irte di punte, con una naturalezza che non imparavamo. Giocare un intero giorno in quei luoghi, mescolandoli al mare, al salso sulla pelle da stendere al sole, creava due felicità difficili da spiegare: una libertà illimitata e gioiosa del proprio corpo e dell’esistente e una dimensione del tempo e dei pensieri che era regolata dalla fame e dal sole. Si rientrava per pranzare e dopo un finto pisolare, si riprendeva fino a ora di doccia e di cena. Ogni giorno era una raccolta di spine, risate e scoperte che sembravano isolare agosto dall’estate e questa dalle stagioni: non c’era nulla di paragonabile nella meraviglia dell’anno e neppure il ricordo assisteva nel raccontarlo. C’era solo l’attesa che si sarebbe ripetuta, con i suoi rituali, le scorribande, le nuove avventure, la scoperta delle ragazze che prendevano il sole nude dentro casotti di cannucciato ben permeabili agli occhi e alle prime maliziose curiosità. E le spine che attendevano di conficcarsi i pelle tenera. Ma non erano un problema, casomai un capriccio della natura che non occorreva capire, solo togliere senza piangere. Ed era naturale come il diventare scuri in pochi giorni, avere la pelle che mutava nel sole e nell’acqua, sentire il corpo che era tutt’uno con i desideri e i pensieri, con i gridi e i sorrisi, con i piccoli segreti raccontati sottovoce, con il gelato della passeggiata serale. Un pinguino prima della notte e del sonno, che aveva un solo scopo:far nascere un altro giorno tutto nostro, tutto mio.
parliamo del lavoro
A maggior ragione oggi, più di ieri, è necessario parlare di lavoro; con la pandemia in atto e il PNRR che ripercorrerà i sentieri dei potenti e un sistema consolidato di diseguaglianze. Il lavoro ci è mutato tra le mani e non si è modificato a favore di chi lavora, l’abbiamo sottovalutato quando era più semplice, così oggi la capacità di capirlo costringe a rincorrere i dati più che quello che contengono. Ciò porta a ipotizzare mondi possibili ed economie alternative che per la loro qualità di cambiamento diventano di immane difficoltà realizzativa. Deaglio dice che bisogna partire dal lavoro com’è diventato oggi e su questo esercitare una comprensione e una guida che lo muti o almeno ne attenui gli effetti più impattanti in termini di precarietà. Ad esempio se la competenza diventa rapidamente obsoleta avere percorsi pagati di formazione continua che siano a carico di chi lucra su queste forme di innovazione dovrebbe diventare una componente del ciclo lavorativo. Portare il sostegno a chi perde il lavoro non verso la pensione ma verso un nuovo lavoro dovrebbe essere la caratteristica assistenziale di questo mercato mutato che non si basa più sul lavoro fisso e la competenza acquisita. Cambiare in questo modo il mercato tra domanda e offerta di lavoro non può prescindere dalla constatazione che gran parte di esso è ormai concentrato nei servizi, garantito da contratti e sindacati, nel lavoro fisso e che la manifattura in Italia produce un quarto del PIL.
Tutto questo e molto d’altro giustificherebbe una comprensione della situazione e un intervento da parte dello Stato che progetti un nuovo futuro che non è il PNRR. Difficile che lo faccia un solo Stato con successo più semplice se diventa un problema europeo e l’ambiente, per necessità, sembra dettare nuove regole. E non saranno indolori. Quello di cui non si parla spesso è se il lavoro, anche quando c’è, sia sufficiente nella sua retribuzione per assicurare una esistenza libera e decorosa. Oggi questo non avviene se non in parte e segmenta la parte più attiva della popolazione tra chi ha troppo (minoranza) e chi ha troppo poco.
Troppo o poco rispetto a una società che impone livelli di consumo insostenibili e funzionali a una produzione globalizzata che comunque retribuisce troppo poco gran parte del lavoro che impiega. Una via d’uscita sarebbe quella di aumentare costantemente il valore di ciò che si produce attraverso la ricerca e l’innovazione, ma questo è il settore in cui l’Italia spende meno. Altra consapevolezza da acquisire sarebbe quella che il lavoro senza limite a cui viene soggetto chi ha un contratto precario e non solo, isola ulteriormente la persona dal contesto lavorativo e sociale, non diviene parte di un gruppo che produce qualcosa di cui sentirsi protagonista ma è solo un fornitore senza identità collettiva. Questa parcellizzazione della persona che segue le tante altre presenti nella società della realtà digitale, impedisce una crescita comune. Si guarda il PIL ovvero quanti beni e servizi vengono prodotti ma non la società che li produce e così una nazione di schiavi potrebbe avere un pil elevato ma nessun diritto per chi lo ha prodotto. Ebbene una nazione di schiavi ha ancora la possibilità di un senso collettivo dell’identità derivante da una funzione, può socializzare l’ingiustizia e il sopruso e ribellarsi, una nazione di individui in competizione tra loro, con retribuzioni al limite della sopravvivenza non percepisce più l’ingiustizia come fatto collettivo, anzi la ingloba nella percezione normale della realtà. Questo è il campo in cui un nuovo umanesimo dovrebbe esercitarsi.
l’eroticità dell’anima
Non so se l’anima esista oppure sia un gomitolo di mitocondri lampeggianti. Non sapendolo mi acconcio a ciò che sento e credo in una eroticità dell’anima. Ma “senz’obbligo di pedale”, come per Anna Magdalena Bach nell’orgelbuchlain, che non osava la pedaliera pur essendo maestra di tastiere. Così nascono queste note dopo aver preso sonno finché leggevo. Non mi succedeva da tempo, ma il pomeriggio, il fumo breve e la testa folgorata da tre righe su una persona che non conoscevo. Stanchezza accumulata e distensione da meraviglia.
Avevo letto una descrizione di un letterato triestino, scopritore di talenti. Bobi Bazlen. Una persona libera, insofferente ai vincoli. Così veniva descritto: nomade, disinibito, informale, dissipatore, inesperto, maldestro, veggente, ondivago,
Enigmatico, senza alcun punto fermo.
E mi chiedevo quante delle pulsioni che possiedo gli assomigliavano o erano solo desideri. E così pensando mi ero perso nei sogni.
Per le persone intimamente libere non c’è cronaca dei giorni passati, troppo lenta con le sue decisioni annunciate e nulla che accada nei tempi giusti. Pensavo. Tempi sospesi e scacchi virtuali, conversazioni in attesa di qualcosa che non si dice e i silenzi che fanno conversazione.
Quando frequentavo la Sardegna mi stupivo per la maestria dei sardi nei silenzi: un incrociare d’occhi e tanto bastava. Al bar per il terzo caffè, ed erano appena le nove, guardavo con ammirazione questa sapienza antica dell’ammiccare. Non sapevo nulla di questi codici, mi dovevo fidare e camminare sul filo, ma l’azzardo mi attirava: sentivo lealtà nei silenzi e nelle parole necessarie. Se riuscivo a concludere bene un contratto erano cose importanti, serviva fiducia reciproca e competenza: era il primo tentativo di rivitalizzare un’area chimica, un tempo importante, e farlo senza uscire dalla chimica, ma introducendo altro e migliorando l’ambiente e i servizi alle imprese e alla produzione era una sfida all’ingegno.
Arabo e noia immagino a raccontarlo, allora e ora, ma era realtà fatta di posti di lavoro e redditi. Dovevo scendere dai sogni, togliere le convinzioni di ciò che sapevo ed esplorare ciò che non sapevo per scoprire il nuovo. Insomma osare per capire, guardarmi dentro e scoprire il bene che fa fare al meglio le cose.
A guidarmi era la mia traccia di bene pollicino, per trovarmi nel bosco e sentire il mio richiamo. Lo sentivo assieme alla voglia quieta di una strada che portasse da qualche parte.
Questa era l’idea di partenza, ossia che le cose, i luoghi, le persone, i progetti, avessero un’anima. Partire da un disordine che fosse libertà per giungere a un’esistenza che durava.
Poi andò altrimenti, ma non ci furono errori e il nuovo era a disposizione. Da qualche parte mancò il coraggio e il bene, per questo, quelle parole su Bazlen, risuonavano, come una vita esistente, passata e futura, che pur diversa, aspettava di svegliarsi ed essere in grado di cogliere la realtà che serviva: l’amore che necessita, il comunicare che usa assieme la parola, gli occhi, il gesto, il sonno e il silenzio.
Eccola l’eroticità dell’anima.
T. W. F. o chiunque altro
Da una parte la tecnologia e la complessità, ciò che sfugge alla nostra comprensione oltre l’uso, e dall’altra la dimensione di noi, ammassi fragili, d’ossa, pensieri e sentire. Così è T. oppure W. o F. o chiunque altro, decisamente inerme e malcollocato per carenza di scorza e superficialità. Eppure prova con l’energia, che ogni giorno si riforma, a indovinare, interrogare, presumere il nuovo dentro di sé. L’uomo si sta rimpicciolendo, dice, non emergono i pensieri che abbracciano il mondo e l’universo, lo spirito è al servizio di un precario equilibrio dove ciascuno trova ragioni e scuse. Cita Kerouac e l’inizio di Urlo, ma non ci sono migliori menti a disposizione dell’economia politica, della linguistica o del semplice vivere. Per sfuggire dalla rivoluzione che li lacerava interiormente e dai colonnelli che ne martoriavano i corpi, i monasteri di monte Athos si riempivano di monaci giovani, piegati su se stessi. Una repubblica con diritto d’asilo che seppelliva i contrasti e metteva assieme mistica e mondo in ebollizione.
Nella teologia c’è la semplicità dell’assoluto di chi crede, la linearità del ragionamento che confluisce nella fede,
Per gli altri vale la ragione che porta in sé le sue aporie e la sua negazione. Poi W. o T. o F. pensa che c’è l’ironia che salva e il galleggiare sul cloud. Non dentro ad esso perché le memorie organiche e quelle digitali non si confrontano se non per trarre una realtà spuria che comunque è mente fallace e in divenire. Il déjà vu che possiede la coda dell’occhio, il sogno, la matrice del ricordo soppresso, sono elementi di ciò che ci cammina a fianco e dialoga con noi, il cloud non lo può fare. La memoria digitale nasce cristallizzata, morta all’evoluzione: dev’essere riscritta per falsificare, non tiene conto di come evolve e muta il mondo e il suo riflettere si spegne. Si sgrana in rivoli di incertezza precisa, di complessità ripetuta, ma è solo sequenza non arruffato mescolarsi di ipotesi, di tentativi di scomporre dentro la novità di sé il mondo.
Solo l’arte, dice W, con il suo slancio verso il cielo, sia esso interiore o esteriore, domina la complessità morta della tecnologia. In essa c’è l’ordine, continuamente infranto che dovrebbe contrastare l’entropia dell’anima, ci sono gli incontri fortunati e ci sono i sentimenti. E la materia. E nell’arte di vivere va ancora di moda l’amore: nessuno riesce a tappare la falla nel razionale che esso genera. Nessuno può farne a meno e nel descriverlo T. già sente il suo sminuire rispetto ad un oggetto che non ha punti di presa, di controllo, di misura. Nei particolari ci si esercita per governare quel poco di conoscenza che la vita e I libri offrono, nei particolari si rivestono d’amore le parti aguzze, si rende armonico ciò che sfugge ad un primo pensiero ideativo. Il pollice opponibile non s’oppone all’amore, modella e scava, dall’informe estrae un senso. Da dentro sé attraverso le dita esce un senso. Non tutto deve avere un senso anzi a volte è meglio che questo non sia evidente, uscirà poi e risistemerà la comprensione. E forse le cose.
Siamo un impasto di passato, futuro e presente e li chiamiamo memoria, speranza, realtà, ma sono parole e il senso siamo noi, o prima o poi evidente.