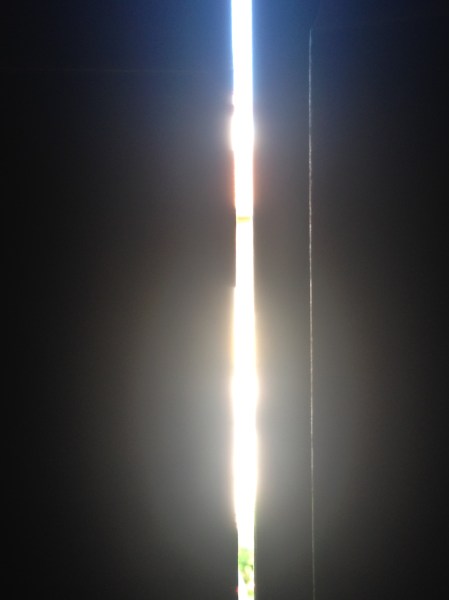Scrivo molto. Non come vorrei, né quanto vorrei. Mi piacerebbe che lo scrivere fosse la mia principale occupazione, ma non può essere così, e allora è fatto di ritagli, di fogli che svolazzano, di agende, di pensieri affidati al notes dello smartphone. Scritti, dimenticati, ripresi, ritornati, scomparsi. Pensavo che un blog fosse un modo per trovare persone che hanno lo stesso interesse, che scavano dalle loro parti e confrontano ciò che trovano. Un tempo lo era ora non è più così. Nel mio blog vengono pochissimi amici affezionati. Spesso mi piacerebbe sapere di più di loro. Chiedergli come vivono, come stanno davvero, parlare di impressioni, esperienze, vite. Poi mi rendo conto che questo mondo troppo spesso avvicina in modo strano il sentire ed è raro lo scambio.
Mi accorgo anche che altri passano per curiosità e scompaiono. Credo sia destino di chi scrive non sapere nulla di chi lo legge. Quali interessi suscita. Perché si è interrotta una lettura o cosa si è pensato di un raccontare che sembrava svagato. Sembra spesso un discorso che avviene in un solo senso. Per dare misura delle storie virtuali basterebbe pubblicare i whatsapp o gli sms che si susseguono. Qualcuno l’ha già fatto e ci ha ricavato due o tre libri, ma è un parlare diverso che sempre chiede e dice come si sta, cosa si pensa. E’ il momento e ad esso manca qualcosa: il contorno e la profondità. Manca il divagare, la confidenza di un’amica, il pensiero malinconico che non lascia, il particolare di una chiesa che non sarà mai vista da chi legge eppure ha suscitato curiosità. Come del raccontare il sudore d’una notte d’estate, o il canto dell’allodola prima che filtri la luce dalle imposte socchiuse, il sogno dal quale si è appena usciti, il rumore sommesso che arriva da una finestra vicina con sospiri e rumori d’amore. Tutto questo si può raccontare ma non racchiudere in poche parole.
Scrivere è un bisogno, un peso immateriale positivo che equilibra l’anima. Scrivere è essere ciò che si è, un gomitolo di aspirazioni, di ricordi, di attese, di delusioni e felicità improvvise. Dalla vita con il suo filo che corre ne è uscita una palla, un gomitolo con cui qualche gatto gioca e sembra fingere di capire.
In realtà continuerò a scrivere anche se non so che ruolo abbia nella mia vita. Nel gioco della psicanalisi ad un certo punto mi sono accorto di aver compreso parecchio di me. Potevo allineare tutte le manchevolezze, sapere da cosa si erano originate, ripescare gli incontri che mi avevano impaurito, cambiato, e quelli che mi avevano reso quasi felice. Ho visto l’origine profonda e quella banale di alcune malinconie, ho intravvisto il sauro che dorme dentro, dove si arriva a fatica e mai senza pagare pegno. Ho interpretato sogni, cambiato qualche piccolo atteggiamento e infine mi sono accorto che all’analista non avevo più nulla da dire perché parallelamente era andato avanti un discorso sulla carta che si era originato ben prima e che continuava per suo conto a interpretare, cercare, mettere in fila. Ci siamo salutati neanche tanto bene, voleva continuassi, ma non avevo più nulla da offrire che mi desse un senso differente ed era una consapevolezza profonda, come quella del non dare consigli, del considerare che i pesi si portano da soli e si lasciano nel giusto posto . Per me quel posto era la pagina, la penna, le parole che si formavano e venivano da una fonte comune che si era arricchita per strada, ma era sempre quella. Quella fonte ero io. Con tutte le emozioni raccontabili e non dicibili, con le manie piccole e grandi, le paure e gli scatti improvvisi di felicità. Ero io nel momento in cui camminavo senza meta facendo le stesse strade, nei pensieri che avevano il ritmo del passo, nei desideri e nelle delusioni. Ero io negli errori piccoli e grandi commessi, nel senso di fallimento rispetto alle grandi attese. Ero io che mi perdevo e che accettavo ciò che mi sembrava grande e alto, tanto da farne un pensiero che poi lo portava a terra e lo rendeva comprensibile, fattibile. Ero io che mi cercavo nell’inutile perseguito con acribia determinazione.
In questi giorni ascoltavo la lettura della Coscienza di Zeno e pensavo che il flusso ininterrotto di pensieri, con cui vedeva la vita mettendoci la giusta ironia, non gli toglieva la necessità di raccontare il sentire e così faceva Grace Paley nei suoi racconti in cui si guardava vivere. Di questi esempi ce n’erano a migliaia e tutti avevano scritto per una necessità che precedeva il bisogno di avere lettori, di sentirsi bravi e che quella fonte, di cui parlavo e che tutti abbiamo, si disseccava solo quando si era inutili a sé. Per questo ancora scrivo e continuerò a farlo, non per i lettori che vorrei mi parlassero ma per quella solitudine del parlar dentro che viene compensata o da qualche persona che arriva al cuore e non ha bisogno di bussare oppure dal far uscire le parole che dicono come e cosa si è. Parole come sangue che fluisce e circola in un corpo più grande, un dentro e fuori di se stessi che è l’abbraccio che posso dare a me stesso e al mondo.
(302) Vivaldi – Dixit Dominus (RV 594) – YouTube