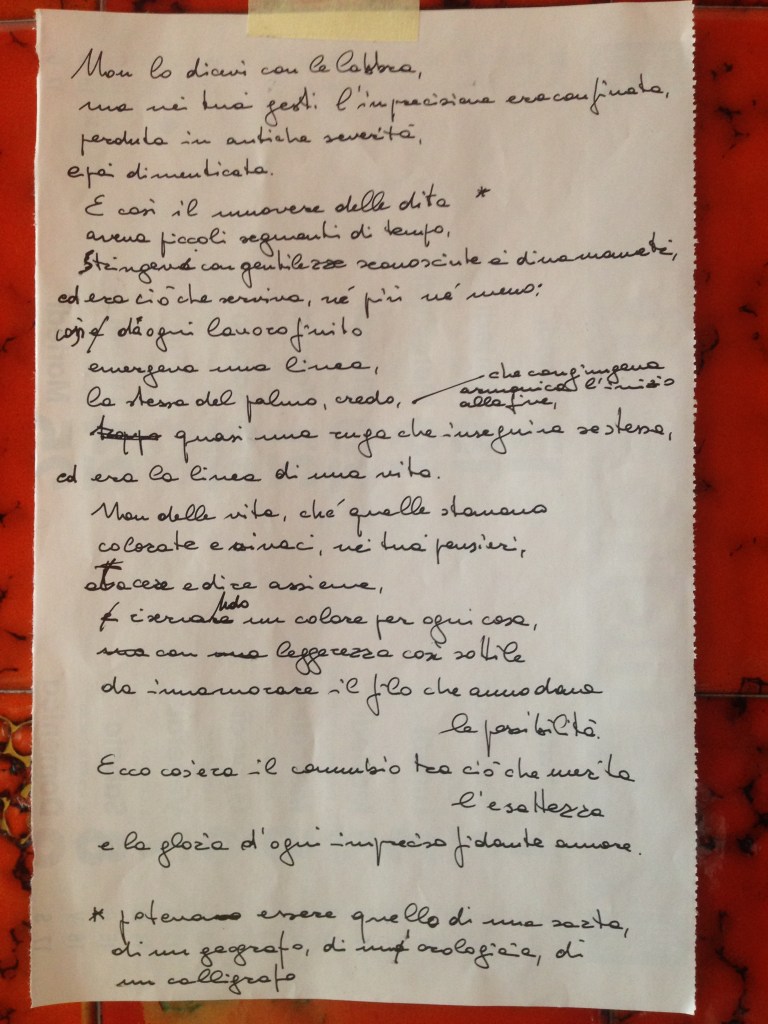Molti sabati e pasque li ho passati al mare. Di alcuni ho un ricordo particolare che come tutti i ricordi è più impressione che fatto, di altri mi è rimasta la sensazione che avrei preferito essere altrove. Superata l’età in cui la Pasqua aveva un significato particolare, specifico dal punto di vista religioso e quindi di per se stessa fonte di pensieri direzionati, restava una sensazione di festa particolare, però con la libertà del pensiero e quindi dell’andare, Ancora oggi faccio fatica a considerare la fede altrui come un fatto da antropologia culturale e quindi mi trattengo nel violare le intimità, i riti più ostentati, fermandomi alla soglia e facendo un passo indietro. Dove inizia ciò che per altri è importante, come non avere rispetto? Ma non ricevo lo stesso trattamento, nemmeno lo sforzo di dire qualcosa che consenta una riflessione. M’ infastidisce ricevere messaggi religiosi, citazioni di telefoniche di salmi da persone, che ti hanno messo in una mailing list perché in qualche modo sei stato importante a loro. Quando è accaduto eravamo diversi e allora questo fenomeno semplicemente religioso consumistico non c’era. In molte pasque che ho vissuto da solo o in compagnia, non c’era neppure il dato umano delle piazze davanti alle chiese gremite di persone auguranti, le mie, semplicemente si svolgevano al mare dove mio suocero aveva un villaggio. Arrivavano i villeggianti estivi a prenotare ed io che c’entravo abbastanza poco, mi godevo il mare fuori stagione.
La spiaggia era ancora ingombra di alberi e di residui della civiltà di pianura. Cercando con attenzione si potevano immaginare luoghi e fatti d’origine dei resti. Qualche moria di polli, una buriana di novembre, un nuovo detersivo dentro contenitori in plastica dal colore inusuale, molti frammenti di giocattoli, dalle teste di bambole ai pezzi di ufo robot segno che natale aveva fatto felicemente il suo corso. C’era un pranzo particolare, molte chiacchiere, di quelle che non affondano nel personale, perché non sta bene, e parecchio vino e caffè. Così arrivava il pomeriggio e la sensazione di una giornata strana che sarebbe stata riscattata dal lunedì con qualche scampagnata per argini. Se il tempo teneva. Lì, a Pasqua, era il mare il gran protagonista, con il suo aspirare pensieri, isolare le persone in sé e lì si giocava la partita dell’utile e dell’inutile: avevo perso tempo, ero contento, l’avevo fatto per forza? Di tutto un po’ ma ciò che emergeva era la capacità del mare di riportarti a te. Questa era la solitudine del mare e devo dire che appoggiato a qualche capanna appena costruita, riparato dal vento e con il primo sole tiepido, tutto questo mi pareva una dimensione bella e positiva, che magari non c’entrava nulla con il giorno e la ricorrenza, ma apriva una alternativa alle abitudini, alle feste obbligate, alle giornate che celebrano qualcosa e passano lasciando un senso di vuoto senza nome. Cos’è successo davvero? E adesso? No, questo riportarmi a cose che io solo sentivo era un passo avanti, un senso per me. Poi sarebbe arrivata la sera e il ritorno, ma quell’angolo era mio, solo mio.