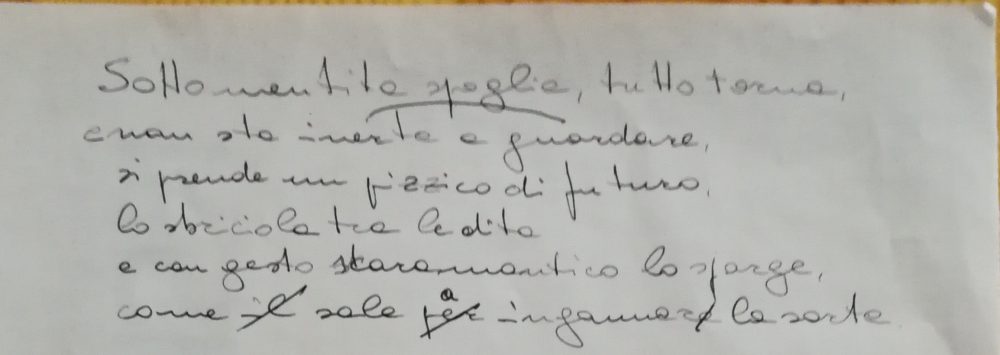Facevo cose banali. Cinque litri di normale nella ‘500 e andavo al mare. Spiaggia libera, asciugamano, sacchetto con i panini e la coca. Ero povero, non indigente. Dipendevo dalla precarietà del poco che raggranellavo. C’era un pamphlet situazionista sulla miseria della classe studentesca. Un sacco di parole per dire che dipendevamo in maniera indecente dai genitori, dal sapere accademico, dalla precarietà dei lavori offerti a chi studiava. Leggevo con attenzione e mi ritrovavo, in verità sarebbe bastata un po’ di autocoscienza, ma c’era conforto in quei ragionamenti: sembrava non sarebbe durata. C’era la mobilità sociale e col tempo, si pensava, si sarebbe stati meglio. Adesso è come allora, solo che è sparita la mobilità sociale.
Al mare ci andavamo in gruppo. Facevamo le solite cose: bagni lunghissimi, gli scherzi scemi, gli sfottò, la ricerca di qualche contatto femminile. Si parlava di tutto, non restava niente. Era meglio un paio d’anni prima, nell’adolescenza che finiva nelle scoperte, nelle camminate infinite, nei discorsi filosofeggianti. C’era stata questa nuova sensazione che la vita non era un insieme dato, ma qualcosa di ancora informe, che solidificava nelle scelte, che si costruiva precariamente eppure con arditezza. C’erano passioni che avevano bisogno di avere un senso, una relazione con la giornata; e spesso erano così totali da traboccare in essa. E poi c’era la scoperta del sesso, della sua impervia e semplice attrazione, della bellezza che si toccava col piacere. Si discuteva su tutto quello che si poteva dire. Si era spesso sinceri. Non mi vantavo. Avevo bisogno solo di rafforzare l’autostima e quindi un po’ assomigliavo e un po’ ero io. Nell’assomigliare si poteva dire tutto, nell’io molto meno, districandosi tra timori, sorpresa di scoperte, desideri.
Quante nozioni scolastiche mutavano nel farsi e diventavano dell’altro così originale che pareva nuovo e mai pensato prima. Lo usavo per stupire l’amico, e di più stupiva me, apriva mondi che nulla avevano a che fare con il nozionismo preteso a scuola. Mi perdevo in quel panorama di possibilità che si aprivano. Gli amici erano pochi, finiti gli sciami della fanciullezza, ci si sceglieva, a volte si forzavano le situazioni. Allora ho fatto scelte sciagurate per rifiutare il banale. Poi tutto si era trasformato in una cricca, in un parlarsi a memoria. E mi mancavano le notti insonni, conquistate e perseguite senza un vero motivo che non fosse la libertà.
Questo accadeva solo due o tre anni prima di quelle estati che inghiottivano pensieri, che riconsegnavano al banale. E agosto piombava in quei gesti scontati: il mare, la piscina, qualche lettura forsennata, assieme alla scoperta della solitudine come salvaguardia di una diversità e innocenza solo mia. Non mi disturbava che gli amici delle altre stagioni, andassero verso vacanze a me impossibili (erano tutti più ricchi di me), mi sembrava che rimasto solo ci fosse una tregua da un ruolo. Chi restava per quelle puntate al mare, lo conoscevo meno ed era un fare senza impegno. Il banale consentiva di non pensare troppo alla propria condizione affettiva, agli amori incerti, alle timidezze infinite di scenari costruiti nella testa, al bisogno di sesso che era insieme bisogno d’amore. Il banale riempiva i giorni comuni con altri, se mi si chiedeva di andare, andavo: meglio che niente. Meglio che si riempisse il giorno che alla notte pensavo io. Con le ubbie, le passioni che tracciavano confini, con le parole che si colmavano di significato e tracimavano, investivano altre parole e creavano pozze di pensiero liquido dove mettere le mani. Con paura, ma anche con desiderio, perché sapevo che lì sotto i significati si accoppiavano, c’erano nascite improvvise, folgoranti intuizioni e rifiuti che volevano dire il contrario.
Intanto al mare, di giorno, giocavo facendo parate spettacolose alla palla che scivolava sull’acqua, nuotavo senza paura e mi perdevo in quell’infinito che stava sotto e in cui ci si sarebbe potuti lasciar andare. Eventualmente. Sino al primo grido di richiamo, sino al pensiero che io mi aspettavo altrove.