Mi piacciono i quaderni grossi di pagine bianche, prendere la penna e scrivere, è un atto di libertà che devo a me, solo a me. Cosa condividiamo anche con chi ci è amico ? Le fatiche? La quotidianità? Oppure a volte sono le riflessioni che ci hanno fatto capire chi siamo ora rispetto a un allora che aveva altre ansie, incompletezza, rossori diffusi, richieste urgenti, voglia di vivere. Ciò che neppure si capiva sembrava indifferibile e urgente. Inseguire le notti, i giorni, i luoghi, gli affetti, l’amore che coagulava imperioso e spavaldo, lasciandomi attonito di tanta bellezza. Eppure erano anni pieni di asperità, mai facili, a cui sarebbero segui anni altrettanto complicati. I fallimenti sono una buona occasione per cominciare qualcosa di nuovo con la consapevolezza di ciò che è stato e invece spesso sono una coazione a ripetere. Allora c’era del buono anche nel processo non solo nei fatti e perché non si guarda bene cosa ci corrisponde in quel mettere assieme azioni in un determinato ordine, seguendo conoscenza e desiderio, perché in quella sequenza si trova un noi che si cela nel profondo e scrive sempre tra le righe dei diari. I conti con il passato si abrogano non si chiudono perché dentro di noi troveremo sempre un adesso figlio di quell’allora.
Mi è stato detto che devo amarmi come sono, nessuno mai riflette sul fatto che noi siamo amati o amiamo per scelta emotiva, per affinità interiore. Allora penso che amare se stessi non sia quel processo amoroso che conosciamo verso o da altri, ma sia qualcosa di diverso e personale. Amarsi significa scendere nel profondo, capire qualcosa, risalire e poi cercare di assomigliarsi sapendo che c’è molto da scoprire e che non si finirà mai. A questo dovrebbe servire il comunicare, a superare l’apparenza e il dovuto per dire e fidarsi di chi riceve il messaggio. Ciò che scrivo è parte di me ora, come lo sono stati innunumeri foglietti, appunti, folgoranti intuizioni. Una scia di carta e inchiostro, di emozioni provate e tutte apparentemente perdute, ma per vie recondito e parziali, parte di me ora. Conservo molto e quando rileggo riconosco che la strada fatta è stata uno scavare nell’essenza delle domande, che all’osso, le parole sono immagini criptate e depositi di senso. Abbiamo codici comuni traballante ed equivoci, così ho capito che ascolto volentieri gli altri, che le vite si svolgono e si assomigliano, che l’intuizione è fallace, che non finisce mai di stupire ma che è ciò che si capisce e la leggerezza che contano. La leggerezza è sapere cosa conta e vivere tutto quello che ci viene dato o scegliamo di cercare. La leggerezza è il proprio tempo che viene lasciato scivolare via perché ce n’è ancora e poi ancora. Penso abbia a che fare con la meditazione che porta all’innocenza, la leggerezza, so che fa star bene, che a volte si crea, ma spesso è un desiderio che si esprime in altro modo. Penso anche che la leggerezza genera stupore dell’altro, delle cose, dei particolari che contengono ciò che si cela alla distrazione. Penso che ci sia un dire che si capisce e rispetta chi ascolta, che la comunicazione sia questo e altro. Seguo il filo del pensiero e già la parola si sofferma, guarda e vorrebbe ascoltare, è nel labirinto senza Arianna per uscire deve volare. Ha bisogno di liberarsi della tristezza e del non fatto, dello stesso raccontare con un fine. E se è libera, ascolta e vola e dentro genera pace.
Archivi categoria: lettere all’analista
vanitas vanitatis
In quell’attività dell’anima,
ch’è guardare nel mio specchio,
vedo i segni del tempo,
e tra lampeggiar d’occhi e residue stanchezze,
mi fan pena i successi caduti all’ultimo intoppo.
Misericordia è volersi bene oltre le attese
e così tengo il buono rimasto,
gli ideali fieri di nuove battaglie,
il desiderio che s’affaccia,
tra lo stupore d’altrui mai pensati pensieri.
E’ in un particolare che rifulge, il bello inatteso,
ciò che fa dolce la luce nell’ombra,
il mondo che ancora m’emoziona ed avvince.
E’ la commozione dei vecchi,
irta di tenerezza e abbandono,
che oscilla tra immotivata gioia e tristezza profonda,
Sono i miei tratti che riconosco,
e allora indugio nei pensieri,
che resistono, a volte indomiti,
forse mai supponenti,
ma hanno modellato solchi, tracciato mappe:
i segni che vedo, seguo e ricordo.
Chi mi guarda, scivola su tutto questo,
chissà che cerca,
ma anch’io mostro la vanità
l’esser un po’ sopra il piegar la schiena,
e tengo per me, e per altri pochi,
il senso di quelle strade che trepidamente indago.
Di tanti anni, e negli sbagli, m’è riuscito il conoscermi
(il ricordo è così mutevole e creativo),
e ora a dire ciò ch’è accaduto, dei segni resta verità.
Mi guardo non visto nell’andare in scelta compagnia,
andare qui restando,
in cerca di me stesso, stupito
del nuovo che ancora mi ritrovo.
un’alterata percezione del tempo
Ho vissuto quel tempo senza lunghezza come un cavallo scosso, chi guidava erano gli impegni, le cose che giungevano già scadute, l’urgenza di un fare che implicava immaginazione prima che abilità e intelligenza. Ma forse si doveva unire il tutto e non me ne accorgevo, ci pensava il sistema simpatico a regolare le cose.
Mesi si aggiunsero ai mesi, diventarono anni e il transitorio mutò la programmazione del tempo. Le giornate erano folate di libeccio, si scuoteva tutto attorno, non dentro dove il periodare era diverso. Spesso contrapposto. Gli alberi nei giardini minuscoli, teste dissenzienti in balia di venti sconosciuti. Il sole appariva e scompariva tra nubi, tende, sbattere di imposte.
Ogni giorno aveva la sua quiete, la luce irrompeva nella stanza , il caffè, il silenzio delle prime ore del giorno, ravvicinato, trasparente e confuso con la vista dei tetti e delle finestre ancora chiuse. Correva la luce sui coppi, sui corrimani delle terrazze, sulla facciata ocra della casa oltre il vicolo. Offrivo al mattino un meditare che raccoglieva i sogni e li portava amorevolmente tra le cose del giorno.
Altri giorni erano i taxi per l’aeroporto nella notte piena che accoglievano i silenzi e le poche parole necessarie. Fuori le allodole già cantavano nel vicolo e i profumi dei giardini nella notte mi avevano accompagnato fino al corso. Asfalto, terra bagnata, rosmarini, rose, salvia, timo, tutto sparso nell’aria. Avrei dormito in aereo, in treno, da nessuna parte.
Non ricordo giorni di quiete fino alla piena estate. Ma della quiete c’è sempre poco da raccontare e meno da ricordare, certamente quei giorni c’erano perché ricordo i luoghi, i bozzoli di silenzio, i pensieri che liquefacevano e scacciavano le soluzioni.
Rispondevo a me stesso ben più che ad altri, del fare, delle azioni previste, budgettate e i pensieri, il meditare erano ben superiori all’apparenza del dire, dello stesso agire. Erano miei.
Fortificare se stessi e chi era con te, essere pronti, immaginare, conoscere i propri e altrui limiti, non eccedere, cercare aiuto in sé e solo se necessario, altrove.
La notte portava fresco, ricordi, musica nel buio, bagliori bluastri dalle finestre aperte. C’era il desiderio di essere parte sostanziale di qualcosa che si doveva compiere perché questo suggeriva silenzioso il daimon. Tra l’essere e le abitudini stratificate, c’era (c’è ancora, c’è sempre) un libro intonso che attendeva d’essere scritto. Ogni parola, scelta con cura di logica e cuore, parlava al vento d’ogni notte. Lo leniva e rassicurava, lo aiutava a preparare un altro giorno.
Tutto era acuito, veloce o lento. I profumi, la temperatura sulla pelle, la percezione dei suoni, la musica, le sensazioni del tatto, l’odore mutevole delle pietre scaldate dal sole, lo sbattere di una lamiera mal fissata, l’abbaiare insistente di un cane prigioniero. Non ho mai fatto così tante foto di notte, passeggiavo e non c’era nessuno, ascoltavo i passi, le ombre, le luci che davano contorni netti ai palazzi, alle cose. Quei contorni che non aveva il tempo dentro di me, i pensieri divisi tra la concentrazione e l’assenza, come se uno scalpello interiore si esercitasse con pazienza a scavare la materia delle emozioni e decidesse cosa doveva contare e cosa mettere in disparte. Un togliere perché ci fosse una forma e una fedeltà a sé, a ciò che ero e che doveva mutare ma solo in accordo con quel profondo che solo a me apparteneva e generava.


















tempi








Cerco di non pensare troppo ai proclami di guerra, alle previsioni dissennate e fosche. Mi illudo che ci siano reazioni di popolo, che ci si rifiuti di diventare tizzoni in un gioco di fiaccole vicino alla polveriera. Sconcerto. Parola colma di evocazioni. Disarmonia, impotenza, incapacità di comprendere, consequenzialità scisse dalla logica che si alimenta nel buono e nell’utile. Disagio crescente da affrontare. Le alternative oltre al dovuto possibile opporsi alla pazzia, cercano uno scartare a lato. Un riflettere sui tempi che sono radicati negli animi. Noi siamo ormai zuppi di un tempo servo di necessità non nostre, né vitali, altrove hanno altri tempi e percezioni. Che vi sia in questo una salvezza possibile? Esco. Faccio cose.
Percorro la città a passi lunghi e veloci, un’andatura da studente per raggiungere un tempo che non è il mio. Il tempo personale viaggia con me, mi accompagna, accelera o rallenta secondo i miei segreti, che borbotto e reciprocamente condivido. Sapere che ci sono molti tempi, che se possiede più d’uno, aiuta non poco a sistemarmi nel mondo in cui vivo. Ne ho esperienza.
In Ucraina, in Moldova, in Russia, nei paesi dell’est che ho frequentato, il tempo scimmiotta il correre dell’occidente. Spesso gli interlocutori hanno i colori giusti nei vestiti, ma tagli sempre un po’ sbagliati, l’orologio è troppo evidente, le ventiquattrottore che andavano di moda venti anni fa, hanno dentro tre fogli, il parlare è urgente e serrato. Quando si discute, il tempo e la sua presunta immanenza, irrompono, diventano parte concreta nell’alzare il prezzo di qualunque cosa e non si capisce perché, visto che attorno c’è il deserto, ma non importa, se il tempo ha un valore dovrà essere pagato. Si tratta dell’uso appreso dai tempi d’occidente, appreso chissà dove, forse nei film, oppure nei libri o nelle rimasticature di chi l’ha frequentato, ne è stato irretito e lo propone assieme all’inglese farcito di tecnicismi. Basta concludere e poi il tempo vero, riprenderà il suo corso. Mi ricordavano, queste persone, i commessi viaggiatori d’un tempo, le riunioni dei venditori di enciclopedie, dove non occorreva conoscere ciò che contenevano i libri, bastava usare il linguaggio giusto con le persone che dovevano comprare, la stessa aggressività e la stessa tristezza mescolata alle barzellette. L’Occidente ha alterato tempi e anime, l’attesa non è più parte della vita, ma spreco. Ne risente la conversazione, i gesti, l’uso delle cose. Quando viene imposta la gara e le regole non è detto che chi lo fa vinca, ma modifica il modo di vivere, di vedere se stessi e il mondo. Cambia la poesia è la musica assieme alla pittura. Sono barometric fedeli dell’anima e si legge il compromesso, ossia l’equilibrio tra il perduto e il nuovo. Un latente sconcerto nell’adeguarsi che sente una perdita di profondità acquisita e di identità comune a favore dell’indistinta superficie. Colorata e luccicante, da consumare in tempi brevi, poi inutile e da buttare.
Diverso è il tempo dell’Africa, di quella meno occidentale almeno. Qui gli avverbi cambiano significato: adesso può essere tra un’ora, un giorno, un mese, di sicuro non è tra un minuto. Presto ha lo stesso tempo e significato, in realtà vuol dire che accadrà quando si può. Credo affondi nell’animismo e che la religione musulmana abbia trovato un accordo pacifico. Il clima aiuta, è congruo a una diversa concezione del tempo. Il bidello della scuola dell’Asmara, quando gli chiedevo quando m’avrebbe portato i soldi cambiati, mi diceva: dopo. E se io gli chiedevo: dopo, quando? Lui rispondeva stizzito: dopo, più tardi, presto. Ecco che torna presto, come tornava in Senegal: quando arriviamo che siamo stanchi? Presto. Ma alle sei ci siamo? Probabilmente. E arrivavamo alle nove. Basta sapere come funzionano i rapporti tra parole e tempo, adattarsi al tempo del luogo. Poi subentra la consapevolezza che tutto accadrà quando è ora, che solo il muezzin ha un orario vero, che il resto segue una sequenza in cui ciascuna cosa matura e succede quando può. Succede è conseguenza di qualcos’altro, perché affrettarlo? Non è una sola consequenzialità, queste sono le nostre logiche, è un addensarsi di probabilità, molte sconosciute e non misurabile con le stesse unità di misura. Un tempo dell’accadere quantistico, reale e impalpabile, che dialoga splendidamente con la luce: ciò che non accade prima del buio è destinato al domani. Quasi tutto, la notte 6riservata al dominio dei corpi e ai loro tempi.
Quello che ad un osservatore disattento potrebbe sembrare imprecisione, scarsa valutazione, in realtà è rispetto per il flusso delle cose: bisogna salire sul tempo comune, lasciarsi trasportare, non guidare il convoglio, lasciare che i fatti si incontrino con noi. Questo tempo accelera e rallenta, ma non dipende da noi, è nell’aria spessa di calore, nelle buche della strada, nell’aprire e chiudere di finestre perché l’aria circoli fresca, nei problemi risolti momento per momento. Si direbbe che tutto è provvisorio rispetto al tempo d’occidente, ma in realtà è il modo, un modo alternativo per risolvere le cose. Diverso e reale, il cui effetto è principalmente economico, impedisce il controllo delle prestazioni secondo i nostri parametri di guadagno, si negozia volta per volta, dal taxi all’albergo, e anche il venditore se dorme appoggiato al bancone, bisogna svegliarlo se si vuole comprare, ma è davvero un problema quando si sa che funziona così ?
Quello che accade in Europa è lontano, il tempo è la possibilità di avere un futuro, adesso. Bisogna saperlo e sentire che per avere tempo bisogna vivere. E imparare che i tempi sono nella vita, la ibridano in conoscenze nuove e assolute, non serve correre, sono le stagioni che regolano tutto e quindi il ruotare del pianeta, il sole, il giorno, la notte. Urgenza è ristabilire le condizioni per capirsi, per avere tempo da riassettare, riportare a noi, a me.
I ferri del mestiere
Ricordo il sole nel giardino, l’ombra della mura, la mezza vera da pozzo rinchiusa, il banco, i “ferri” originari di mio Padre che l’avevano accompagnato nel mestiere e nel suo evolvere, gli attrezzi che si erano aggiunti nel tempo comprati perché la tecnica mutava. Nulla era in disparte, ogni utensile aveva un nome e una funzione e il suo ruolo emergeva quando veniva preso dalle cassette o dalla borsa.
Quello che doveva essere un amico, ma era solo un collega, prese tutto, diede pochi soldi a mia Madre e sembrò fare un favore. Forse lo pensò, comunque si sbagliava. Un’ impressione triste mi rimase di quel pomeriggio, perché parlava troppo e un giudizio era stato emesso sulle cose. Il sole nel giardino, nel capanno dove mio Padre lavorava, era diventato inopportuno, come lo stridio del gesso sulla lavagna, qualcosa di fastidioso che non scriveva nulla. Ciò che per quell’uomo era ormai vecchio e inadeguato, aveva prodotto capolavori che ancora funzionavano benissimo, era stato usato con la maestria che differenzia chi prende in mano un tramite per l’intelligenza e l’arte che possiede da chi questa intelligenza non ha e si affida alle cose.
Capivo che per mia Madre, come per tutti noi, la presenza di mio Padre era ovunque e la sua assenza lancinante, gli oggetti del suo lavoro erano un continuo riportare il pensiero e far riemergere il dolore. Questo aveva motivato l’accogliere quello che sembrava un atto d’amicizia, poi le parole di troppo, che a me erano sembrate un giudizio, avevano riaperto la ferita.
Mia Madre non capi, prese la banconota con difficoltà, salutò e ringraziò con le parole che definivano il sentire: non occorreva. Ed era vero, era una signora mia Madre, e lo era mio Padre. Fosse stato zitto con me, avrei ora un ricordo negativo in meno su come ci si approfitti anche del poco. È natura umana per alcuni, ma non di tutti.
Però un dono mi è stato fatto quel giorno, mai avevo capito così intensamente la grandezza di mio Padre nel suo lavoro, la sua maestria che curava il bello assieme all’utile e le sue mani, le mani che tanto ho amato nelle rade carezze, le avrei volute nei geni, come un tratto che si trasmette per il tempo a chi verrà. Non so se questo accada, ma se ciò fosse non serviranno utensili particolari per l’arte di essere se stessi e grandi, con umiltà e silenzio, mio padre era così, perché un lavoro ben fatto è già eloquente in sé.
parliamo tanto di me
Parliamo tanto di me, che questo poi si fa guardando il mondo e illudendosi che il mondo ci guardi e abbia un qualche interesse per noi. La realtà, così come la percepiamo è nostra, immersa nelle emozioni, deviata dai pensieri e oscuramente percepiamo questo isolamento che poi motiva lo sforzo comunicativo. Abbiamo bisogno di confrontarci di continuo con ciò che percepiamo, sentiamo, guardiamo e non poterlo fare con il mondo, gettiamo messaggi in bottiglia sperando che qualcuno apra e ci legga. A questo serve scrivere parlando d’altro. E pure a dire la verità scrivendo, quella che ci pare la verità. La verità non si esibisce, si racconta, è un’approssimazione della comprensione, ma la verità di chi scrive onestamente, anche quando è ipotetica, è chirurgica. Almeno chirurgica a sé, perché capire di più è inseguire qualche demone, anatomizzarlo per capire com’è fatto, purché resti vivo ed aderente alla sua verità. Che poi è la stessa di chi scrive. La verità del guitto, invece, balla larga nei vestiti non sono suoi, mentre vuole farli apparire tali; e si capisce.
Bisogna dirla con semplicità, la verità, ma questo è il segreto dello scrittore di rango che la ammanta di semplicità di vesti e la lascia spogliare da chi conosce l’erotismo della verità.
La verità ha una sua malinconia, che supera di molto il racconto del proprio malessere, anzi il parlar d’altro è un modo per proporre diversamente la malinconia che è nelle cose. Si dirà che le cose non hanno emozioni, però le acquistano quando cessano di essere tali e acquistano significato per noi. Sono le cose che ci colpiscono quando smettono d’essere indifferenti, che offendono; in fondo la verità è una mediazione tra un sentire e un essere ed entrambe le condizioni sono vulnerabili dalle cose. Ma restiamo in ambiti domestici: la nostra verità, che è poi bisogno, non ha specchio nel bujo del non vedersi, del non sapere chi si ha davanti. Soprattutto se si scrive come si borbotta tra sé. Il fatto di non avere specchio nello sguardo, nell’espressione, fa trovare specchio nelle parole e qui, a volte, si potrebbe usare la perfetta ricetta dello scrittore, ovvero mistero, storia, erotismo q.b. Ma questa non è verità, è racconto, plot, eppure quanti tentativi maldestri di racconto auto specchiante slegato da chi scrive, si trovano.
Chi ha lembi di storia comune si capisce per ricordi conosciuti, sensazioni sperimentate e soprattutto per intuito. Aiuta il vissuto che si sovrappone, ma nei modi in cui questo accade. Questa condizione si può trasferire anche nella comunicazione epistolare, che è fatta di sintonie profonde, rivelazioni intime, ed è un percorso di conoscenza, una relazione. Invece scrivere al mondo, a chi non si vede né si conosce, razionalizza, semplifica. Una frase in testa è fatta di continuità piene di puntini multimediali e spiegarlo diventa una fatica immane. Allora si razionalizza, e si perde il succo della vita vera.
Non scrivo per essere capito subito, non da tutti almeno, ma per la sintonia. Mi basta.
E se poi la parola diventa cura, allora ci dev’essere, come nell’amore, una doppia disponibilità: quella di lasciarsi curare e di curare. La relazione epistolare non esaurisce certamente la necessità di conoscere l’altro, essere vicini è una scelta che usa più mezzi.
Scriversi è una componente potente di un incontro, ma bisogna che sia un incontro.
E c’è differenza tra vivere come superficie (con puntate al profondo) e l’essere.
In fondo di questo vivere, di cui molto si parla, il limite è proprio la superficie e di come se ne parla. Se si fa lo sforzo del non tradire se stessi, è necessario scavare, allora agisce più il malessere, o il dolore, che la gioia, ma per comunicare la conoscenza che emerge, la nostra verità infedele, c’è bisogno di mostrarsi e questo implica una fiducia totale anche sull’essere fraintesi, perché il fraintendimento è il miglio posto dove nascondere ciò che siamo davvero.
Oh beh!
Questa canzone è per me la summa sublime di ciò che si può comunicare:
carichi eccessivi ed equilibrio










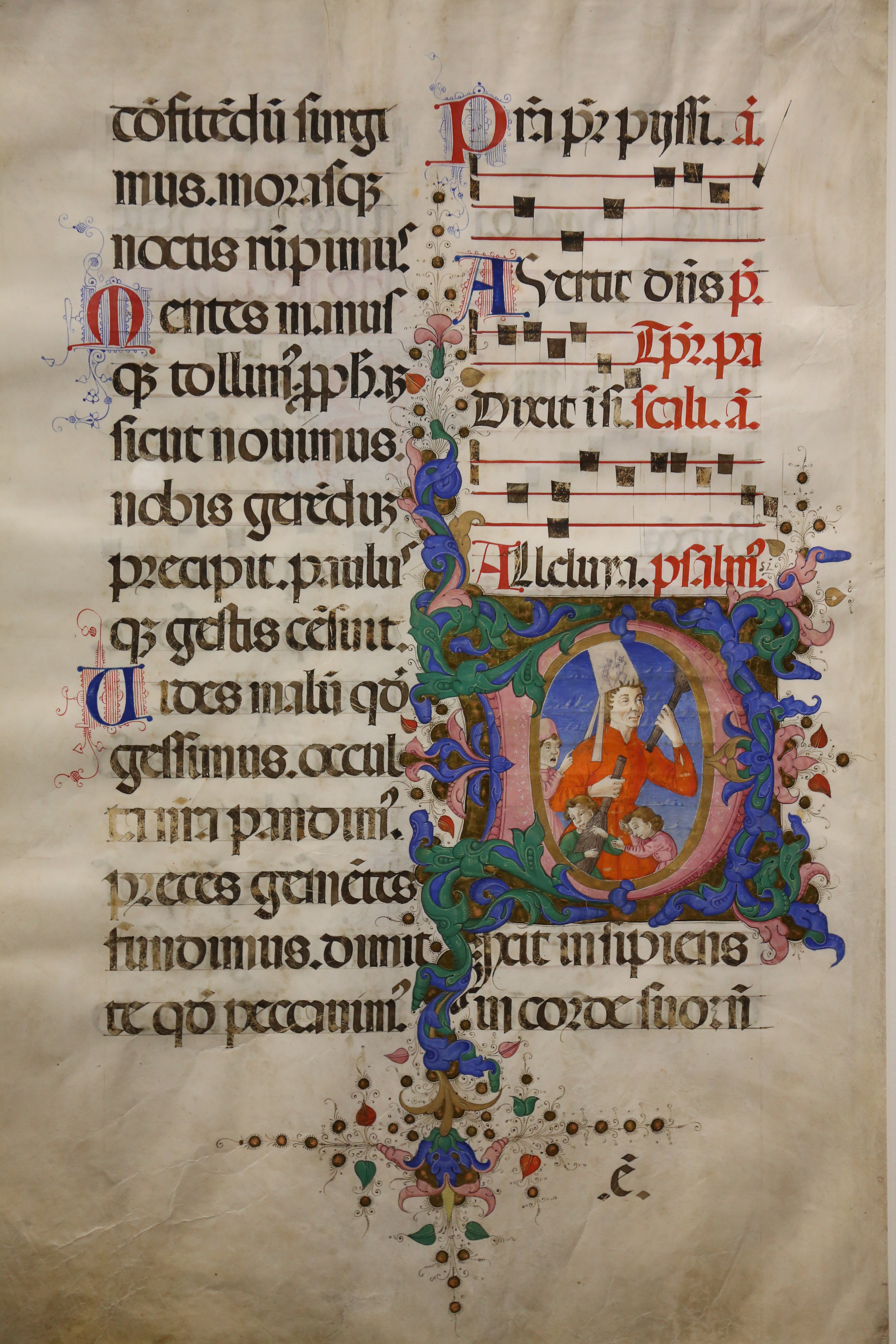

A volte penso che i carichi, presi con grande insensatezza (la generosità è tale), siano eccessivi. Lo sono perché projettano un’ombra sul mondo, sul tempo, su ciò che vedo. Ribellarsi per tutta la vita alla schiavitù delle cose, al loro ingerirsi nella vita, proprio per il senso del dovere che merita la funzione che si ricopre, significa rispettare le regole, ma non deve impedire di vivere.
Forse si cade in altre costrizioni; penso a me che coltivando le mie passioncelle, ho direzionato la nave tenendo equilibri che poco c’entravano con una visione usuale del presente, del mondo. L’essere fuori dagli schemi in realtà non pesa, è una scelta. E’ il folle che non sceglie la sua follia, ma la diversità non è un marchio d’infamia tra gli eguali, è una specialità, un seguire il demone, o il sogno che questo produce. Il problema, per non pochi, è proprio quello di avere un sogno, di alimentarlo, di svegliarsi, fare, e poi nuovamente sognare.
Qualche giorno fa, scrivendo d’altro e ben più concreto, parlavo del sogno come generatore di passioni. Vale in politica come nella vita quotidiana, ma non sopravvaluto le passioni, hanno troppa letteratura che le ha svalutate. Mentre in questi tempi si usa molto la narrazione ovvero il raccontare una realtà che sembra plausibile ma non è neppure finzione, anche se modifica non poco le vite collettive. Le passioni soffrono della stessa sopravvalutazione dell’emozione che diventa il modo per sgravarsi di obbiettivi più ampi e faticosi. Ma pur ridotte, passioni, emozioni, hanno comunque bisogno di un flusso in cui manifestarsi, una sorta di recinto in cui possono esplicarsi, correre. E parlo di passioni che non sono la soddisfazione del desiderio, del giorno per giorno; no, parlo di ciò che si può mostrare senza timore, perché è in sé chiaro ciò che si dice, parla della diversità e della sua continuità ed è così che ha un ambito in cui confrontarsi. In fondo quando raccontiamo di noi, ci sono almeno due realtà che si uniscono, quella delle nostre urgenze interiori, quelle che ci fanno star bene o male, e quella delle urgenze esteriori, con la loro violenza e scarsa creanza.
Quando lascio che l’urgenza esteriore mi espropri da me, che non ho più equilibrio e cerco ciecamente la medietà, il confondermi nell’essere eguale perché questo è rifugio, è riposo. Ma non posso permettere che l’esterno ammazzi la capacità di sognare, di generare passione; non posso permetterlo perché ne morirei in ciò che ho di vero e quello che rimarrebbe sarebbe poca cosa: un codice di regole banali.
dire è non dire
Si snoda il racconto di una storia oscura, dice di cose evidenti, ma parla anche d’altro, di un sottofondo che la sorregge e non emerge. E’ una di quelle storie che non si capiscono bene, estratta dal fondo melmoso che ciascuno si porta dentro. Sembra semplice, ed invece è complessa, fatta d’un malessere che ha più nomi: quello contingente, ed è ciò che viene vissuto, ed altri nomi apparentemente più lontani. Reminiscenze, sorta d’aliti di antichi pasti mai conclusi, che fanno capolino e sembrano non entrare nel sentire, senza parole per dirsi e dire. Difficile dar loro nome perché sono storie parallele all’esterno, vicende apparentemente già terminate che si annodano in chi racconta. Semplicemente ci sono e confluiscono tutte nello stare a disagio con sé. Questo è il sentire vero, e il racconto cerca di dare evidenza a una serie di fatti, parla di particolare e di generale, li mette assieme, e prova, con fatica, a collegare ciò che è distante, e che si dovrebbe davvero cambiare, con quello che è più vicino e pare avere decisioni semplici. Ma esiste una decisione che ci riguardi profondamente e che sia davvero semplice?
In fondo il racconto è ricco di quelle richieste di intuizione che generano puntini che attendono nomi. E in quei puntini c’è la misura della richiesta di partecipazione, sono piccoli-grandi vuoti che si generano quasi da soli per far capire che il racconto è ben più complesso dell’evidenza. L’evidenza è una ferita che deve essere ripulita, suturata, ma il motivo per cui si è generata è anche in quelle sospensioni. Il racconto è un processo curativo, prima che salvifico, e come ogni cura mette in discussione il rapporto con il medico. Genera il dubbio se tarda il risultato e però ci si deve fidare, servirebbe la comprensione, richiesta con la parola, e il silenzio. Anche pensarci, senza proposta di una soluzione, va bene, ciò che urta è la proposta facile che dice: bisogna cambiare per star bene. Per questo non serve un racconto, chi racconta sa che non va bene e sta cercando con fatica una via d’uscita.
La meccanica semplice ed oscura, è fatta di racconto, ascolto, reazione, e se l’ascolto è giudicato insufficiente, confluisce in una chiusura-reazione.
La difficoltà raccontata, è di quelle profonde, un mal stare da scelte in gestazione, oppure da scelte che non verranno prese, ma che comunque interferiranno fortemente con il concetto di star bene. E’ eccessivo pretendere attraverso un racconto una svolta, chi parla lo sa, e forse quello che vuole nel raccontare è un aiuto a decidere costruito con partecipazione e rispetto, con la comprensione della difficoltà, non una soluzione. Ciò che il racconto della difficoltà d’essere, narra, è il capire la ferita e il suo legame con altro.
Il limite della parola è questo, pensare che essa sia in grado di rappresentare davvero il malessere, oltre la partecipazione empatica di chi ascolta. E’ il limite dell’analisi che si esaurisce nella parola, senza una nuova storia da scrivere, e chi racconta si chiude nel momento in cui sente l’ascolto come non adeguato al dolore e alla sua complessità. Mentre sa benissimo che la semplicità sarà creata nello sciogliere molti nodi con difficoltà, e per questo rifiuta il consiglio, e vuole la partecipazione, magari silente. Un effetto del racconto può essere l’aggressività, ovvero la reazione che ribalta sull’altro l’insufficienza propria e della risposta, come se la mancanza d’intuizione fosse una colpa. In sostanza gli si chiede con rabbia perché non capisce e lo si traduce nel vedere la sua fragilità: ma tu che sei debole come me, come puoi avere le idee chiare? Se tu stesso stai male, quando mi proponi soluzioni apparentemente facili, mi stai parlando di ciò che ti infastidisce nel mio malessere. E perché non le applichi su di te?
Quando scatta questo meccanismo di reazione, può esserci solo la rivalsa, a volte la rabbia che fa dire parole eccessive che mostrano altre difficoltà, seguite dal ritirarsi verso la coscienza che è inutile parlare di sé e dalle difficoltà si esce solo attraverso se stessi. Allora il senso di solitudine è grande.
Controllare il balzo della bestia interiore, ammansirla, convivere, è un mantra. Dal racconto, fattosi soliloquio muto, sembra emergere un tentativo di conclusione: bisogna correre con l’animale, riconoscerne il senso del pelo, capirlo senza la pretesa di esaurirlo. Ma è un tentativo, perché anche da soli, il racconto è sempre un dialogo a più uscite e soluzioni.
piccoli wafer di risentimento
Sensazioni impercettibili di fastidio. Rapprendono senza chiedere aiuto alla ragione, sono il facile ricoprirsi d’altre ragioni. La domanda a cui rispondere è: con chi ce l’ho davvero e perché mi dà fastidio il suo interferire con me? Poiché la risposta neppure s’accenna, su croccanti modi di dire che sostituiscono le frasi, viene spalmato un sentire che mescola assieme la mancanza della giusta cura con la certezza di una incomprensione profonda. Una piccola colpa viene attribuita e il tutto è mescolato in crema da racchiudere sotto altri croccanti modi di dire. Si può continuare a lungo, anche perché il gusto dolciastro dell’essere incompresi alimenta non poco la considerazione di sé, fa sentire la propria differenza persino negli ambiti in cui ci si sente amati e protetti. Quella crema che si crea diviene appetibile giudizio, una sorta d’offesa lieve che tiene un po’ in disparte e accende l’attesa delle domande che si riferiscono allo stare. Tutto si misura tra ciò che verrà intuito e quello che resterà in ombra. In fondo è un gioco che lascia sempre la porta aperta al recupero. Un broncio del bimbo che è in attesa dentro i gesti, le attenzioni. E come bimbo è egoista, chiede d’essere accudito mentre non si prende cura. Non ha la leggerezza che sarebbe necessaria, però fa i conti con la ragione e il sentimento e questi sono nani forzuti che riportano le cose in un ambito dove ciò che c’è davvero emerge. Che stai facendo? Di cosa t’Incupisci? Non ci sarà la forza per sorridere e neppure per accantonare del tutto, ma il limite è già chiaro e tutto ritrova un posto d’importanza propria. Come nascono, i piccoli wafer di risentimento, vengono consumati, digeriti e scompaiono nei modi del vivere che di ben altro hanno bisogno. Non farli evolvere ma considerarli parte del silenzio è una pratica salutare. Neppure dovrebbero nascere, ma la perfezione attribuita è intrinsecamente fallace perché è bisogno d’altro, non libertà. E sul bisogno d’amore non si riflette mai abbastanza, ma neppure lo si lascia cadere se esso esiste davvero. Se è bene solvibile nel conto acceso tra anime che hanno innumeri ragioni d’essere insieme e che neppure devono attingere alla ragione per capire le alchimie profonde che le lega. Nella ricerca del benessere facciamo i conti con noi stessi e il mondo, quando siamo meno in equilibrio, insoddisfatti, preoccupati, giochiamo a chi risolverà la fatica che ancora non ha dimensione, per farci star bene. In questa sfera nascono dolcetti che tali non sono, che scompariranno dal ricordo ma fotografano un momento, una immagine in cui siamo a centro e attorno tutto è sfuocato, c’è e attende di essere riconosciuto. E’ solo stanchezza, tutto si rimetterà a posto. Riconoscere d’essere stanchi è già capire che il problema è in noi e che costruire silenzi è fatica inutile.
Il rancore è un veleno serio, modifica dentro e toglie luce, è una lama che scende e taglia la percezione. Produce disastri a chi lo prova e non di rado a chi ne è oggetto. Lasciamolo da parte, non ci riguarda.












divagazioni sulla bellezza
La bellezza ci cerca, ovunque, basta non essere offuscati dalla stanchezza, dalla serialità d’un sentire obbligato, e ci trova. Se diventa estetismo non ci coinvolge davvero, parla con quel narciso che ci accompagna, lo conforta e gli fa credere di appartenergli. Certamente è un sentire concreto la bellezza, è un equilibrio e un imprevisto, ma qui mi fermo perché voi ne sapete più di me e ognuno sa di cosa parla quando parla di bellezza, della sua bellezza.
Mi piace meno la “letteratura” del brutto, dello sporco redento, la povertà non è mai bella per chi è povero e neppure la bruttezza lo è per chi è brutto. Può essere una spinta a riconoscersi, estrarre virtù nascoste, ma costerà fatica. Altra cosa la mediocrità, la miseria interiore e la bruttezza sguaiata senza pensiero, che si distribuiscono ovunque secondo una gaussiana indifferente al censo. Magari più diffuse dove ci si aspetterebbero i migliori talenti. La politica, a esempio, oppure gli alti ruoli di lavoro, pubblico o meno, dove conta più il millantare che la capacità vera. Se la bellezza è un aiuto formidabile a crescere, l’imitazione del mediocre condanna a vedere il peggio come normale.
Però l’umanità c’è ovunque, in centro come nelle periferie e credo che portare la periferia in centro sia un atto di bellezza, come pure far vivere le persone in modo più decente. Lasciarla dov’è, nel bisogno è letteratura e divisione sociale. Quando si parla di mobilità sociale di questo si intende, ovvero del cambiare condizione di partenza.
Infine quando si scrive la propria storia non importa molto da dove si viene, l’importante è scriverla, possibilmente con meno luoghi comuni possibili, e in questo avere una direzione è importante. Ma forse nella mia testa c’è un’ icona del bello interiore che è lo star bene nell’equilibrio mobile, mentre il bello esteriore è un urlo che trascina, spesso è apparentemente statico mentre genera pensiero nuovo e acuisce i sensi. Modelli di sentire, che mescolano esperienza, vita, letture, viaggi, sono parte di me, motivo per la mia, di storia.
La bellezza è una direzione, una guida, in realtà cerco me stesso e la mia storia.













