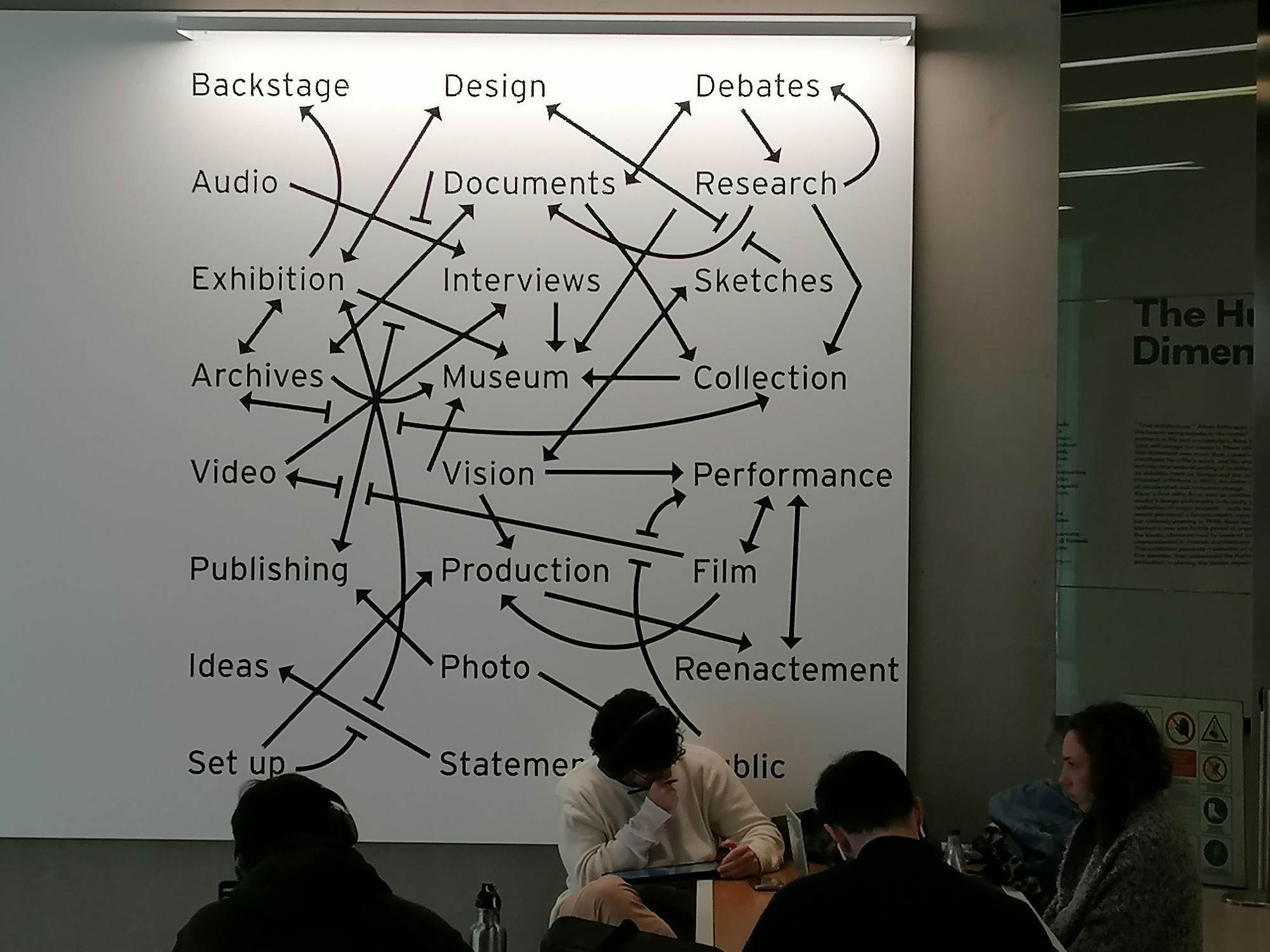” Davanti a lei c’era il solito viso giovane di Senkichi, ma non aveva il fascino oggettivo che si può provare per il corpo di un uomo al quale ci si comincia ad abituare. No, era un fascino magnetico, sempre più ambiguo, sempre più totalizzante. qualcosa in lui l’aveva rapita e non sapeva se sarebbe riuscita a separarsene. La sua voce, un gesto banale, il suo sorriso, un’abitudine insignificante come la smorfia esitante che faceva ogni volta che accendeva un fiammifero e ne ammirava la fiamma… Non poteva lasciar andare tutte queste cose che, soprattutto da quando avevano iniziato a convivere, si erano incollate al cuore di Taeko come vischio. Se qualcuno le avesse estirpate con la forza, la sua pelle si sarebbe lacerata fino a sanguinare. ”
Yukio Mishima. La scuola della carne. Feltrinelli
Taeko, la donna, ama e si lascia prendere dal fascino e, man mano, trasforma la presenza dell’amante in vita propria. Appartiene e la sua libertà evolve solo in relazione all’altro finché coincide con l’appartenere. Ma Senkichi non ha lo stesso sentire e ha una libertà che non corrisponde con eguale appartenenza, ha vita propria, e Taeko, mentre dipende sempre di più, lo capisce. Oppone desideri, destino proprio, ma solo nella sua mente, in realtà tutto è a due e vorrebbe un’ attenzione assoluta, essere libera di appartenere ed agire in conseguenza. Non essendo così, si lascia andare all’obbedienza, si conforma agli ordini erotici, modella la sua vita su quello che le viene chiesto, immagina una conclusione comune come libertà condivisa, ma sente che l’altro vive più vite e lei è solo una di queste. Di questo colloquio con l’amato, molto avviene nella sua testa, anche la richiesta di rassicurazione continua per timore della perdita che sarebbe perdita di sé, è implicita. Chiedere troppo potrebbe implicare l’addio. Teme la fine dell’amore come fine propria e il dolore fisico indicibile che ne conseguirebbe, è sul crinale, ha paura, non rompe l’incantesimo e quindi non può andare per proprio conto, deve procedere.
Se qualcuno vuol sapere come va a finire meglio legga il libro, a me interessa capire perché una cultura così differente dalla nostra com’è quella giapponese e in autore così imbevuto di tradizione come Mishima, diventi tanto simile la paura dell’abbandono nei suoi effetti. L’abbandono non ha sempre avuto la stessa fisiologia in occidente, in epoche, anche recenti e attuali, dove le migrazioni sono frequenti, c’è quasi un’inclusione della modalità del lasciarsi nell’ordinato evolvere delle storie amorose. Prima per una necessità che era immanente, dettata dalle cose, ora per una sorta di termine dei vincoli. Per cui è anche strano che questo sentire si sia portato, intatto nel dolore che provoca, nelle vicende di una società come la nostra, più leggera nei contenuti, meno vincolata. Diminuendo i vincoli sociali e religiosi legati al contratto matrimoniale e alle storie amorose era sembrato inizialmente che i sentimenti perdessero incrostazioni, fossero più naturali e liberi, che le storie avessero un evolvere che tralasciava gli assoluti e puntava sulla realtà. Come vi fosse finalmente un primato dell’amore, soprattutto nella sua eguaglianza di sentire e che il resto assumesse man mano la consistenza degli obblighi e della loro soluzione sociale. Invece non è stato così e pur essendo diverse le situazioni in occidente a seconda del contesto nazionale -ciò che è normale in un paese protestante sembra non lo sia in un paese cattolico- l’amore ha evidenziato la difficoltà di essere simmetrico e ha forse accentuato il dolore dell’abbandono. Più libertà ma non eguale, più dolore nell’abbandono, ma non eguale. A ben vedere tutto come prima. Quindi una fisiologia dell’abbandono e del dolore connesso non si è sviluppata. E non parlo delle grandi storie d’amore, ma della quotidianità dell’incontrarsi, amarsi, tenere assieme l’amore, oppure lasciarsi. Che questo accada in ogni cultura, anche se in modi, e credo con intensità differenti, rendono l’abbandono un punto fermo di analisi. A partire dall’abbandono (o dal suo non esserci) si arriva alla tipologia d’amore. E qui, ancora, oriente e occidente si incontrano, l’appartenenza e il sono come tu mi vuoi, è dipendenza, snaturamento del sé. Ma se si chiede a chi percorre questa strada, ci si sente dire che questa libertà consegnata all’altro è prova dell’amore e ancor più è dono assoluto. Piegarsi diviene facile se l’insicurezza di essere amati è alta, eppure in tutte le altre manifestazioni del vivere la vita sembra continuare con gli stessi principi di prima, è solo in quell’ambito che non ci sono più resistenze. Se in una storia non c’è simmetria, qualcuno rincorre perennemente e oscuramente sa che l’abbandono è già compreso nell’inizio, quindi ciò che si vorrebbe, indipendentemente dai sistemi culturali in cui si è nati, è che quel destino fosse rovesciato, che non fosse vero. Così Taeko, immagina evoluzioni cruente e comuni, non riesce a vedere un futuro felice e trasferisce alla passione asimmetrica il compito di far coincidere con un dolore/piacere, il destino comune. Manca un’ ipotesi dell’abbandono come evoluzione della storia amorosa, anche come sintesi di realtà, come passaggio/nascita verso qualcosa di nuovo che sia maggiore perché comprende una crescita. Il dolore come riconquista del reale e di sé, l’amore come qualcosa che mentre segna le vite, le spinge avanti, fa desiderare un nuovo assoluto. Manca questo pezzo nella cultura e quindi ciascuno lo elabora come meglio crede, trova una soluzione oppure implode in ciò che non stato. E questa singolare comunanza rovescia l’analisi: per sapere chi siamo e come saremo amati dovremmo capire perché l’abbandono pesi così tanto in noi come paura assoluta. Anticipo di una solitudine, questa sì assoluta nel nostro vivere, una incompletezza a trovare l’altro e quindi a sentirsi amati per davvero. Manca una educazione ai sentimenti, e questo è così poco naturale da far presupporre che sia un’area lasciata intenzionalmente vuota, come se nell’infelicità degli uomini ci sia un esercizio di potere.