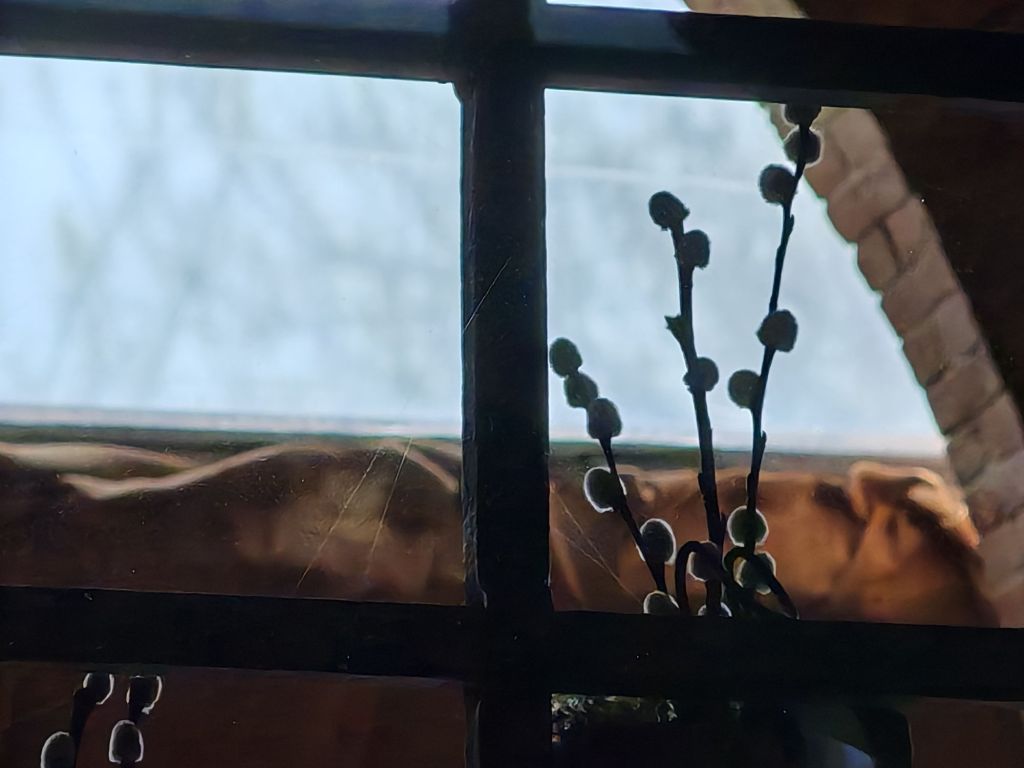La sera arriva sempre più presto. La stagione regala meravigliosi tramonti, ma chiude le finestre all’avanzare della notte. Sull’altra sponda del lago le luci si accendevano prima, mi perdevo a guardarle nell’ora in cui l’attesa è calda di promesse. Pensavo la notte che entrava scivolando da sotto le porte, che stupiva le abitudini sollevando gli sguardi da un lavoro, mentre invadeva corridoi e cucine. Gli alberi della litoranea erano punti di luce gelosa dei lampioni e cerchi si susseguivano alternando chiarore ed ombra nei marciapiedi . Qualche panchina ospitava le parole scambiate prima di un abbraccio, di un lasciarsi fino al giorno successivo, non c’erano addii, pensavo, ma luci e calore che abbracciavano le luci dentro i cotoni pesanti, le prime lane che avvolgevano i corpi. Il tramonto che vedevo si stingeva in coni pieni di verde donati dagli alberi sopra i vecchi affusti in ghisa dei lampioni. Un mondo quieto, ignaro, che si preparava alla cena, allo scegliere il che fare in attesa del sonno. Fuori dal grafo che unisce i punti e le relazioni del perimetro di ciò che conta per la sua vita, c’era un altro mondo che alterava l’ordinata sequenza delle scelte. Mi sembrava un mondo meraviglioso per il molto che poteva dare, ma insieme irto di minacce. Capivo cosa significava quella parola che il medioevo ci restituiva: essere in balia di qualcosa, di qualcuno, di volontà senza regole negoziabili e avvertivo la mia scelta del posticipare, dell’omettere ciò che avrebbe potuto irritare la sera e la notte.
Ascoltavo spesso la quarta sinfonia di Brahms che mi sembrava riassumere l’attesa di un secolo ormai lontano, ancora così romantica nella volontà, nell’indurre l’idea che il singolo potesse affrontare non solo il proprio destino ma quello dei molti essendo parte di un’idea grande, bella, di pace e di inclusione. Era un tempo denso, non troppo distante, in cui la gioia immotivata poteva dialogare con le malinconie della consapevolezza del tempo, del luogo, del modo. Ma ora che posso dire del tempo che ci lega, del camminare portando speranza, dell’ascoltare intelligenza, mentre attorno si diffonde indifferenza e incoerenza tra le logiche del buono possibile? Capisco che le parole dicono poco, ma non è logico, naturale dare speranza ai propri affetti, preservare gli amori, la bellezza che abbiamo la fortuna di ricevere? E perché allora la notte non è quieta e non si fa strada la coscienza dell’essere protetti, che chi ci è caro avrà la bellezza da noi vista e molta di più, che noi stessi, il mondo, possono pensarsi in pace non travolti dall’innominabile?
La conclusione di questo riandare a un tempo che mi sembrava denso di speranza e con difficoltà, è in un epitaffio: “il terrificante inizio del ventunesimo secolo, un tempo senza dio, contaminato da arrivisti e corrotti, nel quale il capitalismo finanziario, con la complicità dei governi conservatori e la passività dei socialdemocratici, ha soppresso il welfare state” (Fernando Valls, El Pais). Dovremmo aggiungere che i diritti, la dignità, l’equità che poteva essere una conquista comune, ridiventano parole e sono la fotografia di un gruppo infelice e succube. E’ l’immagine degli abitanti di questo occidente mediterranea, atlantico, ora globalizzato e succube? Siamo noi? Può essere, la fotografia è precisa, ma include sentire e chissà quanti si riconosceranno, perché non per tutti è uguale.
Si celebrano gli sconfitti? Solo nei romanzi, nella vita diventano naufraghi senza patria. Non c’è salvazione senza un sogno, senza una terra a cui tornare. Si accatastano le vite nell’inverno del nostro scontento. Servirebbe un incipit, un vessillo, un orifiamma che indichi il senso del vento, e poi la corsa in direzione contraria e ostinata a riprendere ciò che è nostro: la speranza di un futuro in cui cresca l’umano. Nel sole che ha illuminato il giorno e domattina tornerà, nel sole mediterraneo, dove le navi portano rifugiati e noi non sappiamo accogliere e ora neppure noi sappiamo dove andare, trovare un senso, perché ciò che s’è smarrito è il senso. Del fare, dell’essere, dello stare assieme. Parafrasando Pintor, agire è uscire dalla solitudine, essere nuovamente proprietari delle scelte che ci riguardano.
L’indifferenza cresce quando il necessario c’è, ma la grande contraffazione immiserisce, poco a poco, tutti, e nel cedere un metro di diritti umani e poi cento, un campo, un paese, si consuma la voglia di lottare. Il grande paradosso è questo difendersi, anche da se stessi, dalle proprie paure e miserie, dalla incapacità di ritrovare il noi comune che rovesci le regole imposte dal profitto sfrenato. Come non ci fosse più un limite a cosa ci toccherà perdere ancora. E sappiamo che ora sono le vite, la scelta tra la pace e la guerra, tra l’umano e l’inumano.
Vorrei una fotografia felice in cui guardarsi a lungo, decidendo se riconoscersi o meno, ora e in futuro. Seguire col dito le pieghe del sorriso del momento, che è fiducia del divenire. Riconoscersi è essere consapevoli, affrontare la sofferenza per uscire dall’inazione, dal subire ciò che non ci appartiene. Ma insieme, perché da soli non c’è storia.
La sera arriva sempre più presto, eppure la luce manterrà le promesse, chiede ai sogni di interpretarci per il giorno e così bisbiglia nella notte le parole che noi decidiamo di ascoltare. La luce torna e ci troverà sereni nell’agire per non cedere alla solitudine.