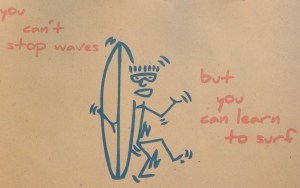Ho risentito la sua voce per radio, lo stesso tono, lo stesso incespicare nella costruzione della frase che deriva dall’abitudine di usare l’inglese come prima lingua. Come allora lo stesso atteggiamento tranchant che mi aveva così colpito e indisposto. Eravamo entrambi di vent’anni più giovani. Al consolato italiano, un cocktail di presentazione e di benvenuto. Invitati della comunità italiana e americani, tutti in piedi e impegnati in quell’esercizio da polipi che tiene insieme un piatto, un bicchiere mezzo pieno e una forchetta, tra un tonnarello e una polpetta al sugo lui si avvicinò e mi chiese cosa vendessimo davvero. Il tono e il sorriso ironico sottolineava che degli italiani non c’era da fidarsi molto, Che eravamo un po’ magliari e che comunque non avevamo la giusta dimensione per il paese che ci ospitava. Ero un po’ offeso, non ci conoscevamo e mi sembrava avesse la puzza sotto il naso, solo che la puzza eravamo noi. Gli dissi che avevo conosciuto suo padre, professore all’università al mio corso, e gli chiesi cosa ricordava della città in cui era stato a lungo. Sapeva poco e ricordava meno, però aveva un giudizio. Ne ricavai una ulteriore sensazione negativa, ingenerosa, per noi, per me, che ci davamo da fare e che, con difficoltà, cercavamo di rappresentare un Paese, il suo e nostro, e insieme un territorio degno di considerazione, geloso della propria dignità.
C’ho ripensato più volte in questi anni e ho concluso che aveva ragione e torto assieme. Che spesso le missioni economiche fallivano gli obbiettivi, che mancava la continuità nel lavoro di promozione, che rappresentare l’eccellenza non era facile perché quella conclamata si rappresentava per suo conto, mentre mostrare la fatica, le speranze, il lavoro certosino, le unghie rotte e le notti insonni non portava nessun lustro, Però c’era il territorio, la storia, l’eccellenza delle menti, l’insegnamento, una grande capacità di intuizione e di lavoro. In fondo ci facevamo lustro dei parenti ricchi, del successo altrui, mentre del nostro cosa potevamo dire se non che c’era voglia di lavorare, di fare, di crescere.
Aveva ragione sulla dimensione delle imprese, sul fatto che assieme alle realtà vendevamo la voglia di crescere, le speranze che sembravano cosa fatta, la ricerca in corso con gli scarsi mezzi, le idee povere anche se aperte. Eravamo parenti poveri, merce da lavoro, da sfruttare per penetrare il mercato che con il suo risparmio un po’ di potere d’acquisto l’aveva.
Aveva torto nel pensare che fossimo piazzisti, che ci fosse un voi e un noi. Per dimostrare che questa parte della realtà non salva nessuno, c’ha pensato il mercato finanziario, le crisi immani degli ultimi anni, il mutamento troppo veloce dei Paesi e della incapacità di crescita del benessere. Noi eravamo di una ricchezza cosi labile e recente da sapere il duro prezzo dell’impoverimento, lui non lo sapeva ma questo avrebbe investito anche il Paese ricco per antonomasia: gli Stati Uniti, demolendo la sua classe media.
L’ho visto più volte in televisione, letto e ascoltato. È un opinionista autorevole e ricercato, esponente di quella scienza, l’economia, che non risolve i problemi, ma propone in continuazione soluzioni. Si è un poco ammorbidito, forse l’età, però ancora giudica e fa capire che possiede verità incontrovertibili. Ho rivisto la mia opinione d’allora, non mi infastidisce più, aveva ragioni e non verità allora come adesso. E questo mi rassicura che in tutti gli errori che si possono fare, la buona volontà è ancora un motore mentre chi giudica si ferma oppure viene trasportato, ma non aiuta ad andare avanti. Però abbiamo bisogno anche di critici feroci. Ci riportano alla nostra dimensione, basta non essere schiantati dalla critica e pensare che non c’è speranza.