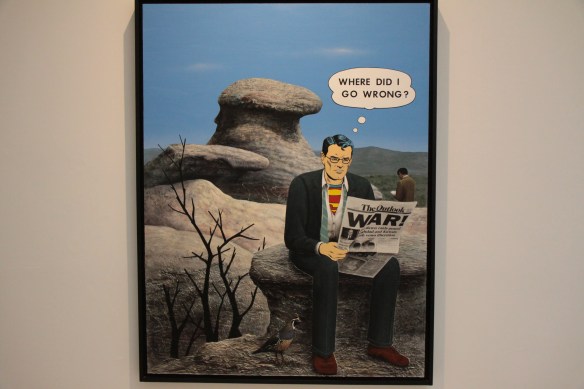Con la distanza le ferite non fanno più male, ma non si dimentica, l’indifferenza non è possibile. Se qualcosa colpisce chi ha ferito, si generano sentimenti ambivalenti, una triste soddisfazione ed una comprensione, altrettanto triste. E’ la misura dell’imperfezione, ci hanno raccontato storie sulla perfezione, credo che solo accettando ciò si è, sia possibile cambiare. Un’altra storia a doppia faccia che è comodo credere, è che si possa cambiare sempre oppure che ormai non si cambia più. Già l’esigenza di porre il problema, in realtà pone una questione che riguarda non la necessità di cambiare, ma come affrontiamo la cosa, ovvero se si vogliono mettere le mani in ciò che ci fa male, che non ci piace, oppure se ci si rassegni a tenerci, non la parte migliore di noi, ma quella meno faticosa. Credo che questa sia la scelta e che l’una o l’altra opzione non abbia un valore morale, che visto che il dolore è una faccenda personale alla fine ognuno avrà vissuto come voleva vivere.
Nei rapporti tra persone ci si può scambiare, e fare, molto bene, ma anche ferire in profondità. Non di rado entrambe le cose. Se il rapporto è stretto, forzato o meno, una strada si trova, magari molto costretta e fatta di necessità. Se il rapporto è una scelta, allora le conseguenze delle ferite hanno un aspetto che dovrebbe essere valutato guardando dentro e fuori: ricevere una ferita è un bagno di verità, aiuta a vedere l’altro nella sua realtà, quella che abbiamo accuratamente evitato di vedere perché ci faceva comodo fosse come noi lo volevamo. Si pensa fino a prova contraria: sei come io ti voglio. Quindi una ferita aiuta a vedere, ma aiuta anche a distaccarsi, sia fisicamente che mentalmente, perciò ha una sua positività di cui faremmo volentieri a meno. Infatti l’essere feriti è comunque un tradimento di fiducia in sé, anzitutto, e questo provoca un secondo effetto, ovvero ci mette davanti alla scelta: andiamo avanti, teniamo il rapporto anche se non sarà più come prima perché il velo è caduto, oppure rompiamo il rapporto e senza vivere in ciò che non sarà, si procede, ritornando a noi? Credo che in entrambi i casi ci sia un cambiamento, il che significa che si può cambiare sempre, e che accade anche attraverso la gioia e non solo la tristezza, ma quanto profondo sia il cambiamento dipende da noi. L’errore, in chi lo riconosce, è il più potente motore dell’apprendimento.
Non c’è nessuna idea di perfezione in quanto penso, gli errori insegnano molto, ma non a non farne e neppure l’accettazione di sé, se non vogliamo diventi una mortificazione, è un fatto statico, è tutto dinamico e riportato a noi che esaminiamo, comprendiamo, viviamo anche le emozioni negative, magari cercando di non permettere che queste aggiungano male al vivere. Quello che non è utile, penso, è non capire che il dolore può cambiarci, renderci migliori a noi e che per questo è un fatto personale. Tornare sui propri passi, rifugiarsi nei porti tranquilli, pensando che sia sempre tutto come prima, è chiudere gli occhi, raccontarci una storia che testimonia tutta la nostra debolezza e la non volontà di utilizzare il dolore della ferita per vederci davvero come siamo. E cambiare.
p.s. voglio spiegare la scelta del filmato: Farinelli è un castrato, credo che poche violenze per il piacere altrui abbiano avuto, per secoli, meno riprovazione morale. Quindi ferita doppia, non sanabile e in più giustificata. Persone costrette a soffrire, accettare la sorte e cambiare. Ma lo stesso si potrebbe dire per molto d’altro che conculca l’espressione del sé, la costringe e mortifica. Fino al quotidiano più piccolo, che si vive, nelle nostre piccoli, grandi ferite.
Lascia ch’io pianga
mia cruda sorte,
e che sospiri la libertà.
Il duolo infranga queste ritorte
de’ mei martiri sol per pietà.