Posare la fatica del giorno
nel verde che la notte ha inghiottito,
eppure c’è,
popolato di vita e di sonno.
Guardo il buio
in esso c’è la luce ardua
che non mostra il pulsare dei cuori
e anche le case sono mute.
Figure per un attimo
popolano finestre,
sono il tempo probabile
di chi m’assomiglia.
Fatiche, passioni e amori
si separano, rosari tra dita,
tracciano linee, pensieri e sentire,
un dolore che non sovrappone,
né comunica fine.
Regala la notte un grido d’uccello,
forse un rapace
che celebra le paure nella caccia notturna
e volgo lo sguardo
al cielo d’inverno
cercando nelle stelle
il rumore dell’erba.
Archivi categoria: notturno
ancora l’allodola non canta
In evidenza

La luce è a volte così stanca che si piega
e dorme appena fuori del cuscino,
così l’aria nella notte ascolta
e nutre il respiro, al buio
vede sogni e pensieri che si annodano
dietro gli occhi chiusi,
i timori che si vestono e danzano
parlando nell’orecchio.
C’è un tepore di corpo e piuma:
una nuvola senza tempo
s’aggira tra veglia e sogni,
mentre le cose si dispongono in attesa,
tace il buio, finalmente,
e ancora l’allodola non canta
dal caldo del suo nido.
notte d’inverno
In evidenza


S’è sparsa la luna nel cielo d’inverno
lotta con la nuvola che l’abbraccia
c’è calma di vento
e l’aria cade fredda,
pioggia sottile d’ozono e polveri.
La salvia dialoga col mirto e il rosmarino,
tra loro l’antica rosa
che ha perduto ogni foglia
e attende che qualcuno la protegga.
Insetti voraci nella notte
ancora si satollano
prima del sonno nell’oscura Terra.
La luna esce fulgida
e illumina le cose,
senza un gremito, lamenta
ciò che vede e ascolta.
ci sarà tempo
Ci sarà un tempo per l’irrilevanza
con il colore che estenua I visi e fugge dalle cose
Ci sarà un tempo in cui si sgrana l’acqua e cadono le pietre,
i nomi sciolgono le labbra
e cio ch’era solido si disfa per suo conto.
Ci sarà un tempo di luce grigia
in cui l’esecrare non avrà più senso,
dei nuovi popoli sarà pronta la memoria
e del vecchio solo polvere per vento.
Ci saranno notti che negano all’anima la luce,
solitudini nel buio che ricama domande accantonate,
e mentre i cani abbaiano lontano,
occhi aperti attenderanno
una fede che cancelli la ragione.
le discese e le risalite

L’antica contrada delle beccherie scendeva verso il fiume, diventava piccolo porto e poi le pescherie. Il ponte continuava la strada medievale tra le case e congiungeva palazzi e torri. Le poche rimaste. Anche la torre a fianco dell’antico albergo al bo era stata prima privata della lanterna, rinforzata con catene e raccorciata, ma teneva ancora le campane che suonavano a carillon l’inizio e la fine delle lezioni e battevano le ore. La casa che guardava le pescherie e il fiume era sorretta dalle altre case vicine. Un crocchio di eterne ragazze che ospitavano artigiani, piccoli commercianti, botteghe, operai. La via era la traccia di un retroporto romano appena fuori delle prime mura medievali e poi inglobata nel reticolo di strade che riempivano di case e orti lo spazio tra i palazzi di professori e nobili.
La notte, complici le ristrettezze comunali, l’oscurità era morbida e si spingeva sotto i portici seguendo le imprecazioni degli ultimi arrivi dal lavoro o dall’osteria. C’era il silenzio che solo le città possiedono. Animato, robusto e sornione, custode di vite che si ritengono appartate e condividono i sospiri. La torre batteva le ore, in mezzo ad esse un respiro profondo di basso si gonfiava e poi espirava il fiato già caldo dei muri. Su quel ritmo e con quell’accompagnare, ogni canto diventava sommesso, ogni nota appropriata, ogni voce era piena di promesse e di possibilità.
Le prime voci che ancora ricordo, furono quelle della mamma, sudata, affranta, contenta. Di mia nonna, che bestemmiò piano perché non ero una bambina, di mio padre che era felice come solo lui sapeva essere. La voce di mio fratello, che uscì dal sonno e in piedi sul lettino cercò di capire il trambusto inusuale, venne appena dopo, Ed era interrogativa. Chi era arrivato a quest’ora di notte?
Se esiste una tavola periodica dei suoni che li sistema assieme ai sentimenti, quelle voci erano nella parte primigenia, quella che trasforma l’energia in materia e nella sua semplicità costruisce l’evolvere delle cose. La complessità di ciò che si estrae dalle possibilità delle vite attinge a quei suoni che sono i primi uditi, tenuti stretti come buoni, conservati per discernere le vicende di ciascuno.
O almeno così io credo sia. E a quei suoni, tanto amati e tenuti da conto, unisco ciò che era fuori di quella stanza con le imposte socchiuse e le finestre aperte. Metto la notte che percorreva la via e che ha ascoltato il mio primo strillo. Unisco il rintoccare delle tre nella campana piccola della torre, i passi di qualcuno che andava verso casa. E senza avere nessuna pretesa di capire, penso che il tempo nato allora, abbia stabilito relazioni con quei suoni, tracciato segni per ritrovare una strada su cui tornare. Sono i suoni dentro che lasciano andare e correre, gioire, capire, dispiacersi, piangere, ricominciare. Quei suoni sono una perfetta circonferenza che riporta il tempo dove è nato e dove ha acquistato il nostro senso. Ognuno di noi li ha.
Io ricordo i miei e così la notte mi parla quando è quieta e nella veglia collega voci e vibrazioni, la prima compagnia, gli amori già prima sbocciati, speciali, mai esauriti.
oscurità
Quando, nella notte, il sonno si ritrae,
diviene fatica il sogno,
l’oscurità prende la ragione,
allora è forte il desiderio del giorno,
unica salvezza per discernere,
risposta se vi sia tempo alla vita.
Forte è il peso del reale,
e non è neppure la verità
ma chiede alle dita della bellezza
se ancora potranno scorrere,
meditando pensose, sugli uomini.
Se l’un l’altro potranno unire
l’unità che trabocca dal bisogno.
Sappiamo troppo del mondo,
ed è solo l’apparenza,
per sentirne il dolore vero,
la tenebra che avvolge le coscienze,
bisogna ascoltare e parole terribili vengono pronunciate: ricada su di noi il sangue,
ma siano sterminati.
Baratri d’odio vengono aperti nella luce,
odio che s’accumula ovunque,
odio che rende i corpi, le menti,
spazzatura d’umanita, negli sterpi gettata.
Odio che toglie luce,
che nega la tragedia,
odio che vorrebbe essere ragione,
odio che corrode,
che giustifica ogni crimine,
odio che uccide l’ amore che redime.
Sappiamo troppo per non provare
e capire che questo non finisce
che ci riguarda perché ci muta,
perché lacera prima le parole
e poi il silenzio.
Connivenza, disumana indifferenza.
Saremo travolti dall’odio
senza un risveglio di pietà,
senza un accendere la luce,
per guardarsi attorno,
vedendo gli affetti che respirano
che sono con noi nei sogni.
Non basta rinviare al giorno,
esso porta tempo e luce
e quanti di energia da spendere,
per fermare l’abisso,
ma vuole che ci sia argine al vuoto,
che l’odio si fermi
e venga sconfitto,
per conservare la capacità di ridere,
per amare e fare e disperdere,
ma vivere,
vivere e far vivere,
amare e insieme vivere.
la riconquista del buio

L’aereo, nella notte, sorvola la penisola arabica. Sotto i deserti, le sabbie fino al mare e poi l’acqua, anch’essa nera. Notte nella notte, nero nel nero, sopra c’è un’immensità di stelle, sotto la dimensione spaurita dell’uomo che cerca il sonno per ritrovare al mattino la luce.
Dopo il Cairo e prima di Abu Dhabi c’è solo il buio. E di nuovo buio sino a Sana’a. Le imperscrutabili ragioni economiche della compagnia aerea tagliano due volte il deserto e il buio che avvolge tutto. Nella sosta forzata all’aeroporto, restare a bordo sarebbe il massimo del confort, ma si deve scendere. C’è un’espressione che mi torna in mente: gli occhi feriti dalla luce, ed è così. Il buio era primordiale, ma dolce e ovattato, induceva la vista di cose senza distanza o il sonno, rispettava la stanchezza. Fuori la luce artificiale, violenta lo sguardo. Lancia sui viaggiatori la plastica dei duty free, degli arredi pieni di arabismi fatti in Cina, ferisce l’occhio e la necessità di quiete. Tornare a bordo, dopo aver capito il proprio nome detto da un altoparlante pieno di consonanti, è una conquista e una liberazione. Poi ancora buio. Ore di volo nella cabina con le sole luci di sicurezza e fuori un tessuto di nero.
Anche la costa è buia.
Il mare sottostante è incessante di moto, ma non si vede e dei pirati non si parla più. Chi si muove nel buio sa cosa deve fare, ha almeno due sensi in più, il primo è la capacità di coordinare ciò che i cinque sensi avvertono, il secondo è leggere il buio come spazio, dargli misura per potersi muovere. Chissà cosa vede e sente un animale notturno. Noi, figli della luce, abbiamo abusato della nostra madre, scordandoci che la notte era anch’essa madre di vita e non solo di riposo e così per noi il buio non ha misura e ciò che non ha limite impaurisce.
Il buio sotto l’aereo dice che qualcosa è accaduto sulla costa, che lo Stato che sorvoliamo ha deciso cose che riguardavano le luci e quindi gli uomini. Mi raccontavano che Massaua era una sorta di territorio libero, ricco di divertimenti poco compatibili con un regime di povertà diffusa, poi c’è stato il taglio netto. Via i giovani, via le attività, via tutto ciò che può nuocere ad una dittatura. Anche il divertimento e il turismo nuoce se fa parlare troppo liberamente.
Il nero della pianura continua verso l’altopiano, si intravvedono luci troppo piccole per dire che c’è vita. Potrebbe essere un fuoco di pastori, un camion nella notte, l’aereo è sceso molto. Poi l’annuncio: siamo su Asmara. L’aereo si abbassa ancora. Dopo le luci sguaiate di Abu Dhabi, quello che ora si vede è piccolissima cosa, sembra una strada di paese quella che riordina la notte, luci di lampione rade, si intuiscono le case, ma non ci sono palazzi alti, mancano le luci rosse di segnalazione. Eppure è una capitale. Scoprirò poi che quella dimensione di case che si estendono senza alterare le dimensioni, induce una quiete, come ci fosse una presa del territorio da parte dell’uomo, ma senza fretta. Intanto è notte fonda, l’aeroporto è illuminato di luci giallo brune, ma sembrano lampade notturne che non devono disturbare il sonno, e fuori, dopo il piazzale dei taxi improbabili, dilaga nuovamente il buio. Nelle notti seguenti ho spesso alzato gli occhi e li ho immersi in uno strepito di stelle. La Rift valley non è distante, e ho pensato: ecco ciò che vedevano gli uomini che ancora non sapevano d’essere tali.
Dell’Eritrea manco da troppo tempo, come dall’Africa.
il kairos, paziente attende

… e poi non è vero che un battito d’ali,
lì, dalle parti dell’Australia,
nel golfo del Leone generi un tornado.
E neppure è vero che questo confuso canto d’uccelli
parli l’unica lingua di chi sa capire.
Ci sono misteriosi segni attorno,
volontà difficili da intendere.
Ma è pur vero che un battito di ciglia riordina il mondo,
e fa risuonare le campane, con un segno nuovo,
e forte,
e caro.
Ma tutto questo è natura,
è scorrere, è disordine apparente,
che accade inatteso nel mistero ordinato dei segni,
e non c’è arroganza nel fluire,
e neppure nella gravità,
per questo se a un desiderio accade d’accadere,
meglio che di volontà propria sia.
E basta.
E nel far di noi bambini nel tempo, attendere,
che riaccada diverso,
se d’accadere avesse ancora voglia.
scorre del buio il ritmo

non si racconta il ritmo della notte, mentre s’inceppa nel respiro scivolato dalle bocche,
non lo narrano le mani e il loro tatto nell’indifferenza inutile d’aprirsi,
non si legge negli occhi che l’anima socchiude in fessure di profondo rettile.
E cosa cercherebbe il nostro sauro mentre la coda interroga l’impalpabile terreno:
qui ci sono lenzuola che s’aggrovigliano e non sabbia di pulsioni.
A chi dovrebbe chiedere ragione l’interiore sguardo, se non alla paura,
l’unico legante che supera le specie,
e s’accomuna nel buio, smisurata e fluida,
nell’imbibire ossa di sicurezze chiare
Fuori, si sente il buio, penetra foglie, pali e fondamenta,
la luce incauta vi aveva costruito il bello,
il quieto,
l’equilibrio indefinito che rassicurava
e che si scomponeva nell’andare.
Ed era ben presente ad ogni passo,
ad ogni sosta,
si ritrovava sicuro nella luce di sé, di noi,
ma non ora.
Nel buio, non c’è ritmo dell’andare
e l’agro dell’insicurezza scioglie il tartaro d’ogni fondamento,
toglie lo scandire dei segmenti,
li trasforma in cerchi di gesso,
vuoti delle parole che si rincorrono eguali.
E non chiede permesso il timore,
educa senz’essere gentile,
insegna la somma precarietà di ciò che a noi assomiglia
ricordando l’impalpabile non essere della solitudine.
E a te, che come un bimbo non sai il risveglio,
che temi la continuità dell’amore.
A te che devi allungare una mano per sentirti esistere,
che scrolli il buio che ti svuota,
e non balli, non scandisci i giorni,
e ti disperi senza le parole esatte dell’alleviare,
dico che non c’è un ritmo nel buio,
non c’è una canzone che non sia l’eco dell’andar via,
l’abbandono del cercare, il caso ilare del trovare.
A te resta il corpo, che si consegna ai piccoli lampi di stanchezza,
la misericordia degli occhi che ora chiudono esausti
a chiamare tregua
e donarti lo sconcluso sonno

colloqui di fine novembre: la vita come opera letteraria
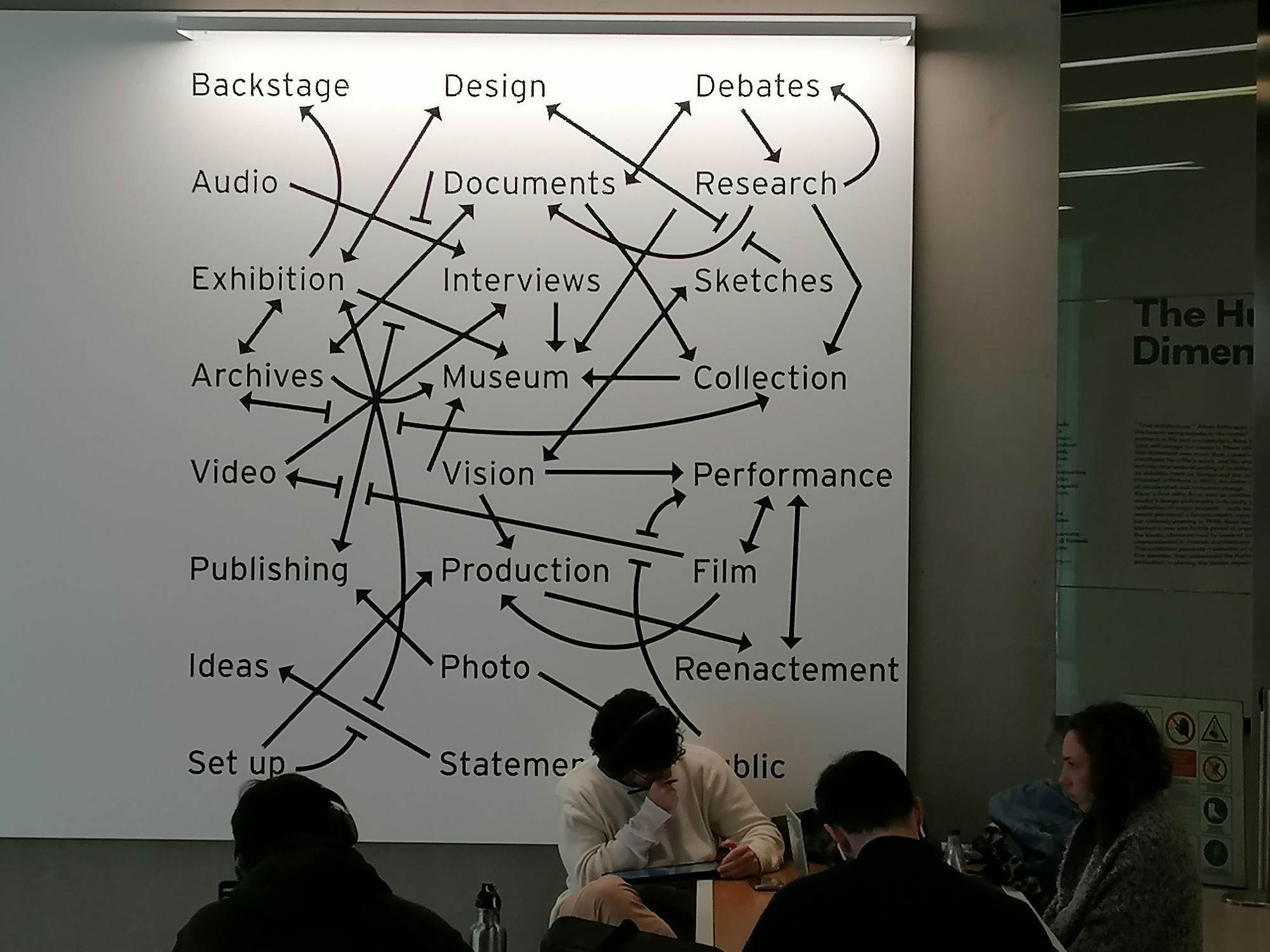













C’è differenza tra vivere e lasciarsi vivere. Lo dici mentre cerchiamo un luogo dove fermarci per uscire dal rumore e dal freddo. La città di mattina si muove a fiotti, come le tue parole, che spiegano, si gonfiano finché parli e sembrano scavare a ondate, con furia che si ferma indecisa e poi riparte. Infatti esiti a volte, usi quelle forme che servono a prendere fiato, i come dire. Mi pare che tu stia cercando più a fondo. Così, mi pare, frasi dubitative… Mi pare.
Si parla e si riflette sul vivere. E si cammina. Sul serio e metaforicamente, dico, che è vero che le nostre vite non sono solo storie. Dopo le leggiamo così. E a volte anche finché sono in corso, quando si deve occultare qualcosa. Relativizzare. Mai nello stesso momento in cui, con precisione millimetrica, ciò che sentiamo accade. Talvolta si immaginano le evoluzioni delle vite, anche un fine , ma appena dopo i fatti. E se si è aperti a ciò che c’accade, la storia va ancor più per suo conto, ne siamo immersi. E’ una strada intrapresa, una direzione da assecondare con lievi movimenti di guida. Un obiettivo intermedio che consegna alla nebbia una destinazione non determinata.
Ti ricordi Ulrich, l’uomo senza qualità? Mi dici. Ad un certo punto, spiega che vorrebbe vivere come un opera letteraria, con una vita che si svolge e si interpreta, senza tempi inutili, per vivere di più? Poi se lo osserviamo, leggendolo, di Ulrich, si colgono le abitudini, l’amante, gli obblighi di un incarico da portare innanzi, molta quotidianità, insomma. Ecco, credo che il pensiero di trasformare la vita in racconto lo facciano tutti quelli che leggono molto. Forse anche quelli che scrivono. Meno i pittori o i fotografi che hanno bisogno del reale per farsene attraversare e sentirlo. Anche chi ama solo il piacere è così. O magari ne dipende solo quando emerge la pulsione e la sua soddisfazione diventa più forte di un fine che la comprenda, e poi tutto torna nei ranghi. I lettori invece, confrontano le storie che leggono con la propria, si riconoscono nelle parole, nelle situazioni, nei personaggi. Cercano la realtà che per loro coincide con la verità. In fondo avere a disposizione tante vite vissute aiuta a verificare la propria. Costruirla. Riconoscerla. L’analista dice che quelli che procedono a questo modo non si vedono sino in fondo, scelgono un modo di interpretarsi e basta.
Adesso si tace, ciascuno per suo conto, la vita attorno è più svelta di noi. Essere seduti fa scendere i pensieri lungo il corpo. Cambio discorso. Hai mai osservato, ti dico, che se guardi una bella donna in piedi lo sguardo e l’attrazione sono rapidi, uno scatto d’occhi e sensazioni. Senti che ti prende e cerchi un senso d’insieme come in una fotografia. Da seduti, la stessa donna diviene più morbida, procede per somma di attrazioni, ti soffermi sul viso, sul corpo, assorbi la bellezza lentamente, aggiungi pennellate, e lasci lavorare i sensi in modo calmo e intenso.
Non abbocchi.
Quando non si sa che fare si accavallano le gambe. Lo faccio con frequenza. Ci sarebbe bisogno di silenzio e invece tutt’attorno ci sono rumori che mostrano le vite altrui. Cose che si muovono o stanno ferme, il fare, le identità, tutte storie che si svolgono per loro conto. Un’immensa biblioteca di caratteri, di segni di cui non resterà traccia comune. La raccolta delle vite avviene in silenzio e si confina in cerchie ristrette. Di parole scambiate e sensazioni che restano, vibrazioni che si disperdono portando altrove energia. Il voler bene resta, ed è la propria storia mescolata per buona parte con la storia di qualcun altro. Abbiamo paura a legarci nel profondo, troppo invasivo, siamo troppo nudi nello stare assieme, non è per questo che attrae il piacere che mette assieme sensazioni che poi si spengono e ricominciano finché si può? Mi chiedo se sia questo il principio di piacere. Intanto hai ripreso a parlare, m’ero distratto un po’ troppo.
L’analista sostiene che vivo in modo letterario. Lo dici guardando le persone attorno, non me. Dice che quando gli racconto qualcosa seguo una trama e questo lo fa sentire in superficie. Credo semplicemente che sia in difficoltà perché le storie raccontate e vissute non lasciano troppi margini. Sono conseguenti, già decrittate, e io ho un rapporto particolare con i ricordi e il presente, questo lo so, ma davvero non saprei come vivere diversamente. Non si può essere diversi da ciò che si è, se ci si racconta la verità. Ossia lo si può essere per costrizione, per convenienza, ma che vite sono in definitiva, vite d’altri vissute nostro tramite.
Magari viviamo tutti in modo letterario, ti dico, o forse chi consideriamo notevole vive così. E magari letterario significa avere un filo, una trama che conduce le cose. E poi non è così per tutti? Conosco così poco degli altri tanto che adesso mi pare di non conoscere nulla di me. Più si procede e meno certezze restano. Vengono a galla le sensazioni, i sentimenti, ci si fa guidare da essi, ma se appena guardiamo sotto si vede che sono ancorati a principi forti che risalgono a chissà chi. Noi ne siamo portatori e in parte sono nostri davvero. Per questo lasciamo che la confusione galleggi, spuma per pelle e cervello per vivere capendoci qualcosa, sotto è tutto così torbido, c’è solo forza che tiene e si confronta. Bisognerebbe dare un nome alla forza per capire qualcosa. Ma dimmi, tu sai perché il piacere non è storia, perché si smarrisce e mal si ricorda? Ecco, vedi, questo ti dà misura della mia confusione. Sul piacere si orientano le vite e io non so capire cosa significhi davvero. Sembra un ornamento di qualcos’altro che avanza con fatica. Si adoperano piacere e felicità come sinonimi, eppure non lo sono, l’uno si può perseguire, l’altra è una condizione che movimenta tutta la persona. Ma entrambi non durano, però significano molto. Forse quel modo letterario di cui parla il tuo analista è la ricerca della felicità sempre e del piacere a volte, e il modo è una direzione verso cui scrivere la propria vita. Come si può. In balia dell’esterno, del caso e dell’interno con le sue forze oscure. Forse una storia è il tentativo di un ordine.
E forse chi non scrive e si affida, cerca le stesse cose. Lo dici guardandomi. Semplicemente spera la felicità e il piacere, ma lascia fare alla volontà che dura un attimo, alla decisione del momento. E’ un altro modo di vivere, con la storia che si scrive da sola. Hai notato quanti forse abbiamo adoperato? Si capisce poco e quel poco sono i comportamenti di tutti. Ci assomigliamo tutti, ma ciascuno vuole le cose in modo differente. Come dici tu, capisco poco anch’io e se mi guardo dentro ancora meno. Vivere letterariamente significherebbe rispettare un teorema, arrivare a una sintesi filosofica. Cose d’altri tempi, ora è tutto relativo, solo noi in fondo non lo siamo.
