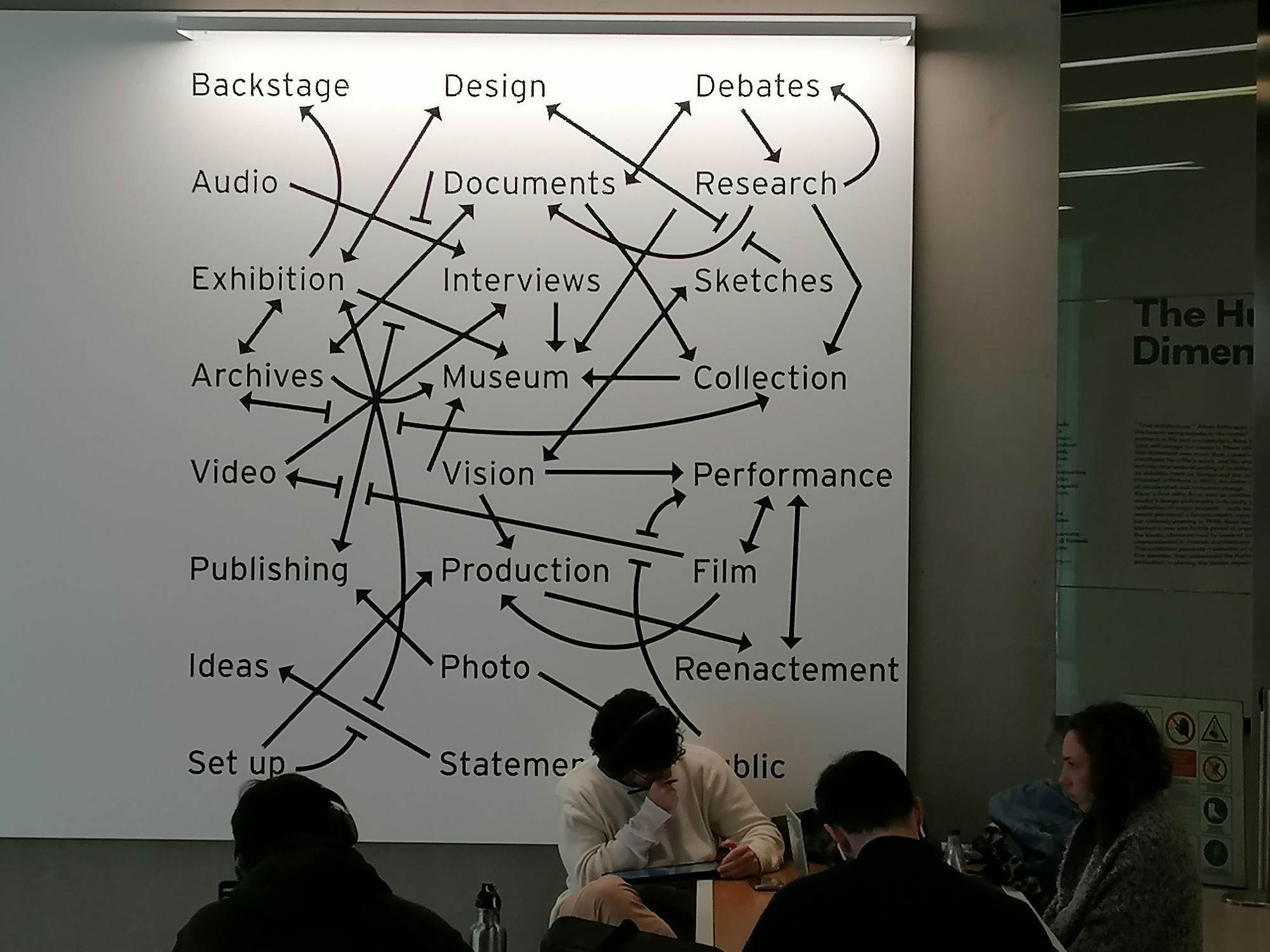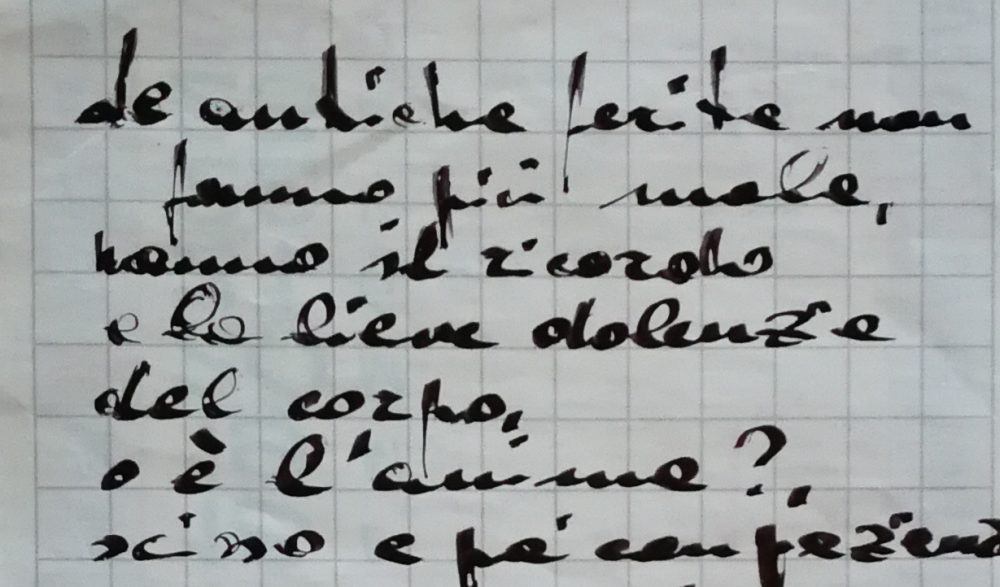Due giorni e le date si sovrapporranno. Neppure il calendario giuliano e quello gregoriano riusciranno a separarle, sicché destini differenti si presteranno a essere letti, per l’ennesima volta, attraverso le celebrazioni o l’indifferenza interiore. Poco conta quello che avviene fuori se esso non risuona dentro, se non trova corrispondenza, se il passato non rende attive due funzioni, quella della riflessione su di sé e quella del capire cosa accade del futuro.
Le celebrazioni sono la sublimazione delle speranze deluse. Il contenitore di ciò che avevamo capito poteva essere diverso e non s’è compiuto. E in ogni non compiersi c’è l’insufficienza della somma delle realtà, il confluire delle forze che piega i rami dell’albero della storia, ma non lo sradica, lo muta alla nostra vista e percezione e quindi in noi. Per questo, e per chi lo sente come evento della storia a cui appartiene, pensare a ciò che avveniva cento e cinque anni fa allo Smolny, a san Pietroburgo, oppure meditare sulla pace apparente del 22 ottobre nella conca di Tolmino, è materia incandescente e viva. È guardare dentro a un vulcano che generò passioni, sentire l’ insieme delle braccia che presero e trascinarono la storia altrove. Nulla nasce in un giorno esatto, persino le nascite degli uomini sono convenzioni legali, ma c’è un momento in cui il presente schiocca le dita e diventa lo scollinare delle forze che hanno creato l’evento, allora dilaga la realtà e coinvolge e travolge.
Allo Smolny, collegio per ragazze d’ottima famiglia, ci sono sale, cucine, letti, stucchi e specchiere. Ottimo luogo contro il freddo che già imbeve strade e barricate, rappresentativo per la presa di potere che passa attraverso milioni di menti e di braccia, che vibra e incalza la certezza di un dopo che s’annuncia definitivo e migliore per l’uomo. A Caporetto, il Kobarid di adesso, l’attesa invece è silente, annoiata dai colpi di artiglieria che sembrano far scena, ma nel fango dell’autunno già urge e si muove attraverso gambe e menti che si chiedono cosa sia la guerra, che speranze essa contenga, per chi e per cosa si corre incontro ad una scheggia, una pallottola e si muore. In entrambi i casi c’è una rotta d’un argine di certezze con qualcuno che irrompe. A San Pietroburgo, chi irrompe è la speranza di un mutamento radicale della condizione dell’uomo, di una pace che sia nascita dell’umanità finalmente libera dal bisogno. A Caporetto trionfa la razionalità, mutata in volontà di strateghi e generali che vogliono chiudere la partita, ristabilire l’antico ordine violato e chiudere da questa fronte una guerra che sta affamando e dissanguando i popoli dell’impero Austro Ungarico e della Germania.
Mancano due giorni a cento cinque anni, e se si leggono le cronache di ciò che avviene nei soviet, di come si dispongono le coscienze, le parole susseguite ai gesti, i toni della voce che già infiammano, e io dove sarei stato, perché questa è la domanda che pone la storia: dove ci saremmo collocati? A Kobarid, intruppato al posto di un nonno, già l’altro era morto due mesi prima poco distante, avrei reagito alle interminabili attese di un massacro che si consumava nelle trincee? Era già successo che ci fossero ribellioni all’insensatezza degli ordini, ai massacri inutili e previsti, le idee socialiste arrivano e raccontavano del rifiuto della guerra. Le scelte che ci mettono in situazioni non vissute sono solo in parte ipotetiche perché sono le nostre vite che testimoniano dove saremmo stati. Quello in cui abbiamo creduto, il nostro leggere la storia che ci colloca da una parte e la rendono cosa viva, fa interrogare non sul dove ma sul quanto faremmo. Ci chiedono dove stiamo adesso e se eccedere nel misurare le speranze deluse, non ci sia la stanchezza degli anni che pongono il tema del fallire. Allora basta ricordare, celebrare per evidenziare la caduta di un sogno, ma non la sua vacuità. E questo basta? A San Pietroburgo s’accendeva una speranza che sovvertiva il mondo, quanto di quella speranza, in altre forme, con altri nomi e parole è ancora presente nel nostro vissuto? Quanto vige la necessità di riconoscere nell’altro diritti eguali, trattamenti dignitosi nel lavoro, opportunità comparabili, vite prive dell’assillo del bisogno materiale? E a Caporetto, in quel disfarsi della grande macelleria degli incapaci al comando e dell’Italia, che trovava se stessa nelle domande, nel perché combattere e per chi, non si faceva forse un’altra Italia che si metteva assieme e rifiutava il prima, ma poi trovava in una linea di difesa i modi per essere finalmente un Paese. Come per il Comunismo bisognerebbe capire quanto c’è di San Pietroburgo nella visione personale del mondo. Per l’idea di essere popolo, sarebbe necessario capire dove sia la Caporetto in noi e come essa generi una linea di consapevolezza dell’essere uniti da un destino comune. I fatti non sono mai definitivi, ma la storia e gli uomini sono costruiti dai fatti, dietro ad essi ci sono le idee, e più in basso c’è quel fondo di identità dove l’io si confonde con il noi. Ci sono i bisogni innati, la giustizia che deriva da un processo naturale e da uno di civiltà, c’è tutto questo che viene riassunto nell’appartenere. A un’idea, a un sogno, a una forza comune che evolve e che diventa più grande.
Umanità è parola femminile e inclusiva, generante storia, feconda e inesauribile. Umanità era quella che assaltava i palazzi del potere, che dilagava e bivaccava tra ori e lussi inenarrabili pensando alla propria fame trasmessa nei secoli. Umanità era quella che si difendeva sino all’ultimo uomo, che veniva vilipesa da chi era incapace di vederla, che tornava verso valle, lacera, dopo aver lasciato amici, affetti profondi a marcire nel fango. Era la stessa umanità che si ricomponeva dinanzi a un pericolo e nuovamente si riconosceva. Non per la patria e per il re ma per le famiglie, per la possibilità di avere un futuro che non fosse di servaggio. A questo servono le ricorrenze, a misurare il fallimento ovvero ciò che manca al successo, a chiedersi dove siamo adesso perché lo sappiamo dove saremmo stati allora. Servono per capire cosa ci sia ancora dentro di noi del futuro che ci attende e di cui il passato è dimostrazione del suo farsi con gli uomini. Non a caso un centenario di come mutò il mondo è stato ridotto a poca cosa, perché ora bisogna togliere le punte acuminate alla storia al fine non rinascano domande; la manipolazione a cui siamo soggetti è questa: non l’esame dei fatti, delle idee, non lo schierarsi per l’una o per l’altra parte, ma l’indifferenza che renda tutto obsoleto, tutto cosabile ovvero ridotto ad avere e non avere. Quando saremo solo cosa, privi di umanità, cesserà la storia. Sarà indifferente e la passione scomparirà dalle vite. Ma sono sicuro che un’idea, una bandiera comune troverà sempre chi la alza e costringe a prendere coscienza, posizione, insomma essere.
Riporto due ignominie di allora, ovvero come l’alto comando italiano di Cadorna cercò di nascondere la propria incapacità e di come, altrettanto maldestramente, il governo Orlando, tentò di correggere. Come a dire che le vite valgono poco solo per chi non vede gli uomini e vale allora come adesso.
Il bollettino censurato su Caporetto:
“La mancata resistenza di riparti della II° Armata vilmente ritiratisi senza combattere, o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso alle forze austro germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire all’avversario di penetrare nel sacro suolo della Patria. La nostra linea si ripiega secondo il piano stabilito. I magazzini ed i depositi dei paesi sgombrati sono stati distrutti. Il valore dimostrato dai nostri soldati in tante memorabili battaglie combattute e vinte durante due anni e mezzo di guerra, dà affidamento al Comando Supremo che anche questa volta l’esercito, al quale sono affidati l’onore e la salvezza del Paese, saprà compiere il suo dovere.”
Orlando comprese che al disastro materiale si sarebbe aggiunto quello morale per l’intero esercito e senza conoscere la verità, ben diversa da quella del bollettino, la stessa sera, fece sequestrare i giornali che riportavano il comunicato Cadorna sostituendoli con nuove edizioni nelle quali il bollettino nella sua prima parte veniva ammorbidito come segue:
“La violenza dell’attacco, la deficiente resistenza di alcuni riparti della II° Armata hanno permesso alle forze austro-ungariche di rompere la nostra ala sinistra del Fronte Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire all’avversario di penetrare il sacro suolo della Patria.”
Circolò anche un’altra stesura, che era nefanda per il morale e all’opposto della verità, apparve nelle edizioni di alcuni giornali della provincia o fu fatta circolare, ciclostilata, o addirittura scritta a mano:
“Per la forte pressione dell’avversario, ma più ancora per l’ignobile tradimento di alcuni riparti della II° Armata e più precisamente delle brigate Roma, Pesaro, Foggia e Elba, il nemico ha potuto invadere il sacro suolo della Patria. Che Dio e la Patria li maledicano e il fango e la vergogna li coprano in eterno”.
Di questo testo misterioso non si conosce la mano, ma di certo era ancora una volta lontano dagli uomini e vicino al potere.