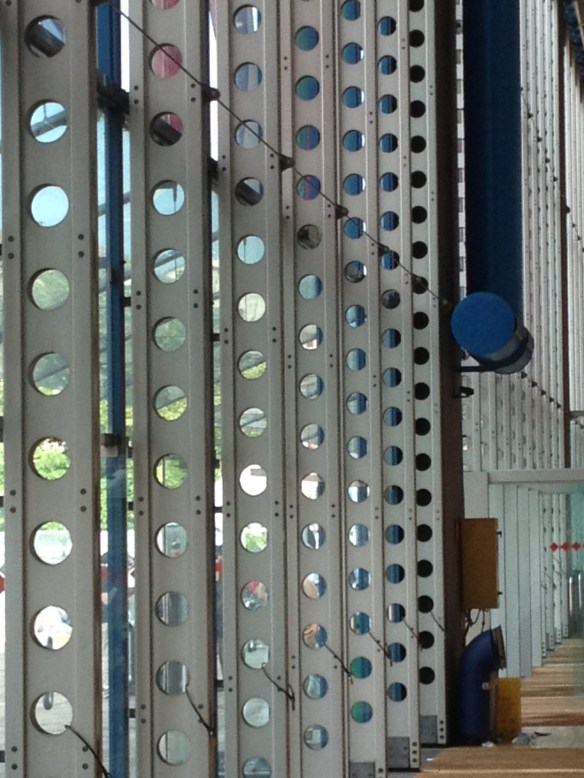Chi era nel seggio della piccola frazione, seggio campione, raccontava il voto e lo scrutinio come cosa epica. Alzava il mento e la schiena nel farlo, poi parlava lasciando angoli di discorso appena accennati, che erano, si capiva, parte di una storia singolare. Un anno in cui c’era particolare animosità e concorrenza, nel seggio, dove tutti si conoscevano fin da ragazzini e ne avevano viste di cotte e di crude assieme senza mai confondersi tra baciapile e mangiapreti, però tutti partecipando della vita degli altri e all’occasione dandosi una mano, tutti, dico tutti, anche il segretario di seggio, che stava zitto perché tartagliava, convennero due cose preventivamente: che le nulle (le schede) erano quelle in cui non si capiva davvero cosa si volesse votare, e che il divieto di bere alcoolici nei seggi, era giusto sì, ma riguardava solo i seggi altrimenti diventava una punizione ingiusta.
Concordato il primo punto, si convenne sul secondo che una fiasca da venti litri fosse a disposizione di elettori e scrutinanti allargati, ovvero scrutatori, rappresentanti di lista, amici nullafacenti, nonché militi che volessero sospendere temporaneamente, a turno, il servizio ed infine il segretario, a cui fu dato compito di predisporre appositi buoni da consegnare alla bisogna assieme al bicchiere, per aver conto dell’effettiva disponibilità di “rosso”. Sul colore del vino si accese una disputa non da poco, che considerava il colore come evocativo d’una parte politica e quindi non nominabile nel seggio. E poiché le domande dei votanti erano specifiche e circostanziate sul tipo, colore, provenienza, decise, com’era giusto fosse, il presidente di seggio, vecchio democristo, nell’ affiancare alla prima, un’altra fiasca di “bianco” e lasciare, oltre alla libertà di voto, faticosamente conquistata, anche la libertà di bere.
A mezzogiorno, un servizio di ristorazione predisposto dalla locale sezione dei rossi, arrivava con un paniere nel seggio, e all’interno, pane, prosciutto, salame, uova sode, focaccia, ben commisurato alla fama di un partito, guidato sì da intellettuali, ma spinto e fatto crescere da operai e quindi abbondante e preventivo per le fatiche che certo sarebbero arrivate, perché l’inazione era fatica più grande del lavoro fisico e le ore di seggio erano tante, e lunghe, e con il pensiero a tutto quello che restava in disparte e si sarebbe dovuto fare nei giorni seguenti lavorando il doppio.
Per non essere da meno, anche il partito bianco portava il suo paniere ben fornito di pane e soppressa, e pure uova, salami e dolci, perché se la politica divideva, le abitudini, il lavoro in fabbrica e nei campi, univa. I socialisti con discrezione, ma senza soggezione, pure avevano un loro paniere, del partito provinciale questo, ed essendo di analoga vita e frequentazione, pur essi mostravano salami, formaggi e sottaceti. Ed era tutto uno scambio, un assaggiare, un mettere in comune, confrontando e sfottendo, ma tutti ridendo. Repubblicani, liberali, e financo il missino, senza salmerie, erano coinvolti e pur neghittosi, a bocca piena, ripetevano sia la bontà del cibo, sia la storia del piatto di lenticchie e che loro non si vendevano per un pane e salame, erano in amicizia, ma il voto poi, e lo scrutinio, erano tutt’altra cosa da questo condividere, da questo clima allegro e fraterno. E tutti a dire che, come poi effettivamente era, che non c’erano cedimenti in questo essere insieme a mangiare, che l’amicizia era un conto e il voto, la politica, un altro, e che no, non si confondeva il dovere con il piacere, tutto era nei limiti e nella moralità dell’agire politico senza tentennamenti.
I più imbarazzati a questi discorsi erano i “rossi”, perché l’idea della rivoluzione non era mai stata abbandonata del tutto; alcuni erano stati partigiani, altri avevano partecipato alle dure lotte in fabbrica, sopportato le discriminazioni, e non si poteva, proprio non si poteva dare tutta la confidenza, per cui era tutto un susseguirsi di battute frenate, di tu e i tuoi, di e che ne dici di…, di ti ricordi di … che neppure attendevano le risposte come definitive, ma erano solo un alleggerire la piccola sensazione di intesa con il “nemico”.
Ma c’era molta creanza, il segretario distribuiva buoni e bicchieri e nelle lunghe ore di ozio si parlava di tutto, del paese, dei figli, delle difficoltà, dei matrimoni giusti e sbagliati, delle nascite in corso, del lavoro che c’era e mancava assieme. C’erano pochi votanti, in quel seggio campione, la frazione era stata importante, ma poi era stata spopolata dall’emigrazione e dalla chiusura della cartiera, lo scrutinio era breve. Nei segni si riconoscevano le mani di chi era entrato riverente e chi spavaldo, di chi voleva sentirsi dire conosciuto e non mostrare il documento (erano tutti conosciuti, ma si diceva ogni volta ed era bello sentirselo dire), delle donne che avrebbero volentieri evitato quella cosa da uomini e delle ragazze che avevano il vestito nuovo e sorridevano molto ed erano più sicure dei ragazzi, dei ragazzi che avevano già le mani grandi dei padri e dei vecchi che si fermavano a parlare e non se ne andavano. Insomma si riconoscevano senza dire, tenendo chiuso nelle teste il segreto del voto e senza dire nulla, al più c’era qualche sorriso scambiato sottecchi tra scrutatore e rappresentante di lista, come a dire: ecco è uno dei nostri. Prima che arrivasse il ’92, chi sapeva di politica era in grado di scrivere i verbali di scrutinio, una settimana prima del voto, sbagliando al più di un voto, e pur se tutti sapevano come sarebbe andata a finire, pure lo scrutinio era atteso, e vissuto, con trepidazione virile, ossia ferma e battagliera.
E dopo aver combattuto su ogni voto possibile, chiusi i verbali, salutati i militi, consumati e bevuti gli ultimi avanzi, chi a piedi, chi in bicicletta, si avviavano verso casa. Era comunque sul fare della sera, per non essere da meno degli altri seggi, e andavano verso una luce gialla, verso le domande curiose di chi era a casa, verso la ripresa della vita conosciuta. Finiva tra i ciao e gli alla prossima, e gli a domenica e i ci vediamo. Finiva, ma non finiva.
Credo di aver sempre saputo perché era davvero un seggio campione.