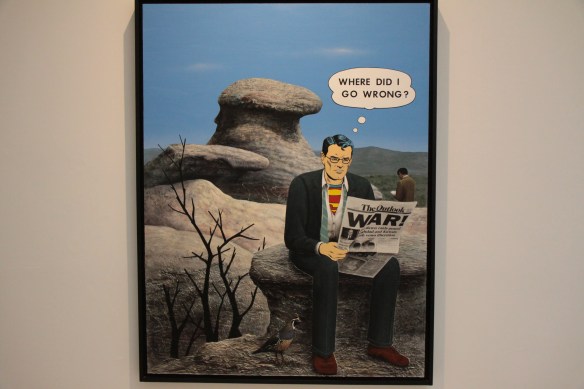Di Aleppo ho un ricordo vivido. Mi sembrava invincibile nel suo essere una stratificazione infinita di umanità senza potere, invincibile come la storia che si legge, si vive, mentre l’altra, quella rombante, si svolge, ma è molto più fragile. Aleppo era solamente bella e così antica da essere intrisa di molte presenze.
Era stata e per questo era viva, non solo ancora viva, ma molto di più: sarebbe rimasta. La città vecchia sotto la cittadella, il suk, l’improvviso risbucare alle stelle dopo le infinite gallerie di botteghe, persone, cose. Il profumo dei fiori, della soda e del sapone, i tappeti che prima di essere colore, sono odore pesante di lana, di mani che hanno annodato, di acqua di torrente che ha lavato. E le lingue che s’intrecciavano, le contrattazioni, il lieve sentore di narghilè, di menta e di mela, i colori dell’oro che ha molti colori oltre al suo, le stoffe impilate in sequenze di sfumature infinite, un asino che attraversava la galleria. E poi, appena fuori, le case, la pietra bianca, il legno, le porte e le finestre istoriate, il sole e il caldo e poi la sera, le luci e il fresco. Ma questo era solo una parte della vita, che si mescolava nei vestiti attillati o nei volti velati delle donne, nella sensazione di identità e tolleranza. Una infinita tolleranza di chi aveva visto infinite guerre e passaggi e poteri che si erano sgretolati, ma avevano rispettato la città, la sua identità, il suo essere tutte le comunità che assieme l’abitavano. Fuori questo si vedeva per consapevolezza e nell’essenza di un commercio levantino che non conosceva religioni e appartenenze, dove il cristiano, il musulmano, l’ebreo, si mescolavano, uniti e differenti.
Appena arrivati in Syria avevo chiesto ad Hassan, la guida che era anche un Imam, di parlare di quanto stava già avvenendo. Era stato evasivo, parlava di torti bilanciati, di propaganda, di un’impotenza della forza a rispondere se non con la forza, ma ad Aleppo si era lasciato andare di più, parlando di malessere, di paura, di preoccupazione per i tempi che sarebbero venuti. Neppure lui, che pure viveva, frequentava chi poteva sapere, immaginava ciò che sarebbe venuto. Da casa, nei mesi successivi, ho conservato quel pensiero che non tutta la verità veniva dai giornali, che non si capiva bene quali erano le richieste, le forze in campo, e pur nella sofferenza che comporta sapere che chi hai conosciuto è in difficoltà, il pensiero era che si sarebbe risolto.
Mai avrei pensato che Aleppo o Damasco o Bosra, o nuovamente Hama, o addirittura Palmira, sarebbero state bombardate, che le distruzioni si sarebbero portate nei patrimoni mondiali dell’umanità, che nulla avrebbe avuto tutela. Ma se parlo dei luoghi è perché penso che essi contengono le persone, che un luogo, un monumento, senza uomini o memoria è nulla, non ha valore in sé. Poi sono venute le notizie, le fotografie, i filmati raccapriccianti e man mano, fuori, è sceso l’interesse, diventava consuetudine, normalità.
I potenti non pensano che il problema debba essere risolto facendo tacere le armi e la vittoria (di chi? per chi?) è stata affidata solo ad esse. Oggi solo i morti, se sono molti, fanno notizia per un giorno, a volte anche meno di qualche ora, ma il resto, cioè quello che dovrebbe provocare l’interesse, la condivisione, la pace, scompare con la notizia.
Il mio pensiero, in questi giorni pieni di colore, di felicità fuggevoli, di parole infinite su un futuro che mai come ora deve tornare nelle mani degli uomini, va a chi soffre in Syria, a quelli che si sentivano sicuri nelle loro case ed ora sono nell’arbitrio, a quelli che ogni giorno vivono perché vivere è più importante e piangono le persone, l’identità, che si smarrisce, ad Hassan e a tutti quelli come lui che mi hanno parlato di pace e di tolleranza, agli abitanti delle città e a quelli che nella campagna non sanno cosa stia accadendo, ma lo vivono con paura e senza speranza. Vorrei che in questa fine d’anno iniziasse, per me, il ricordo che non sono solo per me stesso a questo mondo, che tutto mi riguarda, che se devo attenuare per vivere qui e dove sono, ciò che di atroce avviene in continuazione nei posti più disparati, questo comunque accade e il migliore dei mondi possibili devo (dobbiamo), portarlo fuori da me.
Queste righe sono di Hassan che fa gli auguri qualche giorno fa. Lui fa gli auguri a noi!
Ecco forse il significato di farsi gli auguri è condividere, mettere assieme il legame, ed allora abbiamo bisogno di farci gli auguri tutto l’anno.
ricordo spesso specialmente l’ultima sera ad Aleppo in quel caffe’ a fumare, chissa’ se riusciremo a ripetere quei fantastici viaggi. purtroppo quel caffe’ con una buona parte del suk non c’e’ piu’ solo disastro e cenere, cosi’ come molti siti villaggi e citta’ della Siria, Bosra…………………. ogni volta che ci penso mi metto a piangere, mi dispiace dirlo ma le notizie che vi giungono sono solo una piccola parte, la realtà è molto più terrificante.
Grazie al Signore che noi stiamo abbastanza bene e riusciamo ANCORA a trovare qualcosa da mangiare.
auguro a te e tutti gli amici un felice Natale e che il nuovo anno porti amore e pace a tutto il mondo
carissimi saluti dal profondo del mio cuore
Hassan