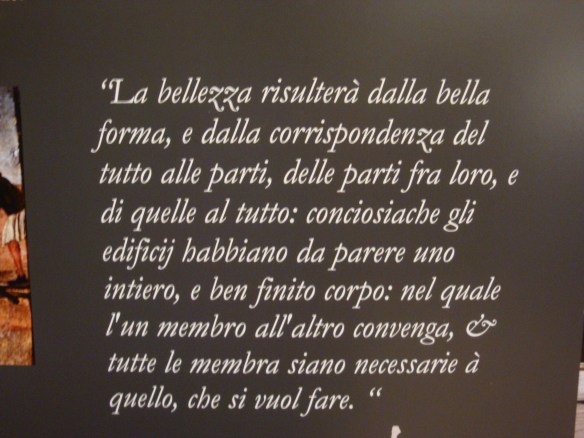Salendo verso i viali di villa Celimontana, i marmi slabbrati, gli immensi cumoli di laterizi, che sin dall’epoca imperiale hanno fatto sfogare la mania di costruire ville, case, mausolei, templi e poi chiese, palazzi di cardinali e di nipoti di papi, circhi e mercati e acquedotti e fontane e di nuovo chiese e case, sono meno invadenti. Accompagnano.
Nella villa ha sede la Società geografica italiana, dalla balconata si vedono giardini, la fontana con un Nettuno ironico per la mancanza di zampillo, ma soprattutto il cielo. Il cielo di Roma ha un’ampiezza particolare, è grande. Come se la città si rovesciasse verso l’alto, ma solo nel contenuto dei desideri degli uomini, mentre i palazzi, le chiese, le case e le strade stessero a guardare, apprensive di quella libertà e continuassero a richiamare quei bimbi riottosi, scendi, scendii, per ricongiungere il vivere, adesso sospeso in aria. I desideri si fanno nubi e cielo e, a volte, piovono sugli uomini, nascondono il sole, rendono l’aria spessa, ma oggi il cielo ha una dimensione così ampia che s’allarga ancora a contenere nubi possenti. Leggerezza e mutevolezza dei contorni spinti dal vento, sembrano suggerire l’essenza del vivere, a noi, che c’accontentiamo di guardare prima d’essere.
I pini seguono i viali del giardino, si spargono e coprono d’ombra, erba e panchine, e ghiaino. Poco prima, davanti alla basilica dei santi Giovanni e Paolo, un matrimonio affollava la piazzetta. Per il colore degli abiti, per le mise un po’ sopra tono, per il formarsi indeciso dei gruppi, per l’attesa d’entrare, per la chiesa equamente spartita tra i sodali della sposa a sinistra e quelli dello sposo a destra, i viali di villa Celimontana sarebbero stati, invece, la cornice ideale. Con i bambini vestiti di bianco ad additare, ridendo, i papagallini verdi persi tra i rami e poi subito a correre tra i pini, con le donne colorate a far capannelli da sciogliere e riformare, nei gorghi di parole, e risate e commenti a mezza voce, con gli uomini in disparte, a commentare e fumare. Sciami che si separano e riformano come gli storni che si muovono sopra la città e di colpo scendono, si posano, liberando il cielo e riempiendo i lecci, di corpi leggeri, di frastuono di voci, di sterco. E poi nuovamente s’alzano alla prima minaccia o voglia, per riformare la nube, e disegnano figure in cielo e, pur bassi rispetto alle nubi vere, affascinano ed attirano sguardi e commenti di uomini che vanno. Vanno verso treni, case, alberghi e non par loro vero, d’occuparsi d’altro che li tolga dall’utilità che li accompagna e pesa. Così all’infinito.
La città si merita tutto questo, è stata accumulata di presenze, è stata risuonata di voci, canti, spazi e sfottò. E’ stata riempita di templi, vuotata di dei, ripopolata di chiese, acquedotti, potenza, rovina, indifferenza, case e bisogni. Perché non dovrebbe meritarsi di essere un luogo in cui l’essere assieme è libertà, fatto vitale e non occasione? Cos’ha in meno delle città, altrimenti antiche, che ribollono d’umanità, in Africa ed oriente, che si punteggiano di caffè, case e giardini, miserie e ricchezze riempite di uomini che non le hanno costruite? Quello che mi fa accettare Roma, per me provinciale, non è la cristianità e il divino spalmati sulla città, ma l’arroganza di chi, indefessamente, ha costruito per magnificare sé attraverso la divinità, ostentando un’umiltà che non esisteva.
A fianco della basilica dei santi Giovanni e Paolo, ci sono le parti del tempio di Claudio al Celio. Su queste e su una villa è stata costruita la chiesa, e poi case, e sopra ancora una casa e un campanile. E quelle vecchie colonne, e pilastri, e travi, messe per altri dei, sono state chiamate a sopportare il peso di tutto questo nuovo credere e sapere, che dilagava nella città. In una nuova funzione, in un riciclo dove il credere si sposta, ma resta come bisogno da soddisfare, guidare, accogliere. Non per tutti, ma resta.
Nessuno degli invitati sembra interessato all’androne galleria che si apre a fianco del campanile e mostra i resti del tempio, neppure al busto di un prelato, posto su una colonnina a prestito sono interessati. Anzi un’auto gli era stata parcheggiata davanti, cosicchè il prelato guarda il retro della macchina. La pietra non si sconsola, e neppure il prelato, solo gli uomini, a volte, pensano che ci sia un posto, e un luogo, per tutto e non la confusione che mescola persone, effigi, funzioni, passato ed attesa di felicità future. Tutto buttato in un melting pot, una pentola ribollente, dove il momento si scioglie senza traccia, neppure quello che si celebra, dura, e tutto confluisce in un brodo che fa dire: è stata una bella giornata, hai visto chi c’era, era buono, stavo bene, il più bel giorno della mia vita, bella cerimonia, che stanchezza. Voci e pensieri che si sovrappongono e si confondono in un brontolio di presente scontato, dove si sa quasi tutto. Per questo mi sarebbe piaciuto vederli nei viali di villa Celimontana, con i vestiti corallo, grigi, rossi, bianchi e tutti i colori che queste occasioni richiedono quando si deve essere un po’ più di quello che si è. Ed è una spesa che deve trovare soddisfazione. Ma l’occhio attento guarda il colore delle scarpe, si accorge del risparmio, giudica l’altezza del tacco e l’abbinamento della sciarpa e poi scivola sugli uomini e coglie l’abbinamento camicia, cravatta, giacca, si accorge del tamarro in agguato ed allora sorveglierà il tono della voce, guarderà ancora, ma con tenerezza, come si dispongono in chiesa. E si allungherà per cogliere il commento per la disposizione sui banchi infiorati di bianco, con i cuscini bianchi e il sacrestano, pure vestito di bianco, finché si fermerà, convinto, che l’aria e i pini sarebbero stati il posto migliore.
Ma perché siete venuti in questa chiesa, non è neppure bella, l’hanno rifatta e ancora rifatta, la parte migliore è fuori e vi avete parcheggiato le macchine.
Il cielo è azzurro, c’è aria calda, ma all’ombra rinfresca. Sotto i pini di villa Celimontana corrono cani e bambini, qualcuno si stende sull’erba, la fontanella butta acqua. Se si chiude la bocca del leone che fa da cannella, si beve acqua fresca, dallo zampillo del naso.
E’ caldo e fresco, come dentro la palazzina della Società geografica, dove s’ annidano carte ed esploratori italiani, qualche storia d’amore africana, passaggi in Asia e nelle Americhe. Hanno camminato, scritto, imparato, tracciato mappe, raccontato e sono tornati.
Fuori è pomeriggio , il sole splende sopra i pini, la città vortica. Più sotto il matrimonio procede. Le voci sono una sensazione, un flusso. Solo gli uomini accumulano anche ciò che non è stato.