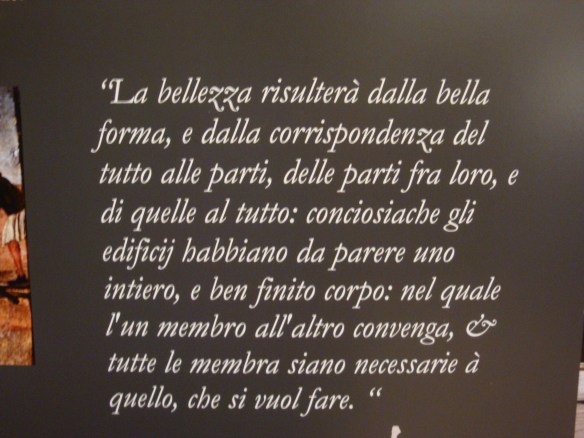Sebastiano Venier e gli impiccati prima della battaglia di Lepanto, don Giovanni Tenorio e la cena con il Commendatore, l’hidalgo Gonzalo Pirobutirro e la Cognizione del Dolore, cosa li mette assieme ?
Nulla, apparentemente nulla, se non la natura dell’ hidalgo, con l’orgoglio, il dolore e la fascinazione che si porta appresso e lo ripiega nella sua cognizione. Fossero solo le donne, oppure il comando, oppure, ancora, l’inerpicarsi verso un cielo che non è mai troppo basso, questo sarebbe l’effetto, non la causa dell’essere ciò che si è.
Il perseguire che segue sé, è destino dell’hidalgo. A partire da quel don Quixote, primo persecutore della sua pazzia, malamente riscattata, e non ce n’era alcun bisogno, da quella fine di ravvedimento d’intelletto. Che mai per alcun motivo dovrebbe seguire l’hidalgo, perché nulla dev’essere nascosto all’orgoglio e nulla, compreso l’immolarsi alla propria idea, dev’essere posto da parte. Pazzia compresa. La fascinazione fa parte dell’hidalgo, sia essa esercitata nel comando o altrove. E il Cervantes certo seppe, lui c’era, di Sebastiano Venier, che il giorno prima della battaglia di Lepanto, impiccò un hidalgo e fece frustare due aspiranti tali, per aver dileggiato e ferito due ufficiali veneziani. Lo fece sulla sua ammiraglia (torna la casa come luogo dell’epilogo dell’hidalgo), come capitano da mar e comandante della flotta che il giorno seguente affrontava il turco, lo fece sapendo che don Giovanni d’Austria, comandante generale designato da Filippo II, hidalgo degli hidalgos, per questo poteva metterlo a morte. Lo fece perché era giusto fosse così ed in questo, egli con l’esercizio del potere, divenne più hidalgo dello spagnolo.
Analogamente don Giovanni Tenorio non si ritrae dal confronto con colui che ha ucciso, con ciò che è oltre la vita ed esercita la fascinazione su di sé, il posso farlo a dispetto di tutto e tutti che è ancora una volta il conformarsi al destino proprio. E qui viene il ripiegamento su di sé, la melancolia di don Gonzalo a cui le donne fanno ombra, il cui piegarsi come armadillo è forza da esercitare per mantenere un destino più alto. Ciò che ha avvinto vite, la sua, quella della madre, quella del fratello morto in guerra, quella del luogo, della villa e del suo contorno dilaniante di banalità, per lui ingegnere, con l’anima altrove, è dolore. E su chi può esercitare un fascino degno, se non su di sé, sul dolore che emana la consapevolezza, sul dolore del vivere? La sua vita di hidalgo riallaccia, con il filo del dolore, le molte vite degli altrettanti hidalgos. Il dolore celato che unisce la passione al proprio destino, un filo su carne viva, da scordare con ciò che si ha a disposizione, sia esso il piacere, la battaglia, la pazzia.
La fascinazione è poca cosa se disgiunta dal sentire.
«… Ma se le ripeto che c’è la mia Pina… sì, sì… la Giuseppina… Lei la conosce, no?… ma se le ha parlato tante volte!…». Il figlio Pirobutirro ebbe l’aria di navigar nel vago: confondeva facilmente le Giovanne con le Giuseppine, e anche con le Teresine: ma più che tutto, a terrorizzarlo, era l’insalata delle Marie e Marie proclitiche, cioè le Mary, le May, le Marie Pie, le Anne Marie, le Marise, le Luise Marie e le Marie Terese, tanto più quando le riscopriva sorelle, a cinque a cinque, da doverle discriminare lì per lì nella baraonda dei rinfreschi, dopo schematiche presentazioni. «… Insomma, le dico che non importa», continuò il dottore; «lei starà seduto come un papa; davanti, magari, dove ha meno scosse… a guardare il paesaggio… ad assaporarlo in tutta la sua dolcezza… E la Pina guiderà. Non si fida della mia Pina?».
O! certo! Egli si fidava pienamente della «signorina Giuseppina», (Quell’astrazione onomàstica non gli dava modo di raccapezzarsi). Ringraziò nuovamente; calorosamente. «… Ma non è possibile…». Emise un sospiro. Era molto preoccupato. Quasi seccato. Fu molto cortese. Un senso di noia, di irritazione era nel suo sangue: un’ansia indicibile sul giro del gàstrico, dov’è il duodeno, come piombo: una figurazione di colpa, di inadempienza, nel suo contegno. Nel suo occhio oramai stanco, velato, si adunarono cose dolorose, lontane. Troppo lontane da quel discorso.
…
«Era il male oscuro di cui le storie e le leggi e le universe discipline delle gran cattedre persistono a dover ignorare la causa, i modi: e lo si porta dentro di sé per tutto il fulgurato scoscendere d’una vita, più greve ogni giorno, immedicato»
(Da La cognizione del dolore, Carlo Emilio Gadda)